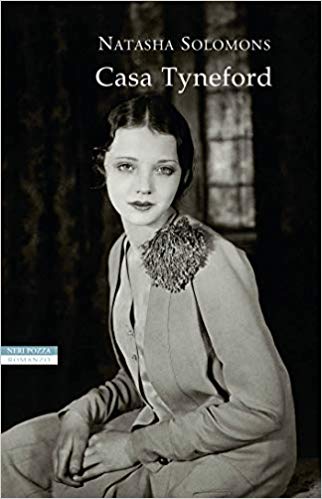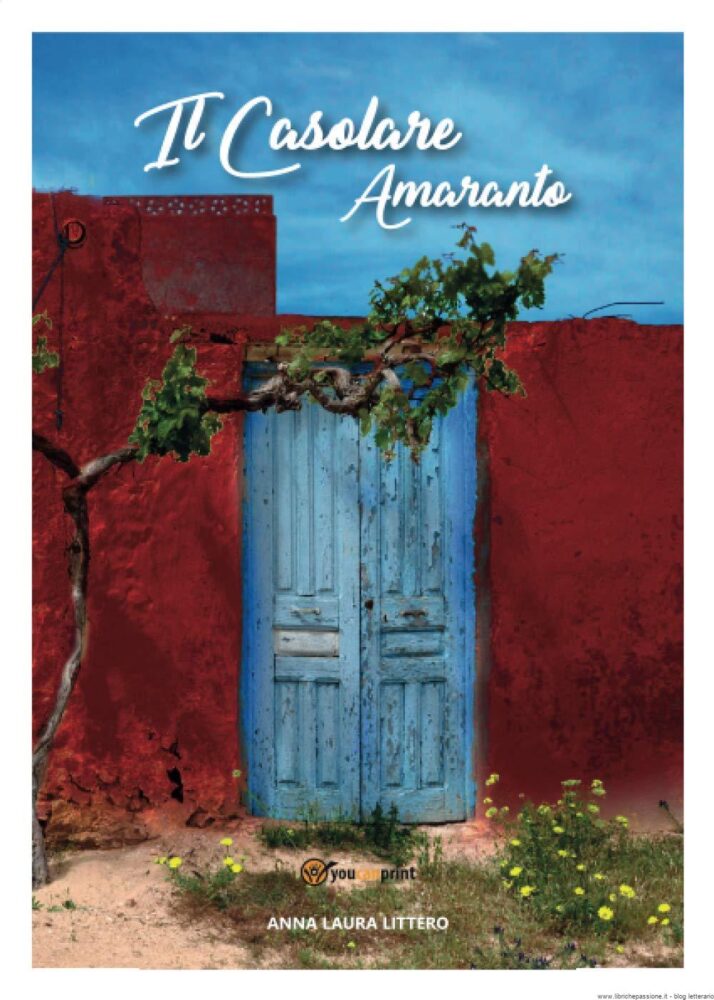Trama
Vincitore Premio Campiello 2019
«Tarabbia si avvicina a un fatto attirato da un richiamo morale, e lo usa per indagare − senza alcunché di morboso, miracolo − il Male nella e della Storia attraverso la scrittura, in una tradizione che va dai Demoni di Dostoevskij fino a Carrère o Vollmann.»
Il Sole 24Ore – Marco Rossari
«Tarabbia non dà risposte. Forse perché, come tutti, non le possiede. Forse perché il compito della letteratura − e dei bravi scrittori − non è quello di dispensare certezze ma di instillare dubbi e suscitare quesiti. Di spronare alla riflessione, sempre.»
Nazione Indiana – Antonella Falco
«Solo la fragilità e il dolore, presi per mano dall’amore ci portano nel punto più profondo del mondo.»
Corriere della Sera – Alessandro D’Avenia
Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni del suo tempo. Da lì scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico.
Gesualdo da Venosa, il celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, è il centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito?
Per vendicare l’onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D’Avalos, dopo averla sposata con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto.
Questa storia − è ciò che il lettore scopre sbalordito − ci parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio.
Con un gioco colto e irresistibile, tra manoscritti ritrovati e chiose di Igor’ Stravinskij − che nel Novecento riscoprì e rilanciò il genio di Gesualdo − Andrea Tarabbia, scrittore tra i migliori della sua generazione, costruisce un romanzo importante, destinato a restare.
L’edificio che attraverso Madrigale senza suono Tarabbia innalza è una cattedrale gotica da cui scaturisce la potenza misteriosa della musica. È impossibile, per il lettore, non spingere il portale. E, una volta entrato, non restarne intrappolato.
Estratto
A Laura e Lorenzo
«FIGLIO: “Mamma si muore nella notte o nell’alba?”
MADRE: “Nella notte o nell’alba, figlio,
secondo che noi avremo vissuto nella notte o nell’alba”»
Giovanni Testori, La Morte
«Ogni uomo […] per un istante è Dio. Dio davvero, non a parole. Poi ricade».
Nikos Kazantzakis, La seconda crocifissione di Cristo
«Certo che Lucifero aveva musica».
Igor’ Stravinskij, Ricordi e commenti
Igor tentato dal demonio
Una lettera
Al professor Glenn E. Watkins,
une College of Arts & Sciences
Department of Music
CB# 3320; Hill Hall
Chapel Hill, NC 27599-3320
USA
Los Angeles, gennaio 1960
Caro signore,
mi perdonerà se comincio con una scimmia, ma è da molte ore che sto seduto al tavolo con l’intento di scriverle e ogni tentativo, finora, è andato fallito. Accumulo incipit e cartacce, come se non riuscissi a trovare un modo per iniziare davvero. Ho da raccontarle alcune cose piuttosto stravaganti che mi sono capitate negli ultimi tempi e che, forse, desteranno il suo interesse o almeno la sua curiosità. Non si faccia l’idea che mi siano capitati avvenimenti molto strabilianti: tutto è sempre dentro un ordine che definirei quasi naturale. Ci sono con me Vera, qualche domestico e Ol’ga, un’infermiera di lontane origini ucraine – tanto lontane che quasi non mi capisce se mi rivolgo a lei in russo. Si occupa della mia salute, il che vuol dire che, quando sono in casa, mi costringe a prendere delle medicine e, se sono chiuso nel mio studio da troppe ore, si sente libera di impormi dei momenti di riposo. Ha un marito
messicano che, una volta la settimana, sistema il nostro giardino, e con cui parla un curioso miscuglio di spagnolo e inglese, interrotto da alcune espressioni odessite che non sono sicuro l’uomo comprenda fino in fondo.
Ieri pomeriggio, domenica, ero in una di quelle mezz’ore che, come le dicevo, Ol’ga mi impone, e stavo affacciato alla finestra dello studio: da lì (da qui, perché è qui che mi trovo ora mentre provo a scriverle questa strana e lunga lettera) si domina tutto il giardino, che a dire il vero non è molto grande, ma contiene una veranda dove d’estate trascorriamo le ore meno calde e una piccola piscina. Quando ci siamo trasferiti qui, ormai quasi vent’anni fa, vi ho fatto trasportare i pianoforti, altri strumenti che mi servono per il mio lavoro, gli spartiti, le carte da musica, il divano per il mio riposo e qualche libro che sono riuscito a farmi spedire dall’Europa. I domestici e Ol’ga la chiamano la «stanza della musica», e vedo nei loro volti un certo stupore ogni volta che, dopo aver trascorso un certo numero di ore chiuso qui dentro senza che un suono provenga da nessuno strumento, io scendo nella sala da pranzo stanco per il lavoro.
Bene, questa è la mia casa: ma vengo alla scimmia e al nostro strano incontro. Le dicevo che mi stavo riposando affacciato alla finestra: proprio vicino all’acqua della piscina, mi sembrò a un certo punto di veder passare un essere non più alto di un bambino di due anni, ma molto più goffo nei movimenti. Era scuro, curvo, e smusava e annusava l’aria: si guardava attorno come se si fosse perduto. Mi alzai dalla sedia e mi avvicinai al balcone, tenendo il vetro ben chiuso, per osservarlo meglio. Era, come avremmo scoperto di lì a poco, un esemplare adulto di cercopiteco barbuto, una scimmia dunque abbastanza comune e, come ci dissero poi, piuttosto mansueta. Ma ora, mentre la osservavo, infilava una mano nell’acqua clorata della piscina e se la portava alla bocca, come per dissetarsi, e continuava a muovere la testa a destra e a sinistra, irrequieta. Stava accovacciata sul bordo, forse chiedendosi dove fosse capitata, finché mi vide: sollevò lo sguardo come se qualcosa l’avesse attratta o spaventata – ma non un rumore, non un movimento era venuto dalla mia stanza. Ci guardammo per alcuni istanti: le confesso, amico mio, che per qualche motivo che non so spiegare, cominciai a sentirmi inquieto anch’io. Hanno, queste piccole scimmie, un folto anello di barba bianca che, quando assumono certe posizioni sotto certa luce, conferisce loro un’aria autorevole. Sono dei Rimskij-Korsakov del mondo animale. Ci valutammo per un po’ attraverso lo schermo della finestra. Presto capii perché la scimmia si era improvvisamente voltata a guardare verso la casa: Ol’ga, urlando, saliva le scale ed entrava, senza bussare, nello studio.
«Una scimmia, Maestro, una scimmia nella piscina!» diceva in inglese.
Si avvicinò al telefono, prese l’elenco, lo consultò e compose un numero. Parlò per alcuni minuti nella cornetta, senza che potessi afferrare appieno il contenuto della comunicazione: capii però bene quando fornì il mio nome e l’indirizzo.
«Con chi era al telefono, Ol’ga?» domandai quando ebbe riattaccato.
«Con l’Ente per la protezione degli animali» disse, ma il suo sguardo fu attratto da qualcosa che accadeva fuori dalla finestra. «Sta venendo qui» disse, portandosi una mano alla bocca.
La mia piccola Rimskij-Korsakov, attirata anziché spaventata da quel trambusto, si era aggrappata a un piccolo rampicante che, dal giardino, sale fino al tetto passando per il balcone. Né io né Ol’ga vedevamo l’animale: ma la pianta si agitava nervosamente. Fu presto sulla balaustra, e io mi voltai verso Ol’ga.
«Le pentole» disse lei. «Corro giù a prendere le pentole». Usò, per «pentole», la parola russa: come le ho accennato, il suo vocabolario non è ricco, in quella lingua, ma annovera moltissimi termini che hanno a che vedere con l’ambito domestico. Risalì insieme a un cameriere (Vera era fuori città), e a due o tre tegami di grosse dimensioni e un paio di cucchiai di legno. Si avvicinarono alla finestra e cominciarono a battere furiosamente le pentole.
«Che cosa state facendo?» urlai nel rumore.
«La signorina della Protezione animali ha detto di fare così, intanto che aspettiamo» rispose Ol’ga. «La tiene lontana».
La scimmia si guardò attorno sbalordita, quindi si riaggrappò al rampicante e ridiscese velocemente verso il giardino. Lo attraversò correndo sulle quattro zampe, e si rifugiò sopra un albero vicino alla staccionata. Ol’ga e il domestico, intanto, avevano smesso di battere le pentole e restavano in silenzio al mio fianco, cercando di capire su quale ramo si fosse rifugiato il cercopiteco. Aprii la finestra e uscii sul balcone. Sono convinto che io e la scimmia ci guardammo ancora per qualche tempo, perché mi sembrava di individuare due piccoli occhi arancione scuro tra le fronde dell’albero. Ma poi intervenne il verso rauco di una ghiandaia e la mia piccola amica si spaventò definitivamente, perché la vedemmo lanciarsi oltre il muro e scomparire nella strada. Non ho più avuto notizie di lei, né dalle radio locali né dalla Protezione animali, a cui ho fatto telefonare ieri sera e stamattina. Sembra quasi che nessuna scimmia sia fuggita da uno zoo. È anche possibile che l’animale appartenga a qualcuno dei miei vicini di casa: questa è Los Angeles, dopotutto, e non ci sarebbe nulla di strano.
Ma alcuni mesi fa, è questa la cosa curiosa, la polizia citofonò a casa chiedendo se poteva perlustrare il giardino. Alla sua richiesta di spiegazioni, Vera si sentì rispondere che stavano battendo il quartiere alla ricerca di una foca evasa da uno zoo, o forse da un circo acquatico – non ricordava bene.
«Una foca, capisci?» mi disse Vera quando mi raccontò l’accaduto. «La polizia! Cercavano una foca nelle ville di Wetherly Drive. Come se una foca potesse davvero scappare, magari attraversando il Sunset Boulevard».
Non credo che una foca mi avrebbe messo in allarme: avrei trovato tutto molto divertente, anche se sospetto che, tra una foca e una scimmia, la meno socievole sia la prima. Siamo circondati da animali, da forme primitive: questo è un fatto. Ol’ga, la buona Ol’ga, questa mattina sosteneva, se ho ben capito, che queste intrusioni sono tutti segni, cose che io dovrei in qualche modo interpretare e mettere nelle mie composizioni. Non è escluso che lo farò, ma per il momento mi diverte stare ad ascoltare questa donna, la cui religiosità è un misto di ortodossia imparata dai parenti e mai praticata, cattolicesimo acquisito col matrimonio e paganesimo innato.
L’episodio della foca è piuttosto buffo, ma non l’ho vissuto perché in quei giorni mi trovavo in Italia in compagnia di Bob Craft. Il nostro viaggio aveva uno scopo preciso, che spero si chiarirà nel corso di queste pagine.
Già tre anni fa, sempre in sua compagnia, mi ero recato in un piccolo paese arroccato nella provincia di Avellino, che si trova a qualche ora di viaggio da Napoli, in una zona rurale piuttosto selvaggia e di un certo fascino: l’Irpinia. Credo che lei conosca bene questi luoghi e il paese a cui mi riferisco, Gesualdo. Avrà così intuito il motivo di questa lettera e del misterioso pacco che vi allego. Ma porti per favore un po’ di pazienza e mi lasci raccontare. Non mi soffermerò a lungo sulla mia visita gesualdina del ’56 ma, prima che lei apra il pacco, le devo dare qualche notizia sul viaggio che ho fatto qualche tempo fa in quella città e, soprattutto, a Napoli.
Come forse sa, nel mese di settembre del ’56 andò in scena nella Basilica di San Marco, a Venezia, il mio «Canticum Sacrum», di cui qualcuno ha scritto, evidentemente senza conoscere ciò di cui parlava, che fu un «assassinio nella cattedrale». Contesto non tanto il concetto di assassinio, quanto lo stato in luogo: il mio cantico non era nella cattedrale; esso era la cattedrale. Non le so nemmeno dire quanto a lungo ho studiato la storia del progetto e dell’edificazione di quel prodigio dell’architettura veneziana prima di scrivere una sola nota sul pentagramma.
Alcuni mesi prima, per mano di Craft ricevetti, in fotocopia, un’edizione del secondo libro di canti sacri di Gesualdo da Venosa. Le fotocopie erano incomplete: mancavano forse alcuni componimenti e alcuni passi di tre mottetti. Da qualche anno il lavoro di Gesualdo aveva cominciato a interessarmi, così in quei giorni, nel tempo libero, mi misi a leggere quella musica. È inutile che la descriva a lei, così come è inutile che spenda parole per raccontarle l’effetto che produsse su di me…
Andrea Tarabbia è nato a Saronno nel 1978. Ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi La calligrafia come arte della guerra (2010), Il demone a Beslan (2011), Il giardino delle mosche (2015; Premio Selezione Campiello 2016 e Premio Manzoni Romanzo Storico 2016) e il saggio narrativo Il peso del legno (2018). Nel 2012 ha curato e tradotto Diavoleide di Michail Bulgakov. Madrigale senza suono è il suo primo romanzo per Bollati Boringhieri. Vive a Bologna.

Jenny