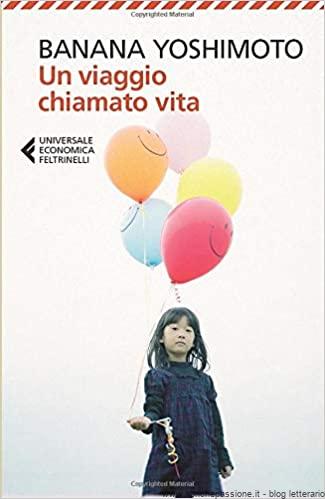Trama
Il libro da cui è tratto il film omonimo con Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson.
Bryan Stevenson era un giovane avvocato da poco laureatosi a Harvard quando decise di trasferirsi a Montgomery, in Alabama, e fondare la Equal Justice Initiative, un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata a porre fine all’incarcerazione di massa e alle pene estreme, a sfidare l’ingiustizia razziale ed economica e a proteggere i diritti umani fondamentali delle persone più deboli e vulnerabili. Al resoconto della sua formazione Stevenson intreccia le storie delle persone che ha difeso e che lo hanno condotto in un groviglio di cospirazioni, macchinazioni politiche, inganni legali e razzismo diffuso, modificando profondamente la sua concezione della giustizia. Tra i vari casi spicca quello di Walter McMillian, un afroamericano condannato a morte per l’omicidio di una ragazza bianca, nonostante innumerevoli prove dimostrassero la sua innocenza.
Il diritto di opporsi è un’indimenticabile testimonianza del coraggio, della perseveranza e dell’umanità necessarie a perseguire una giustizia più equa, ma anche una struggente denuncia contro la pena di morte.
Da questo libro, un bestseller da un milione e mezzo di copie vendute che da duecento settimane è ai vertici delle classifiche americane, è stato tratto il film con Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson.
«Nessun avvocato, dopo Atticus Finch, ha fatto una tale differenza nel Sud degli Stati Uniti… Il diritto di opporsi è la sua potente storia».
John Grisham
«Bryan Stevenson è il Nelson Mandela americano, un brillante avvocato che combatte con coraggio per garantire giustizia per tutti. Il diritto di opporsi dovrebbe essere letto in ogni paese civile del mondo per scoprire cosa succede quando vendetta e punizione sostituiscono giustizia e misericordia».
Desmond Tutu, premio Nobel per la pace
«Il libro più toccante e potente mai scritto sulla pena di morte».
«Financial Times»
«Commovente come Il buio oltre la siepe».
«The New York Review of Books»
Estratto
In ricordo di Alice Golden Stevenson,
mia madre
L’amore è la causa, ma la giustizia
è lo strumento.
REINHOLD NIEBUHR
Introduzione
Un campo più elevato
Non ero pronto a incontrare un condannato. Nel 1983 ero uno studente di ventitré anni alla facoltà di Legge di Harvard alle prese con un tirocinio in Georgia: ansioso, privo di esperienza e con il timore di non essere in grado di gestire la situazione. Non avevo mai visto un carcere di massima sicurezza dall’interno, e di certo non ero mai stato nel braccio della morte. Quando mi dissero che avrei incontrato quel detenuto da solo, senza alcun avvocato al mio fianco, cercai di non far trasparire il terrore da cui fui colto.
Il braccio della morte della Georgia si trova in un carcere fuori Jackson, una sperduta cittadina in una zona rurale dello Stato. Ci andai da solo in auto, guidando da Atlanta in direzione sud, lungo l’interstatale 75, e con il cuore che batteva sempre più forte man mano che mi avvicinavo a destinazione. Non sapevo davvero nulla della pena capitale e ancora non avevo nemmeno seguito il corso di Procedura penale. Non possedevo i primi rudimenti di tutta la serie complessa di appelli che danno forma a un procedimento per la pena di morte, un iter che con il tempo sarebbe diventato per me familiare come il palmo della mia mano. Quando mi iscrissi a quel tirocinio, non avevo riflettuto più di tanto sul fatto che avrei dovuto incontrare concretamente dei detenuti che erano stati condannati. A essere sincero, non sapevo neanche se volessi diventare avvocato. Man mano che i chilometri correvano via lungo quelle strade di campagna, in me diventava sempre più forte la convinzione che quell’uomo sarebbe rimasto molto deluso dal nostro incontro.
Al college avevo studiato Filosofia e fino all’ultimo anno non mi ero reso conto che, una volta laureato, nessuno mai avrebbe pagato per sentirmi filosofeggiare. La mia ricerca frenetica per un “progetto post lauream” mi aveva portato alla facoltà di Legge più che altro perché per iscriversi agli altri programmi di laurea erano richieste delle competenze; per le facoltà di Giurisprudenza, invece, non sembrava necessaria alcuna conoscenza preliminare. Ad Harvard potevo studiare Legge e nel frattempo – cosa che mi interessava – conseguire una laurea in Politiche pubbliche alla Kennedy School of Government. Ignoravo che cosa avrei fatto del mio avvenire, però sapevo che sarebbe stato legato alle vite dei poveri, alla storia delle ineguaglianze razziali in America e alla lotta per l’equità e la giustizia reciproche. Avrebbe avuto a che fare con le cose che fino ad allora avevo visto e pensato nella mia vita, ma che ancora non riuscivo davvero a mettere insieme in un percorso chiaro per la mia carriera.
Poco dopo aver iniziato le lezioni ad Harvard, cominciai a temere di aver fatto la scelta sbagliata. Arrivando da un piccolo college della Pennsylvania, mi ritenevo davvero fortunato per esservi stato ammesso, ma alla fine del primo anno mi sentivo insoddisfatto. All’epoca, la facoltà di Legge di Harvard era un luogo che incuteva un certo timore, soprattutto a un ventunenne. Tra i professori, erano molti a usare il metodo socratico – un’indagine attraverso domande dirette, ricorsive e confutatorie – il cui effetto secondario era quello di umiliare gli studenti impreparati. Quelle lezioni mi sembravano esoteriche e lontane dai temi razziali e della povertà che mi avevano motivato a mettere Legge come prima scelta.
Molti studenti avevano già una laurea di livello avanzato o lavoravano come assistenti presso studi legali prestigiosi. Io non possedevo nessuna di queste credenziali. Mi sentivo di gran lunga meno esperto e navigato rispetto ai miei compagni. Quando, a un mese dall’inizio delle lezioni, gli studi legali cominciarono a presentarsi nel campus e a intervistare gli studenti, i miei compagni di corso indossarono l’abito buono e furono pronti a firmare per ricevere “voli” diretti a New York, Los Angeles, San Francisco o Washington. Per me, invece, comprendere esattamente che cosa, con tanto zelo, ci stessimo tutti preparando a fare rimaneva un mistero assoluto. Prima di iniziare a studiare Legge, non avevo neppure mai incontrato un avvocato.
Trascorsi l’estate del primo anno alla facoltà di Giurisprudenza collaborando a un progetto di giustizia minorile, a Philadelphia, mentre la sera prendevo lezioni di calcolo avanzato per prepararmi all’anno successivo alla Kennedy School. A settembre però, una volta iniziato il programma di Politiche pubbliche, continuavo a sentirmi un pesce fuor d’acqua. Il curriculum era eccessivamente quantitativo, ossia incentrato su come massimizzare i benefici e minimizzare i costi, senza preoccuparsi più di tanto di che cosa questi benefici realizzassero e che cosa comportassero quei costi. Per quanto intellettualmente stimolanti, corsi come Teoria delle decisioni, Econometria e simili mi procuravano un senso di frustrazione. Poi però, all’improvviso, tutto divenne chiaro.
Venni a sapere che la facoltà di Legge offriva un corso intensivo, fuori dai canoni e della durata di un mese, sui processi a sfondo razziale e legati alla povertà sotto la docenza di Betsy Bartholet, un professore di Legge che aveva lavorato come avvocato per il Fondo di difesa legale dell’Associazione nazionale per la promozione delle persone di colore (NAACP). A differenza della maggior parte degli altri corsi, questo portava gli studenti fuori dal campus, obbligandoli a trascorrere quel mese con un’organizzazione che svolgeva attività di giustizia sociale. Firmai con entusiasmo la mia adesione e nel dicembre del 1983 mi ritrovai a bordo di un aereo diretto ad Atlanta, in Georgia, dove era previsto che passassi alcune settimane collaborando con il Comitato per la difesa dei detenuti del Sud (SPDC).
Il volo diretto per la capitale della Georgia superava le mie disponibilità economiche, perciò dovetti fare scalo a Charlotte, nella Carolina del Nord, e fu lì che incontrai Steve Bright, il direttore dell’SPDC, di ritorno ad Atlanta dalle vacanze. Steve aveva all’incirca trentacinque anni e possedeva una passione e una certezza che apparivano l’esatto contrario della mia indecisione. Era cresciuto in una fattoria del Kentucky e, dopo la facoltà di Legge, era approdato a Washington. Era un brillante avvocato di tribunale presso il Servizio per la difesa d’ufficio del Distretto di Columbia ed era appena stato reclutato alla guida dell’SPDC, la cui missione era assistere i condannati nel braccio della morte in Georgia. Tra ciò che faceva e ciò in cui credeva, in lui non vi era alcuna traccia di quelle cesure che invece avevo riscontrato in così tanti miei professori di Legge. Quando ci incontrammo mi strinse in un abbraccio caloroso, dopodiché iniziammo a parlare. E continuammo, finché non fummo atterrati ad Atlanta.
A un certo punto, durante il nostro breve volo, mi disse: «Bryan, pena capitale significa che “senza quel capitale loro ottengono una pena”. Non possiamo aiutare quelli nel braccio della morte senza l’aiuto di persone come te».
La sua certezza immediata che io avessi qualcosa da offrire mi colse di sorpresa. Iniziò quindi ad analizzare le questioni legate alla pena di morte in maniera semplice ma persuasiva, mentre io pendevo dalle sue labbra, completamente rapito dalla sua dedizione e dal suo carisma.
«Mi auguro che mentre sei qui tu non ti crei aspettative troppo grandi», mi disse.
«Oh, no», lo rassicurai, «sono grato per l’opportunità di lavorare con voi».
«Bene, “opportunità” non è necessariamente la prima parola che viene in mente quando si pensa di lavorare con noi. Conduciamo una vita alquanto semplice, e le ore sono piuttosto dense».
«Questo per me non è un problema».
«Be’, in effetti, si potrebbe dire che viviamo ancor meno che semplicemente. Piuttosto a corto di soldi, forse addirittura come chi se la cava a malapena e lotta per resistere, sopravvivendo grazie alle premure degli sconosciuti, sbarcando il lunario giorno dopo giorno, incerti sul futuro».
Mi lasciai sfuggire uno sguardo turbato e Steve si mise a ridere.
«Sto scherzando… più o meno».
Passò a parlare d’altro, ma era chiaro che il suo cuore e i suoi pensieri erano rivolti alle traversie dei condannati e di coloro che dovevano affrontare un trattamento ingiusto nelle
prigioni e nelle carceri. Incontrare qualcuno la cui vita era così potentemente animata dal proprio lavoro fu un’esperienza che mi segnò nel profondo.
L’inverno in cui approdai all’SPDC vi lavoravano solo un paio di avvocati. La maggior parte di loro erano ex difensori penali provenienti da Washington ed erano arrivati in Georgia per rispondere a una crisi sempre più urgente: i detenuti nel braccio della morte non riuscivano ad avere un avvocato. Questi avvocati, uomini e donne, neri e bianchi e tutti sulla trentina, erano incoraggiati l’un l’altro da una missione comune, da una speranza condivisa, nonché dal medesimo sforzo per le sfide da affrontare.
Dopo anni di ritardi e divieti, nel Profondo Sud erano riprese le esecuzioni e la maggior parte delle persone che affollavano il braccio della morte non avevano né un avvocato né diritto a un difensore d’ufficio. Si faceva sempre più largo il timore che ben presto le persone sarebbero state uccise senza che il loro caso fosse mai stato riesaminato da un legale esperto. Ogni giorno ci arrivavano chiamate cariche d’angoscia da parte di carcerati che non ricevevano alcuna assistenza legale, ma la cui data di esecuzione era stata fissata sul calendario e si avvicinava rapidamente. Non avevo mai sentito delle voci così disperate.
Quando iniziai il tirocinio, furono tutti estremamente gentili con me e io mi sentii subito a casa. L’SPDC si trovava in centro ad Atlanta, nell’Healey Building, un edificio di sedici piani in stile neogotico eretto agli inizi del Novecento e ormai in notevole declino, i cui inquilini se ne stavano andando. Insieme a due avvocati, lavoravo in un cerchio angusto di scrivanie e svolgevo mansioni d’ufficio, rispondendo al telefono e facendo ricerche per il gruppo sui vari aspetti giuridici. Avevo appena iniziato ad ambientarmi nella mia routine d’ufficio, quando Steve mi chiese di andare nel braccio della morte per fare visita a un condannato che nessuno degli altri aveva tempo di incontrare. Mi spiegò che l’uomo era lì da più di due anni e che loro non disponevano ancora di un avvocato che si occupasse del suo caso; il mio compito era quello di trasmettere a quell’uomo un solo, semplice messaggio: L’anno prossimo non verrai ucciso.
Mentre guidavo attraverso i campi arati e i boschi nelle campagne della Georgia, ripetevo mentalmente le parole che avrei detto a quell’uomo. Più e più volte riprovai il modo in cui presentarmi.
«Salve, il mio nome è Bryan. Sono uno studente presso il…». No. «Sono uno studente di Legge presso…». No. «Il mio nome è Bryan Stevenson. Sono un tirocinante di Legge presso il Comitato per la difesa dei detenuti del Sud e sono stato incaricato di informarla che lei non verrà giustiziato a breve». «Lei non potrà essere giustiziato a breve». «Assolutamente, a breve lei non corre alcun rischio di esecuzione». No.
Continuai a esercitarmi con la mia presentazione, finché non mi fermai davanti alla minacciosa recinzione in filo spinato e alla torretta di guardia bianca del Centro di classificazione e diagnostica della Georgia. In ufficio lo chiamavamo semplicemente “Jackson”, perciò ritrovarmi di fronte al suo vero nome inciso su una targa mi procurò un sussulto: mi sembrò un atto clinico, quasi terapeutico. Parcheggiai l’auto e mi avviai verso l’ingresso del carcere, dopodiché entrai nell’edificio principale con i suoi corridoi bui e gli ingressi chiusi da cancellate, dove ogni via d’accesso era preclusa da sbarre di metallo.
Per raggiungere l’area destinata alle visite legali dovetti attraversare un corridoio dentro a un tunnel, in cui ogni passo riecheggiava sinistro sul pavimento dalle piastrelle immacolate. Quando annunciai al funzionario addetto alle visite che ero un assistente legale mandato a incontrare un carcerato nel braccio della morte, questi mi guardò con sospetto. Indossavo l’unico abito che possedevo ed entrambi eravamo consapevoli che aveva visto giorni migliori. Gli occhi del funzionario sembrarono indugiare a lungo e con severità sulla mia patente di guida, dopodiché piegò il capo verso di me e iniziò a parlare.
«Lei non è di qui».
Più che una domanda, era un’affermazione…
Bryan Stevenson
È uno degli avvocati più conosciuti e influenti al mondo. Fondatore della Equal Justice Initiative, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il MacArthur Fellows Program. HBO ha prodotto un documentario basato sulla sua storia, True Justice.

Jenny