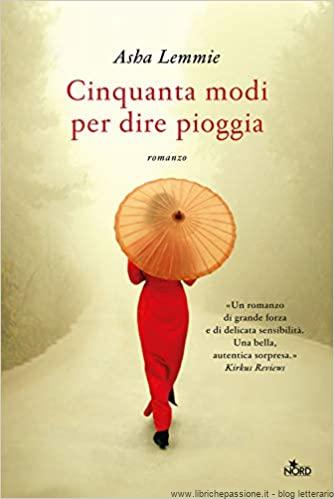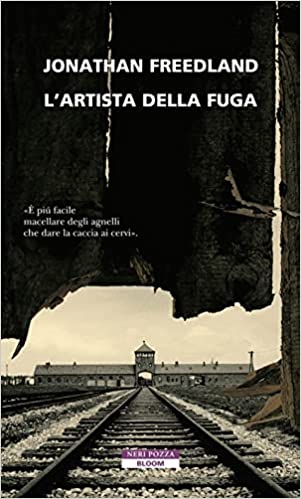

Auschwitz, 1944. La zona è un cantiere edile e rimbomba del rumore sordo del legno, dei cani che abbaiano e delle grida delle SS e dei Kapò. Walter Rosenberg controlla con cura la machorka, il tabacco russo infilato nelle fessure delle assi della catasta di legno perché i cani trovino l’odore repellente. È nascosto con Alfred Wetzler in quella catasta da tre giorni. Ha udito migliaia di stivali che calpestavano il terreno, gli ufficiali che imprecavano, i cani con la bava alla bocca alla ricerca del minimo, fragile, trepidante segno di vita umana e, ora che l’anello esterno delle torri di avvistamento è sgombrato, è il momento giusto per scappare. Fuggire da Auschwitz a diciannove anni insieme con Fred, l’amico bohémien conosciuto a Trnava, in Slovacchia. Due ragazzi ebrei prigionieri dell’orrore nazista. Cosí comincia una fuga che è senza precedenti nella tragica vicenda della Shoah, una fuga che farà di Rudolf Vrba, – il nome che prenderà Walter Rosenberg peregrinando nei paesi dell’Europa dell’Est governati dagli alleati dei nazisti – un testimone meritevole di stare accanto ad Anna Frank, Oskar Schindler e Primo Levi.
È una storia che mostra «come le azioni di una sola persona, anche adolescente, possano piegare l’arco della Storia, se non verso la giustizia, almeno verso la speranza». Rudolf Vrba racconterà, infatti, in maniera dettagliata e precisa, dello sterminio e del progetto della «soluzione finale». Non sarà creduto, sulle prime. Le trentadue pagine del suo rapporto arriveranno, tuttavia, fino a Roosevelt, a Churchill e al Papa e diventeranno poi il documento chiave del processo di Norimberga. La sua impresa è raccontata in questo libro perché «si esibisca in un’ultima fuga: sottrarsi all’oblio ed essere ricordato».
«Pensavo di conoscere la storia di Auschwitz, ma Freedland la racconta da una prospettiva totalmente nuova». Tracy Chevalier
«Un libro acuto e straziante che si interroga su temi universali, tra cui il potere dell’informazione e della disinformazione: è possibile fermare un genocidio dicendo la verità?» Yuval Noah Harari
«Due giovani fuggiti da Auschwitz denunciarono lo sterminio. Ma all’inizio molti ritennero che si trattasse di esagerazioni». Paolo Valentino, Corriere della Sera
«È più facile macellare degli agnelli che dare la caccia ai cervi». Jonathan Freedland

A mio padre, Michael Freedland, 1934-2018
Il suo ricordo è una benedizione
Nota dell’autore
Quando avevo diciannove anni andai al Curzon di Mayfair, a Londra, a vedere Shoah, un documentario di una lunghezza biblica, nove ore. Non era una serata al cinema come tante, un po’ per la durata del film, ma soprattutto per via del pubblico: in sala c’erano i sopravvissuti al genocidio degli ebrei. L’amico con cui ero andato aveva avuto la pessima idea di portarsi i popcorn, ma se li godette ben poco. Se n’era giusto messo in bocca una manciata che una donna si voltò dalla fila vicina e gli diede uno schiaffone sulla coscia.
«Abbi un po’ di rispetto!» disse, con un forte accento che aveva in sé il ricordo dell’Europa prebellica.
Tutto il film era destinato a lasciare in me un segno profondo, ma ci fu uno degli intervistati che mi rimase impresso piú degli altri. Si chiamava Rudolf Vrba. Il documentario ne riporta la testimonianza sui piú grandi orrori della storia umana, orrori a cui aveva assistito in prima persona e ai quali era sopravvissuto. Solo di sfuggita accenna a un qualcosa di straordinario, un fatto che lo rende piú unico che raro tra i sopravvissuti alla Shoah. A diciannove anni, la stessa età che avevo io quando vidi il film, era fuggito da Auschwitz.
Se io non ne ho mai dimenticato il nome e il volto, con mia grande sorpresa, nei decenni successivi, scoprii che pochi altri ne avevano sentito parlare. Finché un giorno, a una trentina d’anni da quella sera al cinema del 1986, mi ritrovai a pensarci. Vivevamo nell’era della postverità e delle fake news, in cui sembrava non contare piú nulla l’aderenza alla realtà dei fatti, e pensai ancora una volta all’uomo pronto a rischiare tutto affinché il mondo potesse conoscere la terribile verità nascosta sotto un cumulo di menzogne.
Iniziai a fare ricerche sulla vita di Rudolf Vrba, trovando le poche persone ancora vive che lo avevano conosciuto o avevano lavorato con lui o gli avevano voluto bene. Per un caso fortunato la fidanzata di quand’era adolescente e sua prima moglie, Gerta, ormai novantatreenne, viveva a Muswell Hill, nella zona settentrionale di Londra. Per qualche pomeriggio estivo nell’anno dell’epidemia 2020, seduti in giardino da lei, abbiamo parlato di quel giovane che allora si chiamava Walter Rosenberg e del mondo che entrambi avevano conosciuto. Mi consegnò una valigia rossa piena di lettere in cui Rudi alle volte esprimeva un dolore quasi insopportabile. A pochi giorni dalla nostra ultima chiacchierata, in cui mi aveva raccontato tutta quanta la storia per filo e per segno, ricevetti una telefonata dalla famiglia: Gerta ci aveva lasciati.
La seconda moglie e vedova di Rudi, Robin, viveva a New York. Anche con lei parlammo per ore e ore, mi disse dell’uomo che Rudolf era diventato, dei ricordi che le aveva affidato, dell’amore che li aveva uniti. Ben presto però, ascoltandola e spulciando documenti, archivi e ricostruzioni storiche, capii che avevo a che fare con qualcosa di piú del racconto di un’evasione senza precedenti: stavo vedendo come la Storia possa cambiare una vita, anche attraverso le generazioni; come la differenza tra la verità e la menzogna possa diventare anche la differenza che passa tra la vita e la morte; e come ci si possa rifiutare di credere anche solo alla possibilità del proprio imminente sterminio, anche quando – e forse soprattutto quando – è cosa certa. Erano questioni che si imponevano con brutale intensità già nell’Europa degli anni Quaranta, ma sembravano avere una nuova, spaventosa risonanza ai nostri tempi.
L’altra cosa che appresi da questa vicenda è come gli esseri umani, seppur spinti all’estremo, riescano in qualche modo a resistere; come si possa conservare la capacità, la voglia di vivere pur avendo assistito a tanta morte; e come le azioni di una sola persona, anche adolescente, possano piegare l’arco della Storia, se non verso la giustizia, almeno verso la speranza.
Quella sera uscii dal cinema convinto che il nome di Rudolf Vrba meritasse di stare accanto a quelli di Anna Frank, Oskar Schindler e Primo Levi tra le vicende personali che ci fanno sapere che cosa sia stata la Shoah. Forse non accadrà mai. Può anche darsi però che, con questo libro, Rudolf Vrba si esibisca in un’ultima fuga: sottrarsi all’oblio ed essere ricordato.
Prologo
7 aprile 1944. Dopo giorni di ritardo, settimane di preparazione ossessiva, mesi passati a veder fallire i tentativi altrui e due anni ad assistere alla bassezza in cui erano capaci di sprofondare gli esseri umani, era finalmente giunto il momento. Era ora di fuggire.
Gli altri due prigionieri erano già lí, al punto stabilito. Annuirono senza dire una parola: forza! Walter e Fred non se lo fecero ripetere. Si arrampicarono in cima alla catasta del legname, trovarono l’apertura e, a turno, si calarono dentro. Un attimo dopo, i loro compagni risistemarono le assi sopra le loro teste. Uno sussurrò: «Buona fortuna»1. Poi, furono solo buio e silenzio.
Senza perder tempo, Walter si mise all’opera. Tirò fuori la machorka, lo scadente tabacco russo di cui gli avevano parlato, preparato secondo le istruzioni: imbevuto di benzina e poi lasciato essiccare. Pian piano, cominciò a infilare il tabacco nelle fessure tra le assi di legno, soffiando delicatamente per distribuirlo meglio, sperando con tutto il cuore che il prigioniero di guerra russo che gli aveva insegnato il trucco avesse ragione, che i cani avrebbero trovato l’odore repellente. Non che si fossero esclusivamente affidati all’intervento di Walter: avevano già provveduto a cospargere abbondantemente di tabacco trattato il terreno intorno al nascondiglio2, di modo che i cani delle SS non si avvicinassero nemmeno. Se il russo sapeva il fatto suo, Walter e Fred sarebbero potuti rimanere accucciati in quel buco sotto la catasta, standosene buoni e tranquilli, per tutto il tempo necessario: tre giorni e tre notti.
Walter fissò le lancette fosforescenti del suo orologio3. Il tempo scorreva lento. Gli sarebbe tanto piaciuto alzarsi, stiracchiarsi, ma non era proprio possibile. Gli stavano venendo i crampi alle braccia e alle gambe, ma sapeva di dover sopportare, e pure in silenzio. Parlare era troppo rischioso. A un certo punto, Walter sentí Fred, che aveva sette anni piú di lui, prendergli la mano e stringerla4. Walter ne aveva diciannove.
Cos’era stato? Un rumore di passi in avvicinamento. Avevano appena cominciato ed era già finita? Istintivamente, le loro mani corsero alle lame. Su questo non avevano dubbi: se li avessero catturati non si sarebbero lasciati interrogare5. L’avrebbero fatta finita in quella buca; avrebbero trasformato il nascondiglio in una tomba.
Certo è che le SS non li avrebbero lasciati lí. Avrebbero trascinato i corpi fino al campo. Li avrebbero legati a delle vanghe conficcate nel terreno o appesi alla forca, con al collo un cartello di avvertimento, come facevano dopo ogni tentativo di fuga fallito. Dei loro cadaveri avrebbero fatto trofei.
A ogni secondo che passava Walter sentiva i nervi farsi piú tesi. La fossa in cui si trovavano era cosí angusta… Ma poi i passi, se di questo si trattava, svanirono.
L’urlo della sirena giunse alle sei di quel venerdí sera. Fece vibrare l’aria e gelare il sangue nelle vene, era l’ululato simultaneo di un branco di mille lupi. L’avevano già sentito tante volte: un suono talmente penetrante da far tappare le orecchie persino alle SS. Un rumore spaventoso, ma molto caro a tutti i prigionieri: voleva dire che almeno uno di loro era mancato all’appello serale e che, forse, era fuggito da Auschwitz.
Era il segnale. Fred e Walter uscirono dallo spazio piú grande, fatto per ospitare quattro persone, e s’insinuarono nella diramazione laterale, una specie di passaggio, che poteva accoglierne solo due. Doveva essere un ulteriore livello di protezione, un nascondiglio nel nascondiglio. I due si strinsero, giacendo immobili fianco a fianco. Per Walter fu quasi un sollievo: finalmente l’attesa era finita, cominciava la guerra di posizione6. Si legarono uno straccio sulla bocca, in modo da non tradirsi con un colpo di tosse7. L’unico movimento era quello delle lancette luminose dell’orologio.
Non l’avrebbero vista, ma sapevano che cosa accadeva dopo la sirena. E in men che non si dica poterono sentirla: la caccia all’uomo. Il rimbombo di duemila paia di stivali che calpestavano il terreno, gli ufficiali che imprecavano, abbaiavano ordini – urlandoli, perché, con quello che era successo qualche giorno prima, un’altra fuga era un’umiliazione –, i cani con la bava alla bocca alla ricerca del minimo, fragile e trepidante segno di vita umana8, duecento cani addestrati e preparati proprio a questo scopo. Le SS perlustravano ogni anfratto9, setacciavano ogni cespuglio, esaminavano ogni canale e puntavano le torce su ogni trincea di quella tentacolare metropoli della morte che era Auschwitz. La caccia era iniziata e sarebbe andata avanti tre giorni.
Di questo Fred e Walter potevano essere certi, perché i nazisti avevano un protocollo di sicurezza dal quale non si discostavano mai. Quella parte esterna del campo, dove gli internati erano impiegati come schiavi, era sorvegliata solo di giorno, durante l’orario lavorativo. Di notte, quando anche l’ultimo detenuto era stato ricondotto nel campo interno, con la sua doppia recinzione di filo elettrificato, non c’era bisogno di sorveglianza. Quella regola aveva un’unica eccezione: se un prigioniero mancava all’appello, le SS avrebbero tenuto le sentinelle armate nell’anello esterno, ogni torretta di guardia occupata da un uomo con una mitragliatrice.
Il tutto sarebbe durato settantadue ore, mentre le SS setacciavano il terreno centimetro per centimetro. Dopodiché avrebbero concluso che l’evasione era effettivamente riuscita, e da quel momento sarebbe spettato alla Gestapo rastrellare la regione per trovare il fuggitivo. Avrebbero sciolto il cordone esterno. Il che significava una breccia nelle difese naziste. Magari non una vera e propria breccia, piuttosto un piccolo varco. Se nei tre giorni e nelle tre notti dopo che era stato lanciato l’allarme un internato fosse riuscito a nascondersi nell’area esterna sfuggendo alle SS e ai loro cani, la quarta notte sarebbe riemerso in un campo incustodito. Poteva fuggire.
Walter udí una voce familiare. Quell’ubriacone assassino dell’Unterscharführer Buntrock doveva essere lí vicino, e dava ordini ai poveri sottoposti. «Guardate dietro quelle assi» diceva. «Usate la testa!»
Fred e Walter si tennero pronti. Le SS si avvicinarono. Sentirono degli stivali montare sulle assi sopra di loro, facendo cadere una spruzzata di sporcizia nella cavità sottostante. Tanto vicini erano gli inseguitori che Walter poteva sentirne il respiro affannato.
Poi fu la volta dei cani, raspavano il legno, annusavano, passavano da un’asse all’altra: li sentivano ansimare attraverso le pareti e il soffitto di legno10. E se il prigioniero russo si fosse sbagliato sulla sua speciale miscela di tabacco? O se Walter avesse frainteso le istruzioni? Perché gli animali non erano stati respinti dall’odore?
Stavolta afferrò il coltello anziché il rasoio; voleva un’arma da usare contro gli altri e non su di sé. Si sentiva il cuore in gola.
Ma, come per miracolo, fu solo un attimo. Gli uomini e i cani delle SS si allontanarono. Dentro quell’angusta duplice bara che era il loro nascondiglio, Fred e Walter si concessero il conforto di un sorriso.
I momenti di sollievo, però, non duravano mai a lungo. Per tutta la sera e quella prima notte, i rumori dei passi e i latrati dei cani si avvicinavano e si allontanavano, andavano in crescendo e in diminuendo, ora piú forti ora piú flebili, poi di nuovo forti, ogni volta che le squadre di ricerca tornavano in quello stesso angolo del campo. A Walter piaceva pensare di percepire l’irritazione nelle voci delle SS mentre passavano e ripassavano lo stesso terreno. Li sentiva imprecare mentre davano un secondo e un terzo scossone a un mucchio di travi o di tegole, ispezionando l’area per la terza volta.
Avevano entrambi un disperato bisogno di muoversi o allungarsi, ma non osavano. Walter avrebbe voluto scaldarsi le mani e i piedi gelidi, ma se provava a cambiare posizione tutto il corpo gli si contraeva in un crampo lancinante. Se uno dei due si assopiva, l’altro diventava preda della tensione, le orecchie tese a ogni minimo movimento nelle vicinanze. Nemmeno il sonno portava riposo, solo l’incubo di un eterno presente, bloccati in quella scatola sotterranea: l’inferno sotto i piedi, e peggio ancora l’inferno sopra le teste.
Sentirono che iniziava il turno mattutino, i suoni familiari del lavoro forzato. La zona era un cantiere edile e presto rimbombò del rumore sordo del legno e squillante del metallo, dei cani che abbaiavano e delle grida delle SS e dei Kapò11. Fred e Walter avevano calcolato che il rischio che la loro catasta di legname venisse smossa dagli operai era minimo – quelle assi non erano destinate all’utilizzo di lí a breve – ma rilassarsi proprio non potevano. Dovettero passare altre dieci ore prima che il rumore si placasse e il Kommando facesse rientro in caserma.
Per tutto il tempo, i due rimasero immobili, sapendo che nel campo interno le SS avrebbero perquisito ogni baracca, magazzino, bagno, latrina e capannone, mettendo tutto sottosopra. Naturalmente c’era un metodo: cercare in una serie di cerchi concentrici decrescenti, con al centro i segugi che si approssimavano alla preda. Una volta arrivati al centro del cerchio piú piccolo, si ricominciava da capo.
I nazisti si avvicinarono cosí tanto e cosí spesso, che Walter non sapeva come avessero fatto a non scoprire lui e Fred già ore prima. Fred la vedeva diversamente. «Stupidi bastardi!» disse, non appena poté rompere il silenzio senza rischi12. Forse era spavalderia. A distanza di ventiquattr’ore, nessuno dei due se la sentiva di mangiare o bere. In quello stretto cunicolo avevano ammassato provviste: alcuni etti di pane debitamente suddiviso in porzioni13, della margarina14 e una bottiglia di caffè freddo15. Ma avevano lo stomaco sottosopra, per non parlare dei nervi, e nessuno dei due toccò nulla.
In un modo o nell’altro le ore si erano trascinate dal sabato alla domenica. Decisero di arrischiarsi, per la prima volta da quando erano suonate le sirene, a uscire dal cubicolo per sistemarsi nello spazio relativamente piú comodo del loro bunker. Anche se Walter aveva cercato di riempire con il tabacco trattato gli interstizi delle pareti e del soffitto, non li aveva tappati tutti: filtrava un po’ della gelida foschia mattutina16.
Erano tutti anchilosati da quanto erano stati fermi immobili. Fred non riusciva a muovere il braccio destro e aveva perso la sensibilità alle dita17. Walter gli massaggiò la spalla per far circolare il sangue. Comunque non rimasero piú di tanto in quello spazio piú ampio.
Le SS continuavano le ricerche. Sentendo due voci tedesche a pochi metri di distanza, Fred e Walter rimasero impietriti. Era il primo pomeriggio e sentivano bene ogni parola.
«Non possono essere fuggiti» disse uno. «Devono essere ancora nel campo»18.
I tedeschi iniziarono a fare ipotesi su dove potessero essersi nascosti. Uno stava chiaramente indicando qualcosa. «Che ne dici della catasta di legno?»
Walter e Fred non mossero un muscolo.
«Credi che possano essere qui da qualche parte?» disse la voce. «Magari si sono costruiti una nicchia».
All’altro pareva improbabile. Dopotutto, rifletté ad alta voce e non a torto, «I cani ci sono passati decine di volte». Certo, a meno che gli ebrei scomparsi non avessero trovato un modo ingegnoso per depistarli.
Poi si scambiarono qualche parola per decidere, dicendosi che «valeva la pena provare», e a quel punto si arrampicarono.
Ancora una volta, Walter impugnò il coltello. Fred fece lo stesso.
I due tedeschi salirono in cima alla catasta, mettendosi a smantellarla asse dopo asse. Rimossero il primo strato, poi il secondo e infine, un po’ a fatica, il terzo e il quarto.
Fosse successo dieci secondi dopo, sarebbe stato troppo tardi. Non era la prima volta – doveva anzi essere l’ottava se non la nona – che a salvare la vita di Walter interveniva un colpo di fortuna, in questo caso di un tempismo perfetto.
In lontananza si udí un trambusto improvviso, voci distanti in preda all’eccitazione. Fred e Walter sentirono gli uomini sopra le loro teste fermarsi, come se tendessero le orecchie per cogliere quel che stava succedendo. Passò un secondo. Poi un altro. Alla fine, uno dei due disse: «Li hanno presi! Vieni, presto!»19 E, da sotto, Fred e Walter sentirono i loro mancati scopritori allontanarsi di corsa.
La domenica sera si fece lunedí mattina. Ormai era iniziato il conto alla rovescia, Walter fissava le lancette dell’orologio, sapendo che dovevano resistere ancora solo un altro po’…
Ritornò il turno del mattino, portando con sé lo stesso frastuono, gli stessi latrati, umani e animali, per altre dieci ore, ogni minuto allo stesso ritmo straziante.
Alla fine il Kommando rientrò in caserma. I tre giorni erano quasi passati.
Alle sei e mezzo della sera, Walter e Fred udirono finalmente il suono tanto atteso: Postenkette abziehen! Postenkette abziehen! Era l’ordine di rimuovere la Grosse Postenkette, il cordone esterno di sorveglianza, gridato da una torre di guardia all’altra per tutto il perimetro. Sentirono il grido svanire a mano a mano che si allontanava, per ridiventare piú forte avvicinandosi, fino a compiere un giro completo. Alle orecchie di Fred e Walter quelle parole, urlate dagli uomini che li avevano ridotti in schiavitú e avevano ucciso il loro popolo a centinaia di migliaia, suonarono come la piú dolce delle musiche. Era un’ammissione di sconfitta da parte delle SS, il riconoscimento di non essere riuscite a ricatturare i due prigionieri che si erano lasciate sfuggire.
Quindi, come prevedeva il protocollo, l’anello esterno delle torri di avvistamento fu sgombrato e il cordone ridotto cosí da racchiudere soltanto il campo interno. Walter poteva udire le SS che tornavano di vedetta nell’anello piú piccolo. Era questa la grande falla nel sistema di Auschwitz, il varco attraverso il quale lui e Fred avevano da tempo pianificato la fuga.
Avrebbero tanto voluto mettersi a correre, ma si trattennero. Per prima cosa dovevano riemergere dalla cavità laterale. Già solo fare un passetto provocò in Walter un dolore acuto lungo le braccia, le gambe, il tronco e il collo20. Aveva i muscoli rigidi e freddi, fece i primi movimenti a scatti, incerto, come se il corpo avesse bisogno di reimparare le funzioni motorie di base. Ci volle del tempo per entrambi, ma alla fine si ritrovarono nello spazio principale. Si accovacciarono e si stiracchiarono, ruotando i polsi e i piedi, non prima però di essersi abbracciati nel buio21.
Fecero un respiro profondo e premettero i palmi delle mani contro il soffitto, cercando di spingere verso l’alto. Ma non si muoveva. Provarono un altro punto. Nemmeno qui voleva saperne di spostarsi. Era questo il vizio di fondo del loro piano? Si erano chiusi senza volerlo nella loro stessa tomba? Era l’unica cosa che non avevano provato e a cui non avevano nemmeno pensato. Avevano dato per scontato che, se si potevano accatastare le assi di legno, si potevano anche togliere. Ma un conto è sollevare le assi da sopra, quando puoi prenderne una alla volta, un altro è farlo da sotto, quando il peso dell’intera catasta preme verso il basso.
Spingendo assieme, grugnendo per lo sforzo, riuscirono a sollevare una delle tavole inferiori di un paio di centimetri. Sufficienti, però, per trovare un appiglio. A quel punto riuscirono ad afferrarla quel tanto da spingerla di lato. Fred si voltò verso Walter sorridendo. «Benedetti quei tedeschi che stavano quasi per trovarci» sussurrò. «Se non avessero spostato le altre assi, saremmo stati in trappola!»22
Ci volle piú tempo di quanto avessero immaginato ma alla fine, in quello che era stato il tetto del loro rifugio da venerdí, c’era un’apertura. Si intravedeva il cielo illuminato dalla luna.
Fecero di nuovo appello alle loro energie, spostando e spingendo le tavole finché non riuscirono, con uno sforzo atroce, a issarsi e tirarsi fuori. Ce l’avevano fatta. Erano fuori da quel buco sottoterra.
Non erano ancora usciti dal campo, però. Per diventare i primi ebrei a evadere da Auschwitz e a rimanerne fuori c’era ancora parecchia strada da fare. Già cosí, per il giovane Walter Rosenberg era una sensazione esaltante, ma non del tutto nuova. Perché quella non era la sua prima fuga. E non sarebbe stata l’ultima.
Prima parte
I preparativi
1. Stella
Aveva sempre saputo di essere speciale. Non era ancora Rudolf Vrba, lui sarebbe venuto dopo. Si chiamava Walter Rosenberg e gli bastò guardare la madre negli occhi per capire di essere unico. Helene Rosenberg lo aveva tanto aspettato, lo desiderava con tutta sé stessa. Aveva già tre figli non suoi, frutto del precedente matrimonio del marito Elias, ma tenere in braccio un bimbo suo era tutt’altra cosa. Per dieci anni l’aveva voluto sopra ogni cosa; i medici le avevano detto di non sperarci piú. Cosí, quando Walter arrivò, l’11 settembre 1924, lo aveva accolto come un miracolo.
Lo adorava, cosí come lo adoravano i fratellastri, due maschi e una femmina, tutti piú grandi di lui di una decina d’anni. In particolare Sammy e Fanci erano come degli zii piú che dei fratelli. Destinatario delle attenzioni solitamente riservate a un figlio unico, il piccolo Walter possedeva un’intelligenza precoce per la sua età. Aveva solo quattro o cinque anni quando Fanci, che voleva starsene un po’ con il fidanzato, lo accompagnò nella scuola in cui costui lavorava, e siccome la scuola consisteva in un’unica aula, ci sarebbe stato qualcuno che l’avrebbe tenuto d’occhio. Doveva solo rimanere buono in un angolo a giocare o disegnare, ma quando tornò Fanci trovò l’insegnante che indicava in Walter Rosenberg un esempio da seguire dagli altri bambini, e sí che alcuni avevano il doppio della sua età1. «Guardate com’è bravo Walter a fare le sue cose» diceva.
Era poco piú grande quando in famiglia lo trovarono intento a sfogliare tutto tranquillo le pagine di un giornale.
Era nato a Topol’čany, che rispetto alla Slovacchia si trovava a ovest ma era piú verso il centro della nuova Cecoslovacchia, creata appena sei anni prima. Di lí a poco la famiglia vendette tutto e si trasferí nella parte orientale del paese, avvicinandosi all’Ucraina – a Jaklovce, un puntino sulla mappa tanto insignificante che i treni passavano senza mai fermarsi. Neanche avrebbero potuto: non c’era stazione, nemmeno un marciapiede. Fu cosí che il padre di Walter, proprietario di una segheria locale, si mise in testa di costruire una banchina e una saletta d’attesa, con tanto di tetto, una struttura che, per la gioia di Walter, fungeva anche da sukkah di famiglia durante la settimana autunnale in cui gli ebrei sono tenuti a dimostrare la loro fede nell’Onnipotente consumando i pasti in capanne temporanee a cielo aperto.
Al giovane Walter la vita in campagna piaceva. Allevavano polli, tra cui una gallina ovaiola che era l’orgoglio della famiglia. Una volta i genitori si accorsero che ogni tanto spariva qualche uovo e misero Fanci a fare la guardia: forse una volpe stava razziando il pollaio. Una mattina Fanci scoprí il colpevole, e non era il predatore che ci si sarebbe aspettati: era il fratellino che s’intrufolava nel pollaio, rubando le uova per mangiarsele crude.
I Rosenberg non rimasero a lungo nel villaggio. Elias morí quando Walter aveva quattro anni, e Ilona tornò a ovest, luogo d’origine della famiglia. Trovandosi nella necessità di guadagnarsi da vivere, si mise a fare la venditrice ambulante di biancheria intima che realizzava lei stessa, non certo la situazione ideale per crescere un bambino.
Una volta lasciò il figlio da un’amica, che Ilona stessa avrebbe definito «una mantenuta». Costei, furibonda con un «benefattore» che l’aveva scaricata, aveva promesso una mancia al piccolo Walter se avesse finto di essere il frutto del loro amore, mentre lei sfilava per la città lamentandosi a gran voce del disgraziato che aveva abbandonato lei e il fanciullo. Per la sua esibizione, Walter fu ricompensato con una gita dal fornaio e la sua torta preferita.
Dopo quanto successo, Ilona pensò che fosse meglio che il figlio andasse a vivere con i nonni a Nitra. E si rivelò una buona idea. Walter ben presto si legò al nonno, che lo allevò secondo i costumi di un giudaismo rigorosamente ortodosso. Di tanto in tanto, gli capitava di fare una commissione a casa dello stimatissimo rabbino della città2, e di venerdí Walter seguiva il nonno quando andava con tutti gli altri uomini al fiume, usandolo come miqweh, immergendosi nell’acqua per il bagno rituale in cui gli ebrei si purificano in preparazione allo shabbat.
A Walter la tradizione piaceva e amava i nonni: era felice. L’unica nuvola in cielo era una certa rivalità familiare col cugino viennese Max, che aveva un paio d’anni piú di lui. Walter sapeva che il nonno era orgoglioso dei suoi risultati scolastici, ma sospettava che il vecchio gli preferisse Max.
Poi sua nonna ebbe un tracollo e il nonno decise che non poteva piú crescere il bimbo da solo: Walter fu spedito in un orfanotrofio ebraico a Bratislava. Dove stupí ancora una volta gli insegnanti per il suo zelo nello studio – quando gli chiesero che cosa gli piacesse fare, aveva risposto: imparare le lingue e leggere, ma trovava il tempo anche di giocare a calcio –
anto che il preside aveva suggerito a Ilona di iscrivere il bambino in uno dei migliori licei della città. Avrebbe significato fare di Bratislava una residenza permanente e assumere una giovane come tutrice mentre lei era in giro per i suoi commerci. Ma se suo figlio poteva avere il meglio, lei era decisa a darglielo.
Quando, nell’autunno del 1935, venne il momento di posare per una fotografia di classe, già erano visibili i tratti dell’uomo che sarebbe diventato. Appena undicenne, aveva un aspetto un po’ nervoso, ma già una certa presenza. Seduto a schiena dritta, con i capelli scuri pettinati da una parte e le folte sopracciglia che lo avrebbero accompagnato tutta la vita, fissava l’obiettivo con una certa intensità. Gli altri ragazzi facevano come era stato detto loro, posando con le braccia conserte. Non lui.
Indossava ancora la tzitzit, quella specie di corpetto con le frange portato sotto gli abiti dall’ebreo maschio devoto, ma sua madre gli aveva fatto una fascia per tenere nascoste le nappe. Le peyess, i riccioli sulle tempie che Walter portava a Nitra, erano sparite. Per la prima volta, ora era libero di prendere le proprie decisioni religiose, senza l’influenza del nonno o dell’orfanotrofio. Un pomeriggio, passeggiando per le strade di Bratislava con in tasca i soldi del pranzo, decise di mettere Dio alla prova: entrò in un ristorante e ordinò del maiale. Al primo boccone, aspettò che la saetta colpisse3. Quando non successe nulla, si decise per la rottura.


Jonathan Freedland è editorialista del Guardian e scrive regolarmente anche per la New York Review of Books. Conduce la trasmissione di storia contemporanea The Long View per BBC4. Nel 2014 è stato insignito dell’Orwell Special Prize for Journalism. È anche autore di sette thriller con lo pseudonimo di Sam Bourne.