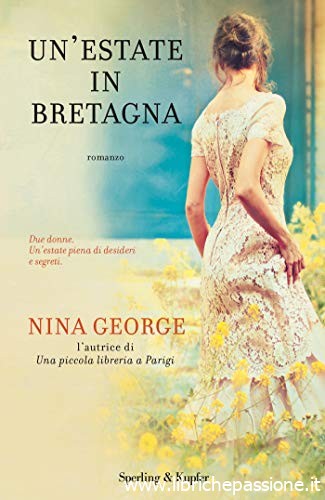Trama
Trama
Tariq, diciannove anni, braccia magre e capelli scarmigliati, abita in una casa bianca appena fuori dalla medina di Tangeri. Suo padre, Malik Zafar, è un imprenditore di mezza tacca con l’ambizione che il figlio segua le sue orme; della madre, Hanan, morta quando lui aveva appena nove anni, Tariq sa invece poco e nulla, se non che la donna aveva origini francesi. Per questo motivo, quando il ragazzo decide di tagliare la corda per sfuggire alle pressioni paterne, l’unica meta possibile sembra essere Parigi, la scintillante città dove Hanan è cresciuta e dove lui spera di scoprire qualcosa su di lei. L’americana Hannah, dopo aver trascorso un periodo in Africa, sbarca a Parigi con l’intenzione di concludere la sua tesi post-dottorato e condurre delle ricerche sulla condizione delle parigine durante l’Occupazione tedesca. Dieci anni sono trascorsi dal suo primo soggiorno nella capitale francese, ma l’eco di un grande amore, e della terribile delusione conseguita, ancora non smettono di tormentarla. Hannah e Tariq hanno poco in comune, ma entrambi sono alla ricerca di qualcosa di perduto: dei fantasmi di Parigi e, al contempo, dei loro personali fantasmi. Quando le loro strade si incroceranno, e soprattutto incroceranno quella della misteriosa Clémence, venticinquenne dalla carnagione scura e gli occhi neri, il passato tornerà a galla con prepotenza, travolgendo ogni cosa. Romanzo profondamente toccante, I fantasmi di Parigi affronta la storia di una nazione e la sua identità e costituisce, insieme, una profonda riflessione sui diversi modi in cui il passato e il presente si intrecciano, a dispetto del trascorrere del tempo.
Estratto
a Hector, mon ami
Qu’est l’histoire? Un écho du passé dans l’avenir. Un réflet de l’avenir sur le passé.
Victor Hugo, L’Homme qui rit
Il metrò offre al forestiero (…) l’occasione migliore per illudersi di essere penetrato (…) nell’essenza di Parigi.
Franz Kafka, Diari
Fourmillante cité, cité pleine de rêves, Où le spectre en plein jour raccroche le passant!
Charles Baudelaire
“Le Sept Rueillards”, da Les Fleurs du Mal
1. Maison Blanche
Stavo facendo la pipì, quando fui attirato dalla mia immagine allo specchio. Il mio volto era così bello che mi voltai a guardarlo e per la fretta spruzzai le piastrelle intorno al water. Dopo averlo scrollato, m’infilai lo zib nei boxer e mi soffermai sull’immagine: l’ombra sulle guance faceva risaltare gli zigomi e pareva che mi fossi dato il mascara. Negli occhi, infatti, c’era un’intensità che non avevo mai colto. Inclinai il capo e sorrisi, corrugando la fronte, ma gli occhi continuavano a luccicare maliziosi. La faccia di uno molto più maturo e navigato di me.
Come avevo fatto a non accorgermi di essere così bello? Non una bellezza classica, tipo gli attori di una volta, né quella spudorata dei divi di oggi. Un misto di anima e sensualità.
Provai a guardarmi più da vicino, poi presi uno specchietto per vedermi da ogni angolazione: ero bello comunque. Forse era perché avevo fumato del kif e ci avevo bevuto sopra una Coca per evitare che mi calassero gli zuccheri (un trucco imparato a scuola). Ero felice di pensare che quella persona ero io: non poteva capitarti niente di male con un aspetto del genere. Il futuro mi avrebbe riservato solamente grandi soddisfazioni: ragazze dalla pelle vellutata e viaggi in terre lontane.
Io e l’uomo nello specchio continuammo a fissarci per qualche minuto.
Poi fu lui a parlare.
«Te ne devi andare di qui, amico» disse.
Non potei fare a meno di annuire.
Perché lo sapevo da un pezzo. Non mi turbarono le sue parole, anzi mi furono di sollievo.
«È tempo di partire».
«Lo farò. Presto».
Abitavamo in una casa bianca appena fuori dalla medina, la città vecchia. Al piano terra viveva un’altra famiglia, e una scala esterna conduceva al nostro alloggio, composto dagli ultimi due piani dell’edificio più la terrazza, da cui si vedeva il mare. La mia matrigna stendeva il bucato sulla terrazza e ogni volta mio padre s’incazzava. «Possibile che devo sempre ricevere i miei ospiti fra le lenzuola bagnate? Che figura ci faccio?» Io non avevo niente contro la mia matrigna, a parte il fatto che non era mia madre. E che ripeteva sempre le cose, come un disco rotto.
Al centro della terrazza c’era il taifor con la tovaglia di stoffa rossa e arancione e ricami dorati che riflettevano la luce del sole. C’era sempre un pacchetto di sigarette sul tavolino e bicchieri di vetro colorato per il tè. Mio padre invitava a casa gli uomini che sperava investissero nei suoi commerci e li portava sulla terrazza a vedere il mare. In quelle occasioni tirava fuori il whisky e lo versava agli ospiti con uno sguardo lascivo, che mi dava il voltastomaco. C’erano decine di posti in città dove potevi comprare liquori. Alcuni avevano in vetrina pacchetti di fazzolettini di carta e scatolette per gatti, ma bastava inoltrarsi nella bottega per scoprire file di Johnnie Walker e Glenmorangie, birre estere e vino del Marocco.
Quando aveva gente, mio padre mi diceva di andare a studiare, e io scendevo nella mia stanza, sul retro della casa, e aprivo, svogliatamente, i testi di economia. Da piccolo me l’ero sempre cavata bene a scuola, ma solo perché ero bravo in francese. L’avevo imparato da mia madre, che era per metà francese. Suo padre, infatti, veniva da una famiglia di coloni francesi stabilitisi in Algeria, i cosiddetti pieds noirs, chiamati così per via delle loro scarpe di cuoio lucido. Di solito i coloni si sposavano fra loro, ma mio nonno si era invaghito di una giovane di Orano – la mia nonna algerina – e l’aveva presa in moglie. Si erano trasferiti in Marocco e poi a Parigi, dov’era nata mia madre, Hanan. Non so perché se ne fossero andati, forse avevano capito che in Algeria le cose si mettevano male. Mio nonno voleva bene a sua moglie e in segno di rispetto aveva dato un nome arabo alla loro figlia, chiamandola Hananche vuol dire “pietà” o “clemenza”.
Mia madre era cresciuta a Parigi e avrebbe fatto bene a rimanerci ma, purtroppo, a poco più di trent’anni, si era recata in Marocco in visita a dei cugini e aveva avuto la disgrazia di conoscere e sposare Malik Zafar, l’imprenditore di mezza tacca che nel 1986 sarebbe diventato mio padre.
Mia madre morì quando avevo dieci anni. O nove. Allora non mi rendevo conto di quanto fosse malata e, uscendo per andare a scuola, le dicevo che forse al mio ritorno l’avrei trovata guarita da quel brutto “raffreddore”. Però ricordo che era magra e non riusciva quasi a parlare. In seguito mi venne detto che aveva un cancro all’esofago, anche se non sapevo cosa volesse dire. Un francese fluente è l’unica cosa che mi sia rimasta di lei.
Per un po’, frequentai l’American School di Tangeri, dove le lezioni erano in inglese e le ragazze vestivano all’occidentale. Ci insegnavano anche la lingua e la letteratura araba, ma l’istituto si rivelò troppo costoso per mio padre. E così mi mandò in una scuola pubblica della Ville Nouvelle, dove non studiavo affatto e fui ammesso all’università per il rotto della cuffia.
All’università c’erano più ragazze. E la signorina Aziz, che insegnava scienze politiche. Folti capelli neri che le arrivavano alle spalle e alla luce della finestra prendevano una sfumatura vermiglia. Portava quasi sempre i pantaloni, ma una volta arrivò con una gonna nera e una camicetta bianca, e tre file di perline rosse intorno al collo. Purtroppo solo verso la fine della lezione mi accorsi della trina bianca che faceva capolino da sotto la gonna, stagliandosi contro il nero delle calze di nylon.
Studiavo Economia, una materia davvero noiosa, ma mio padre non mi aveva dato scelta. Scienze politiche era un esame obbligatorio e conteneva un po’ di storia. Un giorno la signorina Aziz ci parlò delle guerre dell’Ottocento e della conquista del Nord-Africa da parte degli europei. Parlava dei colonizzatori come se non fossero propriamente esseri umani, diceva che erano popoli di grande cultura ma con una sete di sangue che nessuna opera d’arte, per quanto grandiosa, poteva compensare.
Tutto questo mi suonava nuovo. Non sapevo quando gli europei fossero sbarcati nel mio paese, né cosa volessero da noi, ma avevano lasciato molte tracce dietro di sé: chiese, monumenti e nomi di strade. Ascoltando la signorina Aziz descrivere spagnoli e francesi come creature di un’altra specie, mi chiedevo se anche loro ci avessero visto così la prima volta che erano arrivati in Nord-Africa: predoni primitivi su una striscia di sabbia, con alle spalle un deserto smisurato. Predoni, ma con una loro religione.
In apparenza, la signorina Aziz sembrava a posto. Rispondeva pazientemente alle domande di noi studenti e quando il professor Ahmed, direttore della facoltà, infilava la testa nella porta e chiedeva di parlare con lei, posava subito il libro e si affrettava a seguirlo. Tuttavia, sembrava sempre avere la testa da un’altra parte. Era gentile con tutti, perfino con Hamid, il bidello sdentato che noi studenti prendevamo in giro per il suo culone, e non ce la vedevo ad alzare la voce durante le riunioni degli insegnanti. Eppure qualcosa mi diceva che aveva un’anima ribelle..
Laila, la mia ragazza, l’aveva ribattezzata “la Messaggera”, come il protagonista di una serie TV americana, in cui una famiglia adottava un figlio che in seguito si rivelava un alieno. Gli altri bambini della famiglia lo supplicavano di portarli sul suo pianeta natale, ma il Messaggero – che aveva un aspetto del tutto normale, a parte due dita in più e la capacità di spostare gli oggetti con il pensiero – era troppo grato ai genitori adottivi per portare i fratellini in gita nel cosmo, anche solo per un giorno. Penso che ci fosse sotto un messaggio di tipo moralistico: anche se hai una vita di merda, devi continuare a crederci e non arrenderti mai.
Mentre mio padre mesceva il whisky agli ospiti (che bevevano, ma non investivano un quattrino), io cercavo invano di studiare. Che noia! Chi se ne importava della storia, anche se a insegnarla era una signorina Aziz? A che serviva ricordare cose accadute prima che tu fossi nato? E comunque era impossibile “ricordarle”: noi non c’eravamo e non c’erano neanche i nostri insegnanti, per cui nessuno poteva ricordarle, in senso stretto. Tutt’al più le potevamo immaginare… Ma perché?
Se non erano i sogni di fuga, era il pensiero di Laila a distrarmi. Invece di studiare la distribuzione del reddito, le mandavo messaggini con lo smartphone che mi aveva passato quando suo padre gliene aveva comprato uno nuovo. A volte mi rispondeva con una foto di lei che giocava col cane o beveva una Fanta sulla veranda di casa sua.
Non avevamo ancora fatto l’amore. Avevo diciannove anni e non l’avevo ancora fatto con nessuna. Quando Laila era arrivata al college, i miei compagni non si erano quasi accorti di lei, forse perché all’epoca portava i capelli corti, come i maschi, e loro sbavavano per le bionde con i capelli lunghi, che vedevano solo in fotografia. Ma io avevo notato come le si gonfiava la camicetta quando si sporgeva in avanti, anche se la portava abbottonata fino in cima. Laila vestiva sempre in maniera modesta, ma si capiva che era roba fine. Forse si faceva mandare i vestiti dall’estero o li comprava online. Rideva sempre e all’inizio temevo che ridesse anche di me, ma poi mi ero reso conto che la sua era semplice spensieratezza. Anche lei andava pazza per The Messenger ed era stata quella la scintilla. «Mi piace un sacco, e a te?» aveva detto un giorno che era venuto fuori il discorso. «Mi piace la sua capacità di sorprendere…»
Ogni sera, verso il tramonto, salivo a fumare una sigaretta in terrazza e guardavo il mare, in direzione dell’Europa. Dalla parte opposta, ovvero alle spalle della città, gli alberi e le colline cedevano quasi subito al deserto. Una distesa di sabbia marrone segnata dalle cave, con i camion parcheggiati e i nastri trasportatori.
A nord, invece… Cosa c’era laggiù, al di là del mare? La Spagna e la Francia, le terre da cui erano venuti gli invasori… E più lontano, la Germania. In Europa, tutti avevano automobili nuove e begli orologi. Gli abiti che indossavano erano di marca, non contraffatti dai cinesi come i nostri. Le ragazze erano bionde e portavano la gonna corta, mostrando le gambe. I bar non erano nascosti negli hotel di lusso o nei vicoli malfamati, dove rischiavi di buscarle. I liquori erano serviti a ogni angolo di strada e anche le donne potevano bere in pubblico.
Questo immaginavo, fumando la mia sigaretta, con negli occhi le nuvole basse e il mare grigio solcato da una nave portacontainer.
Sapevo che dovevo andarmene, ma non trovavo il coraggio. Mio padre sarebbe diventato una furia, se gli avessi detto che intendevo mollare l’università. Era convinto che quei quattro anni di studio mi sarebbero serviti, che solo grazie alla laurea avrei potuto farmi una vita. C’era soltanto un modo per evitare tutto questo: tagliare la corda. A trattenermi era solo Laila, la flebile speranza di andare a letto con lei.
Laila viveva in una villa appena fuori città. A casa sua vestiva all’occidentale, con gonne e short di jeans, che lasciavano vedere le sue gambe dalla pelle color miele. Aveva la governante, Farida, una donna sui trentacinque anni, con gli occhi grandi e mansueti di una mucca. Adorava Laila, che era l’unica persona capace di strapparle un sorriso. La vedevi girare per casa, posare tazze, svuotare portacenere o, nel corridoio, con le braccia ingombre di panni destinati alla lavanderia sul retro della villa. A volte, sdraiato sul letto, immaginavo Farida che chiamava Laila nella sua stanza perché la aiutasse a spogliarsi e lavarsi alla fine di una lunga giornata di lavoro. Nelle mie fantasie si denudavano a vicenda e facevano la doccia insieme…
Però non potevo abbandonarmi più di tanto a quelle fantasticherie, perché temevo sempre che qualcuno mi vedesse. A separare la mia stanza dal ballatoio, infatti, era solo il moucharabia, un paravento di legno traforato, e chiunque poteva sbirciare dalle fessure. Ma era così per tutti al mio paese: vivevi sempre nel timore di essere spiato.
Laila aveva un fratello minore, Billy, e una sorellina, Najat, che venivano a curiosare mentre guardavamo la TV insieme o giocavamo a carte, ma non si trattenevano mai a lungo. Una volta, a scuola avevo difeso Billy da un suo compagno prepotente, per cui era gentile con me. Gli avevo anche regalato una delle mie magliette dei Radiohead. Era un tipo sveglio, Billy, e cresceva in fretta: presto mi avrebbe mangiato in testa.
Ero innamorato di Laila perché mi aveva fatto capire che prima o poi sarebbe venuta a letto con me? Non lo so, ma era difficile. I giorni passavano e non succedeva niente. Una vera sofferenza, però se avessi potuto scegliere tra andare con Laila o farmi tutte le dodici ragazze del nostro corso, non avrei avuto dubbi. Anche se tra le dodici c’erano due strafighe come Wasia e Kashira.
Non parlavo mai di lei con i miei amici. Il sesso era sempre al centro dei nostri discorsi ma, se qualcuno tirava fuori il nome di Laila, cambiavo argomento. Pensavo spesso a come doveva essere bello sentire il mio zib che scivolava dentro di lei, immaginavo una sensazione di calore, un calore forte, ma dolce… E ogni volta che ci pensavo, naturalmente, mi veniva duro.
La mia matrigna non lavorava. Come tutte le donne che conoscevo, stava quasi sempre in casa e usciva solo per andare a trovare le sue amiche e le sue sorelle. Non che fossimo ricchi, perché i progetti di mio padre non andavano mai in porto, ma non eravamo nemmeno poveri come la maggior parte degli abitanti della medina. Per esempio, avevamo una domestica, una donna tracagnotta e immusonita, che veniva un giorno alla settimana a fare i lavori per una manciata di monete. A cucinare invece era la mia matrigna. Credo che le piacesse. Un’altra cosa che le piaceva erano gli uccelli e teneva due usignoli in gabbia. «Mi ricordano la mia infanzia sui monti del Rif» diceva. Lasciava sempre aperta la porta della terrazza, in modo da offrire una via di fuga a quelli che penetravano nel cortile, intorno a cui era costruita la nostra casa. Gli uccellini dal becco dorato ritrovavano sempre la via del cielo.
Un paio di giorni dopo che l’uomo dello specchio mi aveva parlato, cercai su Internet i voli, ma erano troppo cari per me. Forse potevo prendere uno dei traghetti per l’Europa di cui parlavano i manifesti appesi su tutti i muri della città.
È tempo di partire… D’accordo, allora tanto valeva che smettessi di torturarmi, vedendo Laila tutti i giorni. Quanto allo studio, sapevo che difficilmente sarei riuscito a laurearmi e, anche se ce l’avessi fatta, non sarebbe bastato a procurarmi un lavoro decente. Avrei conseguito una laurea in Economia e commercio con un’infarinatura di storia, grazie alle lezioni della signorina Aziz. Nessuno mi avrebbe assunto per questo. Vai al cantiere, cretino, mi avrebbero detto, e mettiti in fila con i muratori e i lattonieri. No, dovevo andarmene a… da qualche parte. Ovunque. In un posto normale. Magari a Parigi.
Non sapevo quasi nulla di Parigi, ma era in Europa, dove la gente era cristiana e c’erano bar, ragazze, palazzi antichi, cinema… Per cui, prima di perdere il coraggio, balzai giù dal letto. Mentre varcavo la porta del soggiorno, però, capitò una cosa strana: era come se mi vedessi da fuori, un ragazzo con i jeans e la maglietta, due nèi sul mento, braccia magre e capelli scarmigliati.
Mi vidi mentre andavo a dirlo a mio padre.
Ecco Tariq che entrava nella stanza. Il padre era seduto su un divano e aveva messo gli occhiali per leggere alcuni documenti.
«Che vuoi?» mi disse. «Non vedi che ho da fare?»
«Scusami» disse Tariq. «Cosa sono quei fogli?»
«Contabilità. Non si finisce mai. E tu non hai da studiare?»
«No» disse Tariq, togliendosi i capelli dalla fronte.
«Fra un’ora ceniamo. Puoi parlarmi a tavola. Così ci sarà anche la tua matrigna, lo sai che ci tiene».
«Ho deciso di andarmene».
«Dio, dammi la forza! Vuoi smettere di studiare?»
«Sì. Ma non è questo il motivo».
«E qual è, allora?»
«Voglio vivere in un altro posto, un posto migliore».
Mio padre posò le carte e scoppiò a ridere. «Dove? A Fez? Algeri? Lo so che ti piacciono le grandi città».
«Veramente pensavo a qualcosa di più grande…»
«Cioè? La Malesia?» disse mio padre, ridendomi in faccia. «O l’Australia? Perché no, potresti allevare pecore».
«Parigi».
«E che ci vai a fare a Parigi? Non conosci nessuno».
«Voglio vedere il posto dov’è cresciuta mia madre. Scoprire qualcosa di più su di lei. Conosco la lingua».
«Pensi che capiranno il tuo accento? E poi i francesi ci odiano. Ci hanno sempre odiato».
Tariq si sfregò il mento. «Non credo che ce l’abbiano con me. Penso che riuscirò ad ambientarmi. Ci sono molti di noi lassù».
«Sì, in quei sudici palazzoni nelle banlieue».
«Non m’importa dove andrò a vivere».
«E come camperai?»
«Farò il bracciante». Tariq ci pensò su un momento. «O l’eroe».
Mio padre si asciugò gli occhi con il fazzoletto. «E come farai con i soldi?»
«Non ne ho bisogno» disse Tariq. «Ce la farò grazie al mio ingegno».
«Il tuo ingegno!»
«E me la cavo anche con l’inglese».
«Sì, quello che hai imparato dai telefilm americani!»
«E il francese…»
«Piantala di dire fesserie» disse mio padre, ricomponendosi. «E vai a studiare, piuttosto».
Inforcò gli occhiali e riprese in mano le carte. Tariq iniziò a indietreggiare lentamente, sperando che suo padre lo fermasse. Indugiò presso la porta, le dita sulla maniglia.
«Be’?» fece mio padre, sollevando lo sguardo. «Che stai aspettando?»
In camera mia, tirai fuori lo zaino e c’infilai qualche vestito. Presi il passaporto e i miei pochi risparmi, compresi gli euro che mi aveva dato un turista spagnolo cui avevo fatto da guida. Poi andai in bagno e rimasi a guardarmi per un po’ allo specchio. La luce non era bella come la volta precedente e avevo il viso unticcio.
Fanculo! pensai. Muoviamoci.
Dopo aver camminato per una quindicina di minuti, mi feci dare un passaggio da un camionista. Le casse di Sprite e limonada alle nostre spalle sbattevano a ogni scossone. L’autista mi offrì una sigaretta. Quando passammo davanti alla villa di Laila vidi, dalla cabina, il prato al di là del muro di cinta e le applique accese sulla veranda. Avrei voluto che uscisse di casa, ma sapevo che non avrei sopportato di vederla. Mi mancò il respiro, come se qualcuno mi stesse strizzando i polmoni. Cazzo, è così che ci si sente quando si ha un infarto?
Chiusi gli occhi e mi lasciai trasportare dalla strada.
Forse non dovrei dire in che modo raggiunsi l’Europa. Una lunga nottata nel retro soffocante di un camion… Un ricordo su cui preferisco sorvolare. Di sicuro Marsiglia non era come l’avevo immaginata e un terminal merci non è il posto ideale per iniziare una nuova avventura.
Ma avere diciannove anni ha i suoi vantaggi. Per esempio, riesci a dormire ovunque: su una spiaggia, in un campo o, come nel mio caso, fra due pallet sul pianale di un autocarro.
Non ero neanche indolenzito, la mattina dopo, mentre sbirciavo fuori in attesa che uscissimo dal terminal. A un certo punto l’autista si fermò, a un semaforo, credo, e saltai giù.
La Francia, finalmente! Ma avrei potuto essere nella zona industriale di qualunque città. Si vedevano solo capannoni di cemento e TIR. Di vagamente umano c’erano soltanto i cartelli stradali: Saint-Martin-de-Crau, Martigues… Però anche quel buco di culo aveva un aspetto prospero ai miei occhi: quanto carburante dovevano bruciare gli autisti per spostare i bestioni carichi di merci, i giganteschi autoarticolati rossi della Norbert Dentressangle. Mi avviai verso quella che mi parve un’area di servizio, ma era in realtà una pesa.
Un’ora dopo ero nel bar di un distributore di benzina, dove mangiai un tramezzino al formaggio avvolto nel cellophane. Non avevo abbastanza euro per andare a Parigi in treno, così non mi restava che fare l’autostop. Sapevo che Lione era nella direzione giusta e Bordeaux no, ma immaginavo che la maggior parte dei camion fosse diretta a Parigi, per cui l’importante era trovare qualcuno disposto a darmi un passaggio.
Le toilette erano spaventose, un fetore tremendo e pavimenti luridi, come se ci fosse un’epidemia di dissenteria. Sarà così anche nelle case, pensavo, con le piastrelle imbrattate e il piscio ovunque? Mi detti una lavata alla bell’e meglio, ma stavo quasi per vomitare.
Tornato al bar, vidi una ragazza da sola. Aveva i capelli castani e l’aria di chi non dorme da giorni. Dimostrava quattro o cinque anni più di me e non distolse lo sguardo quando si accorse che la fissavo, per cui ordinai un caffè e andai a sedermi al tavolino accanto al suo…