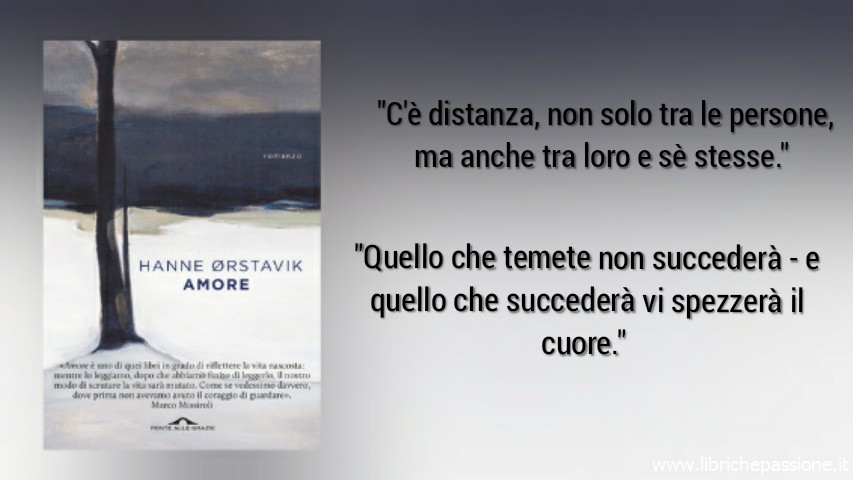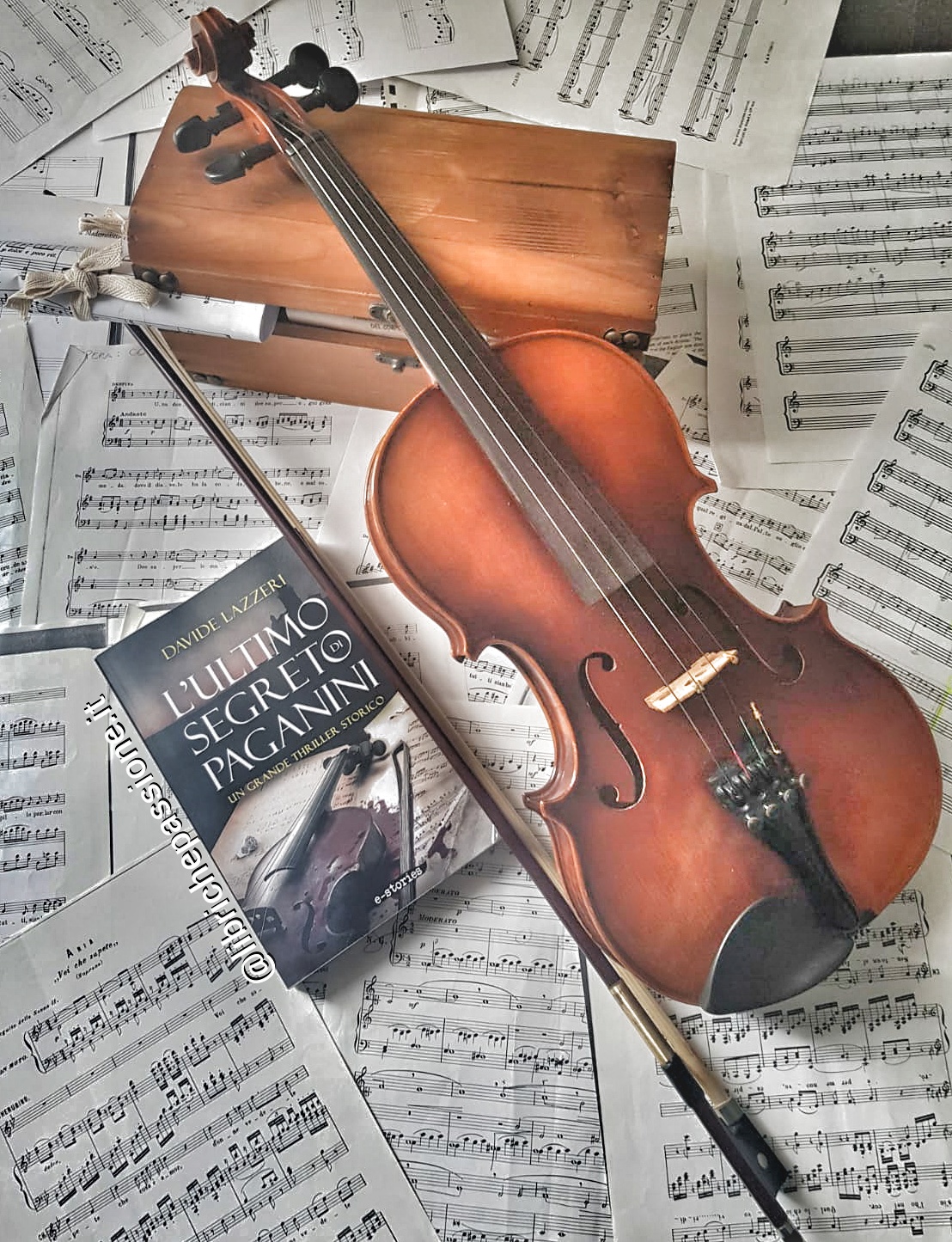Sinossi
1617, Norvegia nordorientale. In una funesta vigilia di Natale, il mare a Vardø si è improvvisamente sollevato e una folgore livida ha sferzato il cielo. Quando la tempesta si è acquietata in uno schiocco di dita, così com’era arrivata, le donne si sono raccolte a riva per scrutare l’orizzonte. Degli uomini usciti in barca non vi era, però, nessun segno. Quaranta pescatori, dispersi nelle gelide acque del Mare di Barents. Alla ventenne Maren Magnusdatter, che ha perso il padre e il fratello nella burrasca, e a tutte le donne di Vardø non resta dunque che un solo compito: mettere a tacere il dolore e cercare di sopravvivere. Quando l’inverno allenta la presa e le provviste di cibo sono quasi esaurite nelle dispense, le donne non si perdono d’animo: rimettono le barche in mare, riprendono la pesca, tagliano la legna, coltivano i campi, conciano le pelli. Spinte dalla necessità, scoprono che la loro unità può generare ciò che serve per continuare a vivere. L’equilibrio faticosamente conquistato è destinato, però, a dissolversi il giorno in cui a Vardø mette piede il sovrintendente Absalom Cornet, un fosco e ambiguo personaggio distintosi, in passato, per aver mandato al rogo diverse donne accusate di stregoneria. Absalom è accompagnato dalla giovane moglie norvegese, Ursa, inesperta della vita e terrorizzata dai modi sbrigativi e autoritari del marito. A Vardø, però, Ursa scorge qualcosa che non ha mai visto prima: donne indipendenti. Absalom, al contrario, vede solo una terra sventurata, abitata dal Maligno. Un luogo ai margini della civiltà, dove la popolazione barbara dei lapponi si mescola liberamente con i bianchi e dove una comunità di sole donne pretende di vivere secondo regole proprie. Romanzo che trae ispirazione dai processi alle streghe di Vardø del 1620, Vardø. Dopo la tempesta «getta luce su uno spaventoso spaccato di storia, raccontando la brutale sottomissione delle donne, la superstizione che aleggia nei luoghi isolati e le atrocità compiute in nome della religione. Un romanzo davvero potente» (Publishers Weekly).
Estratto
A mia madre Andrea
e a tutte le donne che mi hanno (ac)cresciuta
PER ORDINE DEL RE
Se uno stregone, o un fedele, pur disponendo del sacrificio di Dio, della sua Santa Parola e Cristianità ciò nondimeno si dedica al diavolo, allora verrà gettato nelle fiamme e ridotto in cenere.
Da Decreto sulla stregoneria (Trolddom),
Danimarca-Norvegia 1617
Attuato nella contea di Finnmark, 1620
Burrasca
Vardø, Finnmark
Norvegia nordorientale
1617
Quella notte Maren sognò che una balena si era arenata sugli scogli davanti a casa sua.
Era scesa dalla scogliera fino al corpo ansimante, aveva appoggiato l’occhio contro l’occhio della balena e abbracciato la grande massa puzzolente. Per lei non poteva fare altro che quello.
Gli uomini erano calati in massa dalle rocce come insetti rapidi e neri, i corpi massicci in un baluginio di lame e falci.
Avevano cominciato a squarciare e tagliare prima ancora che fosse morta.
La balena sussultava e tutti loro spietati la trattenevano con tenacia come reti tese attorno a un banco di pesci, e a Maren crescevano braccia sempre più lunghe e possenti – la stringeva tutta, forte – fino a non sapere più se era un conforto o una minaccia e non le importava, fissava solo l’occhio con il suo occhio, senza un battito di ciglia.
Alla fine la balena era rimasta immobile, il respiro che si dissolveva mentre loro tagliavano e segavano. Maren aveva sentito l’odore del grasso di balena che bruciava nelle lampade prima che smettesse di muoversi, molto prima che il guizzo lucente dell’occhio sotto il suo occhio si spegnesse in un’opacità smorta.
Piombò dentro le rocce fino al fondo del mare. Lassù la notte era scura e senza luna, le stelle graffiavano la superficie. Annegò ed emerse dal sonno soffocando, il fumo nelle narici e nel fondo oscuro della gola. L’odore di grasso bruciato le rimase sotto la lingua e non andò via.
1.
La burrasca arriva in uno schiocco di dita. Così ne parleranno nei mesi e negli anni a venire, quando smetterà di essere solo un dolore sordo dietro agli occhi e un’oppressione alla base della gola. Quando infine entrerà nelle storie. Ma nemmeno così si potrà spiegare com’è stata davvero. Per certe cose le parole non bastano: definiscono con troppa facilità, poco accorte. E non c’era grazia né naturalezza in quello che Maren ha visto.
Quel pomeriggio la vela migliore è distesa come una coperta sulle sue ginocchia, Mamma e Diinna sono agli altri angoli. Le loro dita più minute e precise rammendano con punti più minuti e precisi gli strappi causati dal vento, mentre lei cuce le toppe sui buchi lasciati dai fissaggi all’albero.
Accanto al fuoco si asciuga un fascio d’erica bianca, che suo fratello Erik ha tagliato e portato giù dalle basse montagne della terraferma. Domani, poi, mamma gliene darà tre mazzi per il suo cuscino. E allora lei la sminuzzerà per infilarla nella federa, terra e tutto, il profumo dolciastro quasi stucchevole dopo mesi di odore stantio di sonno e di capelli mai lavati. Ci affonderà i denti e urlerà, fino a intasarsi i polmoni di quell’aroma soave e terroso.
Ma adesso qualcosa le fa sollevare la testa per guardare fuori dalla finestra. Un uccello, scuro su fondo scuro, un suono? Si alza per sgranchirsi, per guardare la baia piatta e grigia e il mare aperto dietro, le creste delle onde che scintillano come frammenti di vetro. Le barche sembrano mollemente agganciate sulla superficie con le due luci, a poppa e a prua, che tremolano appena.
Immagina di poter distinguere quella di Pappa e di Erik dalle altre, con la seconda miglior vela allacciata stretta all’albero. Il ritmo a strappi della remata, le schiene rivolte all’orizzonte dove si nasconde il sole, già lontano da un mese e per un altro mese ancora. Gli uomini vedranno le luci immobili delle finestre senza tende di Vardø, perse nel loro mare di terra in penombra. Sono già al largo oltre Hornøya stac1, quasi al banco di pesci avvistato nel primo pomeriggio, che la balena ha messo in fuga.
«Se ne sarà già andata da un pezzo» ha detto Pappa. Mamma ha il terrore delle balene. «Si sarà già riempita la pancia prima che Erik riesca a portarci laggiù con quelle lische di pesce che ha per braccia». Erik si è limitato a chinare il capo per ricevere il bacio di Mamma e da sua moglie la pressione del pollice sulla fronte, che per i sámi serve a tendere un filo per riportare gli uomini a casa. Per un attimo le ha posato una mano sul ventre sottolineandone la rotondità sotto la tunica di lana. Lei gliel’ha scostata, ma con dolcezza.
«Lo farai uscire prima del tempo. Lascialo stare».
In seguito Maren rimpiangerà di non essersi alzata a baciarli tutti e due sulle guance ruvide. Rimpiangerà di non averli guardati mentre raggiungevano il mare con addosso le pelli di foca cucite a mano, il padre con la sua andatura tesa ed Erik che lo seguiva dinoccolato. Rimpiangerà di non avere provato qualcosa di più quando se ne sono andati, più della gratitudine per quel tempo da sola con Mamma e Diinna, per il conforto di altre donne.
Perché a vent’anni, tre settimane dopo aver ricevuto la sua prima proposta di matrimonio, si considerava finalmente una di loro. Dag Bjørnsson stava facendo della seconda rimessa per barche di suo padre una casa per loro, l’avrebbe finita prima dell’inverno e si sarebbero sposati.
Dentro, le aveva detto alitandole un respiro caldo e pungente dietro l’orecchio, ci sarebbero stati un bel focolare e una dispensa separata, per evitargli di attraversare la casa con la scure in mano come faceva Pappa. Quel luccichio sinistro, persino nelle mani attente di Pappa, le faceva salire la bile in gola. Dag lo sapeva, si era dato pena di saperlo.
Era biondo come la madre, con lineamenti delicati che, Maren lo sapeva, gli altri uomini scambiavano per debolezza, ma a lei non importava. Non le importava quando le sfiorava il collo con la bocca generosa, mentre le parlava delle lenzuola che lei doveva tessere per il letto che lui stava costruendo. E anche se non provava niente quando le accarezzava esitante la schiena, troppo lievi e troppo in alto quelle carezze per sortire qualche effetto attraverso il vestito invernale blu scuro, quella casa destinata a essere sua – quel focolare e quel letto – le facevano pulsare il basso ventre. Poi di notte si premeva le mani nel punto in cui aveva avvertito il calore, le dita come sbarre fredde tra i fianchi e così insensibili da non sembrarle nemmeno le sue.
Nemmeno Erik e Diinna avevano una casa tutta per loro: abitavano nella stanza lunga e stretta che la madre e il padre di Maren avevano attaccato al muro esterno, sul retro. Il letto la riempiva tutta, premeva esattamente contro quello di Maren attraverso il divisorio. Durante le loro prime notti insieme lei aveva teso le mani sopra la testa, respirando la paglia odorosa del materasso, ma non aveva mai sentito neppure un sospiro. Fu una sorpresa quando il ventre di Diinna cominciò a crescere. Il bambino doveva arrivare appena finito l’inverno, e allora sarebbero stati in tre, in quel letto stretto.
E dopo penserà: forse avrei dovuto cercare anche Dag.
E invece ha preso la vela strappata e l’ha distesa sulle ginocchia di tutte e tre, e non ha sollevato gli occhi finché un uccello o un rumore o un cambiamento nell’aria non l’ha richiamata alla finestra a guardare le luci che si muovono sul mare scuro.
Le crocchiano le braccia: avvicina un dito indurito dall’ago all’altro e li infila sotto il polsino di lana, sente i peli che si rizzano e la pelle che si aggrinzisce. Le barche procedono ancora a forza di remi, ancora salde nella luce incerta, il baluginio delle lanterne.
E poi il mare si solleva e il cielo si abbassa e una folgore livida sferza tutto quanto, illuminando il buio con un bagliore istantaneo e terribile. Sono la luce e il rumore che attirano Mamma alla finestra, il mare e il cielo cozzano come una montagna che si spacca, lo sentono nei piedi e nella schiena, i denti di Maren le affondano nella lingua e sale rovente le brucia la gola.
E poi forse urlano tutt’e due ma non si sente, ci sono solo il mare e il cielo e le luci delle barche inghiottite e le barche che saettano e le barche che vorticano e le barche sollevate, rovesciate, sparite. Maren si lancia fuori nel vento, piegata in due nel vestito di colpo fradicio, Diinna che dalla soglia la richiama dentro, trattenendo la porta perché il fuoco non si spenga. La pioggia è un peso sulle spalle, il vento la respinge, le mani serrate strette, aggrappate al niente. Urla così forte che le resterà la gola scorticata per giorni. Attorno a lei altre madri, sorelle, figlie si gettano contro la bufera: forme scure, viscide di pioggia, goffe come foche.
La burrasca si placa prima di raggiungere il porto, a duecento passi da casa, la bocca vuota spalancata sul mare. Le nuvole si accartocciano su se stesse e le onde scemano, si adagiano ognuna sul profilo dell’altra, lievi come un gregge che si assesta.
Le donne di Vardø si raccolgono sul bordo scavato della loro isola, e anche se qualcuna grida ancora le orecchie di Maren rimbombano di silenzio. Davanti a lei l’acqua del porto è liscia come uno specchio. La mascella le si è bloccata sui cardini, dalla lingua il sangue tiepido le cola sul mento. L’ago le si è infilzato nel tessuto fra il pollice e l’indice, la ferita è un cerchietto rosa.
Mentre guarda, un ultimo lampo illumina il mare odiosamente immobile, e sulla superficie nera emergono i remi e i timoni e un albero intatto con le vele ammainate, relitti sradicati di un bosco sottomarino. Dei loro uomini nessun segno.
È la vigilia di Natale.
1. Faraglione, scoglio staccato dalla costa (N.d.T.).
2.
Durante la notte il mondo diventa bianco. La neve ricopre la neve, riempie le finestre e l’imbotte delle porte. La kirke si erge scura quel Natale, quel primo giorno, un buco nero fra le case illuminate, che ingoia la luce.
Per tre giorni restano sommerse dalla neve, Diinna isolata nella sua stanza stretta, Maren incapace di scuotersi almeno quanto è incapace di scuotere Mamma. Mangiano solo pane raffermo, che si pianta come un sasso in fondo allo stomaco. Maren lo sente così solido dentro di sé, il proprio corpo così irreale, che immagina sia solo il pane duro di Mamma a tenerla ancorata a terra. Se non mangia diventerà fumo che si raccoglie sotto il tetto della casa.
Per restare in sé riempie lo stomaco finché non le fa male, e avvicina al fuoco quanto più riesce del suo corpo. Ogni parte di lei che avverte il calore, si dice, è reale. Si solleva i capelli per scoprire il collo sudicio, allarga le dita perché il calore le lambisca, si alza la gonna finché le calze di lana non puzzano, strinate. Là, e là, e là. Il petto, la schiena, e nel mezzo il cuore, avviluppati nel corpetto invernale, stretti insieme.
Il secondo giorno, per la prima volta da anni, il fuoco si spegne. Era sempre stato Pappa ad accenderlo, loro se ne prendevano solo cura, lo coprivano di notte e rompevano la crosta al mattino per far respirare il cuore ardente. In poche ore c’è un velo di brina sulle loro coperte, anche se Maren e sua madre dormono insieme nello stesso letto. Non parlano, non si spogliano. Maren si avvolge nella vecchia pelle di foca di Pappa. Mai scuoiata a dovere, puzza vagamente di grasso rancido.
Mamma ha addosso quella di Erik di quand’era ragazzo. Ha gli occhi spenti come un pesce affumicato. Maren cerca di farla mangiare, ma la madre si raggomitola su un fianco dalla sua parte del letto e sospira come una bambina piccola. Maren è contenta che la finestra coperta di neve nasconda alla vista il mare.
Quei tre giorni sono un abisso nel quale precipita. Guarda la scure di Pappa che scintilla nel buio. La sua lingua è spessa e coperta da una patina, il punto dolente dove si è morsa durante la burrasca è gonfio e spugnoso, con qualcosa di duro al centro che la preoccupa, e il sangue le mette ancora più sete.
Sogna Pappa ed Erik, si sveglia madida di sudore freddo, le mani gelate. Sogna Dag e quando lui apre la bocca è piena dei chiodi per il loro letto. Si chiede se moriranno tutte lì, se Diinna è già morta con il bambino che nuota ancora dentro di lei, sempre più lento. Si chiede se arriverà Dio, a imporre loro di vivere.
Puzzano forte tutt’e due quando Kirsten Sørensdatter viene a disseppellirle la terza notte. Poi Kirsten le aiuta ad accatastare la legna e alla fine accende il fuoco. Quando libera l’accesso alla sua stanza, Diinna sembra quasi furiosa, il broncio del labbro inferiore riflette la luce della torcia, le mani premute ai lati del ventre gonfio.
«Kirke» dice a tutte Kirsten. «È Sabbath».
Persino Diinna, che non crede al loro Dio, non discute.
È solo quando si riuniscono nella kirke che Maren se ne rende conto: quasi tutti i loro uomini sono morti.
Toril Knudsdatter accende le candele, tutte le candele, finché la luce non brilla così forte che le brucia gli occhi. Conta in silenzio. Una volta c’erano cinquantatré uomini, adesso ne sono rimasti solo tredici: due poppanti in braccio alle madri, tre bambini e gli altri ragazzi troppo giovani per uscire sulle barche. Persino il ministro è scomparso.
Le donne sono ai loro soliti posti, gli spazi vuoti dove sedevano mariti e figli, ma Kirsten ordina di spostarsi in avanti. Obbediscono tutte tranne Diinna, ottuse come pecore. Occupano tre delle sette file di panche della kirke.
«Ci sono già stati altri naufragi» dice Kirsten. «Siamo sopravvissute quando gli uomini sono scomparsi».
«Ma non sono mai stati così tanti» dice Gerda Folnsdatter. «E fra loro non c’è mai stato mio marito. E neppure il tuo, Kirsten, o quello di Sigfrid. Non c’era il figlio di Toril. Tutti loro…»
Si afferra la gola, tace.
«Dovremmo pregare, o cantare» suggerisce Sigfrid Jonsdatter, e le altre la guardano invelenite. Sono rimaste intrappolate e isolate per tre giorni e tutto quello di cui vogliono parlare, di cui possono parlare, è la burrasca.
Le donne di Vardø, tutte quante, cercano qualche segno. Uno è stato la burrasca. I corpi, che ancora devono tornare, saranno un altro. Ma adesso Gerda parla della sterna solitaria che ha visto volteggiare sopra la balena.
«A forma di otto» dice, le mani arrossate che lo disegnano in aria. «Uno, due, tre, sei giri, ho contato».
«Otto per sei non significa proprio niente» dice Kirsten poco impressionata. Si è piazzata accanto al pulpito del pastore Gursson con il leggio intagliato. Ci ha appoggiato sopra le grosse mani, i pollici che seguono le linee degli intagli sono l’unico segno del suo nervosismo, o del dolore.
Suo marito è fra gli annegati, e tutti i loro figli sono finiti sottoterra prima di aver cominciato a respirare. A Maren piace, le è capitato spesso di lavorare con lei, ma adesso vede Kirsten come l’hanno sempre vista le altre: una donna diversa. Non si è messa dietro al pulpito ma è come se lo avesse fatto: le osserva come farebbe un ministro del culto.
«Ma la balena…» dice Edne Gunnsdatter, la faccia così gonfia per il pianto da sembrare pesta. «Nuotava capovolta. Ho visto la pancia bianca che scintillava sotto le onde».
«Stava mangiando» dice Kirsten.
«Attirava gli uomini» dice Edne. «Ha mandato il banco di pesci verso Hornøya per sei volte, per essere certa che li vedessimo».
«L’ho visto» annuisce Gerda segnandosi. «L’ho visto anch’io».
«Non è vero» ribatte Kirsten.
«Ho visto il sangue che ha tossito Mattis sul tavolo una settimana fa» dice Gerda. «Non è mai stato ripulito».
«Se vuoi te lo gratto via io» dice con calma Kirsten.
«La balena era il male» afferma Toril. Sua figlia si tiene così stretta contro di lei che potrebbe essere cucita al suo fianco con i famosi punti perfetti di Toril. «Se quello che dice Edne è vero, è stata mandata».
«Mandata?» dice Sigfrid, e Maren vede che Kirsten la guarda grata, pensando di aver trovato un’alleata. «Ma una cosa del genere è possibile?»
Dal fondo della kirke giunge un sospiro, e tutto il gruppo si volta verso Diinna, che però rovescia la testa indietro, gli occhi chiusi, la pelle scura della gola che risplende dorata alla luce delle candele.
«L’opera del diavolo è oscura» dice Toril, e la figlia le affonda la faccia nella spalla e piange di paura. Maren si domanda quali terrori abbia impresso Toril nella mente dei due figli superstiti, in quei tre giorni. «Il suo potere è inferiore solo a quello di Dio. Può aver mandato lui la balena. O potrebbe essere stata chiamata».
«Basta». Kirsten spezza il silenzio prima che possa addensarsi. «Questo non ci aiuta».
Maren vorrebbe condividere la sua sicurezza, ma riesce a pensare solo alla sagoma, al rumore che l’hanno attirata alla finestra. Aveva pensato a un uccello, ma adesso nella sua mente è qualcosa di molto più grande e lento, con cinque pinne e la pancia in su. Innaturale. Impossibile impedirgli di filtrare dai margini della sua visuale, persino lì nella luce benedetta della kirke.
Mamma si scuote come da un sonno, anche se il bagliore delle candele si è riflesso nei suoi occhi spalancati fin da quando si sono sedute. Quando parla, Maren si accorge del tributo che il silenzio ha richiesto alla sua voce.
«La notte in cui è nato Erik» dice Mamma, «c’era un punto di luce rossa nel cielo».
«Me lo ricordo» dice dolcemente Kirsten.
«Anch’io» dice Toril. Anch’io, pensa Maren, anche se aveva solo due anni.
«L’ho seguita nel cielo finché non è finita in mare» dice Mamma muovendo appena le labbra. «Ha acceso l’acqua come sangue. Era segnato, lo si sapeva fin da quel giorno».
Geme e si copre la faccia. «Non avrei mai dovuto lasciarlo andare per mare».
Questo scatena una nuova ondata di pianto fra le donne. Nemmeno Kirsten riesce a placarla. Le candele guizzano come per un’improvvisa folata d’aria fredda e Maren si volta giusto in tempo per vedere Diinna che esce dalla kirke a grandi passi. Le sole parole che Maren potrebbe offrire a Mamma, mentre la stringe fra le braccia, sarebbero di amaro conforto: Per lui non c’era altro che il mare.
Vardø è un’isola, il porto sembra un morso staccato da un lato, per il resto la costa è troppo ripida o troppo rocciosa per mettere in mare le barche. Maren ha conosciuto le reti prima ancora di conoscere il dolore, le intemperie prima di conoscere l’amore. D’estate le mani di sua madre scintillano di squame di pesce, i filetti appesi fuori a salarsi ed essiccare come fasce per neonati, oppure avvolti in pelle di renna e sepolti a fermentare.
Pappa diceva sempre che era il mare a dare forma alla loro vita. Hanno sempre vissuto per sua grazia e per grazia sua sono morti. Ma la burrasca l’ha reso un nemico e discutono brevemente di andarsene.
«La mia famiglia sta ad Alta» dice Gerda. «Ci sono terra e lavoro a sufficienza, là».
«La burrasca non ci è arrivata?» chiede Sigfrid.
«Lo sapremo presto» dice Kirsten. «Immagino manderanno notizie da Kiberg… lì deve essersi abbattuta di sicuro».
«Mia sorella mi manderà un messaggio» annuisce Edne. «Ha tre cavalli, e a cavallo ci vuole solo un giorno di galoppo».
«E una traversata difficile» dice Kirsten. «Il mare è ancora grosso. Ci vorrà tempo per raggiungerci».
Maren ascolta mentre le altre parlano di Varanger, o di Tromsø, ancora più esotica, come se qualcuna di loro potesse anche solo immaginare la vita in città, e così lontano. Battibeccano un po’ su chi prenderà le renne da trasporto che appartenevano a Mads Petersson, affogato insieme al marito e ai figli di Toril. Toril sembra convinta che questo le conferisca un qualche diritto, ma quando Kirsten annuncia che si occuperà lei delle renne nessuno ha da ridire. Maren non riesce neppure a immaginare di accendere un fuoco, figurarsi governare per tutto l’inverno una mandria di bestie eccitabili. Probabile che anche Toril la pensi allo stesso modo, perché lascia cadere la rivendicazione più in fretta di quanto l’ha avanzata.
Alla fine la discussione si placa, si spegne. Non hanno deciso niente, se non che aspetteranno notizie da Kiberg, oppure manderanno a chiederne se non si saprà niente entro la settimana.
«Fino ad allora è meglio incontrarci tutti i giorni qui nella kirke» dice Kirsten, e Toril annuisce convinta, per una volta d’accordo. «Dobbiamo prenderci cura una dell’altra. Le nevicate sembrano finite, ma non si può mai dire».
«Attente alle balene» dice Toril e con la luce che le colpisce la faccia Maren scorge le ossa sotto la pelle. Ha un’aria sinistra e Maren vorrebbe ridere. Si morde la lingua già dolente.
Non si parla più di andare via. Scendendo dalla collina verso casa, con Mamma che le si aggrappa al braccio così forte da farle male, Maren si chiede se anche le altre si sentano come lei: vincolate a quel posto, adesso più che mai. Balena o no, segni o no, Maren ha assistito alla morte di quaranta uomini. Adesso qualcosa in lei è legato a quella terra, legato come in una trappola…