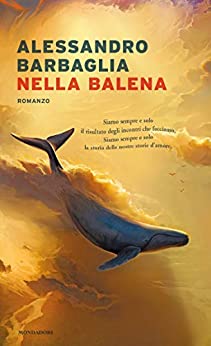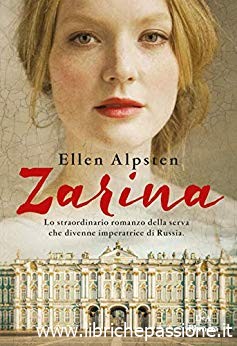Una madre perfetta
Una madre perfetta
Autrice: Kimberly Belle
Casa editrice: Newton Compton
Data di pubblicazione: 23 Luglio 2019
Trama
l miglior thriller da leggere durante le vacanze
Autrice del bestseller Il matrimonio delle bugie
Quando Kat Jenkins viene svegliata nel cuore della notte da un agente di polizia, il suo peggior incubo diventa realtà: suo figlio Ethan, di soli otto anni, è scomparso nel nulla durante una gita scolastica dopo uno strano incendio. Sconvolta per l’accaduto, Kat si precipita sul luogo, ma è tardi: le autorità sono già di ritorno dopo che le ricerche si sono rivelate vane. Le tracce di Ethan, infatti, si perdono nella foresta alle pendici delle montagne. Stef Huntington è una donna influente nella comunità e la sua posizione, i suoi soldi e la popolarità di suo marito, sindaco di Atlanta, l’hanno resa un punto di riferimento per tutte le mamme della scuola. Conosce Kat solo di sfuggita, ma ha sentito voci sul suo conto che si riferivano a un passato traumatico. Stef e Kat vengono da due mondi completamente opposti, eppure le loro strade stanno per incontrarsi. E la loro disperata ricerca della verità potrebbe presto trasformarsi in una corsa contro il tempo destinata a sconvolgere per sempre le loro esistenze.
Un’autrice bestseller
Pubblicata in 17 paesi
Una normale gita scolastica si è appena trasformata nel peggiore incubo
«Un ottimo thriller sostenuto da una scrittura brillante, personaggi credibili e una trama sensazionale. Ho divorato questo libro in una notte.»
Julia Heaberlin
«Un altro successo di Kimberly Belle che intrattiene alla grande.»
Library Journal
«Intrigante e pieno di suspense. Ai lettori piaceranno queste due protagoniste così diverse.»
Publishers Weekly
Estratto
Ai miei genitori,
che hanno sempre fiducia
KAT
Le email di lavoro già mi invadono il telefono mentre controllo che Ethan sbrighi la routine mattutina. Alzati. Vestiti. Per amor del cielo, lavati i denti, pettinati. Nei suoi brevi otto anni di vita mio figlio non è mai stato un tipo mattiniero, e io non sono mai stata una madre paziente, neanche quando non avevo un capo che mi cronometrava dal momento in cui mettevo piede fuori dall’ascensore.
Non che le mamme casalinghe non abbiano stress da vendere, ma almeno in questo io ed Ethan eravamo solidali, membri di una stessa squadra che camminava in punta di piedi sui gusci d’uovo lasciati in giro da Andrew. Negli ultimi sei mesi, dalla separazione, abbiamo preso, però, quest’abitudine. Ethan perde tempo e io lo assillo.
«Dai, tesoro, dobbiamo andare».
I capelli gli stanno ancora per aria nel punto in cui erano appoggiati al cuscino. Ha la maglietta macchiata e spiegazzata, quindi probabilmente l’ha estratta dal mucchio sporco in terra. Mio figlio è di un’incorreggibile sciatteria. È scoordinato e decisamente goffo. Ha le orecchie troppo grandi, i ricci arruffati e gli occhiali, perennemente sporchi di ditate, non gli stanno mai dritti sul naso.
Ma lo amo con tutta me stessa. E non malgrado le sue pecche, ma proprio per quelle. Se c’è una cosa che Andrew mi ha insegnato, è che non si può amare una persona a pezzi. Bisogna
amarla tutta intera, anche le parti peggiori.
Lo spingo di corsa giù per le scale, attraverso lo stretto corridoio e fuori dalla porta sul retro. La nostra minuscola proprietà non è granché, ma divorziare costa e ogni volta che l’avvocato pensa che ci siamo, Andrew se ne esce con un altro assurdo ultimatum. Il tavolino d’antiquariato che abbiamo comprato in luna di miele. Un paio di candelabri di cristallo che ha rotto secoli fa. I negativi delle foto di Ethan da piccolo. Finché quello che vuole non è Ethan, soddisfo ogni sua richiesta.
Ethan si ferma davanti alla macchina, ancora semiaddormentato. «Cosa aspetti? Sali».
Non si muove. Guardo l’ora sul cellulare: sei e ventisette.
«Ethan». Visto che non mi risponde, lo scuoto leggermente per la spalla. «Dai, amore. Sali in macchina. Altrimenti perderai il pullman».
Che parte esattamente tra trentatré minuti, da un’area di parcheggio dall’altra parte della città. Meta di oggi: Dahlonega, una vecchia città della corsa all’oro un’ora a nord di Atlanta. La classe di Ethan si aggirerà per miniere sessanta metri sottoterra, in cerca di oro e pietre semipreziose, per poi dormire in uno chalet in mezzo ai boschi. Quando mi ha portato il modulo di autorizzazione il mese scorso, credevo fosse un pesce d’aprile. Quale maestra porta volontariamente dei bambini di seconda elementare a passare una notte fuori?
«Ma lo facciamo tutti gli anni», mi ha assicurato la signorina Emma quando sono andata a chiedere. «Stiamo in un campo estivo dell’ymca, quindi è sicurissimo. Un insegnante o accompagnatore ogni cinque alunni. I ragazzi lo aspettano con ansia tutto il semestre».
Lo stesso discorso la maestra l’ha fatto a tutte le mamme iperprotettive della seconda, ma con me non ha colto il nocciolo della questione. Non era l’incolumità fisica che mi preoccupava, ma quella emotiva. Ethan ha un quoziente intellettivo di 158, una dote che si accompagna a una particolare serie di problemi. È un bambino brillante, ma impacciato dal punto di vista sociale. Un pensatore analitico che ha bisogno di stimoli costanti. Uno studente insaziabile con un infinito flusso di domande. Il modo di parlare, gli interessi, i pensieri, il suo mondo sono così diversi da quelli dei coetanei che non esiste praticamente alcun punto di contatto. Sono due anni che sta alla Cambridge e non ha invitato a casa un solo amico. Niente compagni, niente festicciole. Niente di niente.
Ma è tutta la primavera che a scuola fanno lezioni sulle miniere e la signorina Emma gli ha riempito lo smisurato cervello con storie di chiuse idrauliche, reti di gallerie sotterranee, vene metallifere, così mi ha informato mio figlio. E fino a stamattina, non vedeva l’ora di vedere tutto di persona, malgrado non abbia mai dormito in un letto che non si trovasse sotto lo stesso tetto mio o di Andrew. Mi ha talmente implorato che ho ceduto, ho bandito i timori e ho firmato quel maledetto modulo.
Sale sul sedile posteriore, gli lancio una barretta senza arachidi e lui la ignora.
«Che c’è, tesoro? Stai male?»
«No». Guarda l’incarto e fa una smorfia. «Non ho fame».
«Mangiala comunque. Ti servirà energia per fare tutti quei gradini su e giù per le miniere». Lo dico apposta per risvegliare un po’ del suo precedente entusiasmo.
Ma mio figlio non ci casca e mi rivolge uno dei suoi tipici sguardi. Mento basso. Sopracciglia inarcate. Occhi al cielo. Emette un sospiro talmente forte da sollevargli il corpo esile dal sedile.
«La mattina muori sempre di fame. Perché oggi no?»
«Non lo so». Gli occhiali gli scivolano giù e arriccia il naso per rimetterli a posto. Sono troppo lenti e la montatura di finta tartaruga troppo pesante per la sua testa. Ethan ha otto anni, ma ne dimostra sei, un altro dei suoi handicap. «Non ho fame e basta».
Devi smetterla di viziarlo. Sento la voce di Andrew chiara come se mi fosse seduto accanto. Altrimenti non si temprerà mai.
Tu devi. Lui mai. Questa è una delle doti più eccezionali di Andrew: attribuire colpe. Sono anni che fa pratica.
Ma Andrew non c’è e io devo andare al lavoro. Non posso permettermi la metà della retta della Cambridge Classical Academy, soprattutto con il divorzio ancora in ballo e la pila di
bollette accanto al tostapane, che mi terrorizza quanto a Ethan fanno paura i mostri sotto il letto. La mia capa non ha figli. Non capirebbe che il cervello da piccolo Einstein di Ethan ha bisogno più di altri di soppesare i pro e i contro. Ho bisogno di questo lavoro e quindi ho bisogno di portarlo a quel pullman. Avvio il motore ed esco a retromarcia dal vialetto.
Durante tutto il tragitto fino a scuola, osservo l’espressione di Ethan nello specchietto retrovisore. Non per la prima volta, vorrei che la separazione con suo padre non fosse stata tanto esplosiva. Che le nostre conversazioni non dovessero avvenire per iscritto e da una distanza fisica minima di sessanta metri. L’ordinanza restrittiva certo non facilita la genitorialità condivisa, soprattutto quando tuo figlio in procinto di fare una gita a Dahlonega, guarda fuori dal finestrino come se stesse andando dal dentista.
Spengo la radio, mettendo a tacere le chiacchiere del programma mattutino. «Tesoro, ti prego, dimmi cos’hai. Che c’è?».
Mi lancia una rapidissima occhiata, poi distoglie lo sguardo. Scrolla le spalle, anche se conosce la risposta. Ethan conosce sempre la risposta.
«Sei preoccupato per gli altri bambini?».
Corruga la fronte e so di aver toccato un nervo scoperto.
«C’è qualche bambino che ti infastidisce?»
Non uso di proposito il termine “bullo”. La parola che la maestra evita, insieme al nome di quello stronzetto, anche se entrambe sappiamo di chi si tratta. La signorina Emma cerca di far passare l’accaduto come un contrasto marginale, assolutamente sotto controllo. Ma il problema è anche questo. Liquida tutti gli episodi di bullismo come liti futili e irrilevanti, anche quando prendono una piega violenta.
«Se mi dici cos’è successo, posso aiutarti a risolvere la questione. Parlerò alla signorina Emma in modo che sia informata del problema. Io e la signorina Emma siamo dalla tua parte, lo sai. Vogliamo aiutarti».
«Non è niente, va bene? Non c’è nessuno che mi dà fastidio».
«Ti preoccupa dormire fuori casa?».
Nello specchietto retrovisore Ethan si acciglia.
«Non devi, sai. La signorina Emma si prenderà cura di te».
Nessuna risposta. Si accascia sul sedile, tenendosi i gomiti con le mani e tamburellando nervosamente le dita: un tic che ha quando non vuole parlare di qualcosa.
Percorriamo il resto del tragitto in silenzio.
Quando mi immetto di corsa nel viale alberato che conduce al parcheggio della Cambridge Classical Academy, non devo guardare l’orologio sul cruscotto per sapere che le sette sono già passate. Le madri tonificate dalle lezioni di yoga brulicano nell’area, bambini urlanti
corrono tra le loro gambe e la signorina Emma cammina su e giù con il telefono premuto all’orecchio. Le facce tirate sono eloquenti.
Tardi.
Entro nel primo varco che vedo, inchiodo con uno stridore di freni e scendo.
«Scusate», grido da sopra il tettuccio dell’auto. «Eccoci, eccoci. Scusate».
Ethan scende dal sedile posteriore, fermandosi a guardare i bambini che corrono per il prato. L’espressione tradisce i suoi pensieri, un desiderio talmente ovvio che sembra scritto per aria. Mi colpisce allo stomaco nel punto in cui, quando ero incinta di nove mesi, Ethan mi tirava potenti calci e il minuscolo piede quasi mi perforava la pelle. Il mio bello e brillante figliolo vorrebbe solo essere accolto dagli altri e io non so come aiutarlo.
Con un sospiro, prende dalla macchina lo zaino e se lo mette su una spalla.
Gli do un pugnetto sull’altra. «A proposito, ti ho preso una sorpresa».
Mi rivolge uno sguardo dubbioso. Ethan sa che i soldi sono pochi e le sorprese sono riservate alle occasioni speciali. «Che sorpresa?».
Apro il bagagliaio. Volta la testa per dare un’occhiata e quando i nostri sguardi si incrociano, ha gli occhi sgranati. «Mi hai preso il sacco a pelo a mummia?».
Sorrido. «Ti ho preso il sacco a pelo a mummia». Quello che desiderava con tutto sé stesso dal momento in cui l’aveva visto da Walmart. Non tanto per il cappuccio ribaltabile e il
cuscino incorporato, ma per la tasca nascosta dove mettere il pezzo consunto di copertina senza cui non riesce a dormire e che non vuole far scoprire ai compagni. «Quello che sai è già dentro, chiuso nella tasca interna».
Il sorriso che gli compare in volto vale ogni sudato centesimo.
«Ti piace?».
Afferra il rotolo e se lo stringe al petto con entrambe le braccia. Ed è talmente grande rispetto a lui che riesce a reggerlo a stento. «È fantastico».
«Ottimo. Allora forse non ti serve l’altra cosa che ti ho portato».
Socchiude gli occhi in due fessure. «Quale altra cosa?».
Prendo la borsa dal cruscotto e tiro fuori un consunto astuccio di pelle marrone.
Ethan lo riconosce e il volto gli si illumina di gioia. «La bussola del tuo bisnonno?».
O per essere precisi, la bussola da rilevamento. Risale alla metà dell’Ottocento, ha ai lati un paio di mirini a scatto in ottone e il mio bisnonno la usava per misurare le terre boscose lungo il confine tra Tennessee e Kentucky. Probabilmente non vale molto, per via della rete di graffi e della crepa a stella sull’angolo di nordest, ma visto che è l’ultima cosa che mi ha dato mia madre prima di morire, per me ha un valore immenso.
La afferra e la stringe al sacco a pelo. «Ci starò attentissimo, mamma, te lo prometto».
«Per la cronaca, non è che te la sto regalando. Non ancora. Ma te la presto per un paio di giorni se pensi che possa farti sentire meno lontano da casa». Mi chino e lo guardo negli occhi. «E a essere sinceri, sapendo che ce l’hai mi sento più sicura. Se ti perdi, puoi usarla per ritrovare la strada».
Mi rivolge un sorriso felice. «Non mi perderò».
«Lo so. Ma prendila comunque».
Alle nostre spalle, il pullman avvia il motore con un sonoro rombo, un mezzo nero ed elegante più adatto a una rock star e al suo staff che a una ventina di bambini schiamazzanti di otto anni. Per la maggior parte si sono già sistemati dentro e urlano eccitati da dietro i finestrini oscurati, dicendoci che è già superata l’ora della partenza. La signorina Emma si volta e guarda verso di noi. Incrocia lo sguardo di Ethan, sorride e alza le mani come a dire Vieni o no?
Prendiamo le sue cose e attraversiamo in fretta il prato.
In fondo al parcheggio, mi accovaccio per mettermi all’altezza di Ethan. Sarà un saluto breve. Conciso e distaccato, sia per lui che per me. «Fa’ il bravo. Obbedisci alla signorina Emma e agli accompagnatori». Gli raddrizzo gli occhiali, gli sistemo il colletto spiegazzato. «E divertiti tantissimo».
Mi rivolge un sorriso a labbra strette. «Sono sicuro di sì».
Ripenso alla prima volta che l’ho tenuto in braccio, nella sala parto dell’ospedale. Era così piccolo, rosa, appiccicoso e fragile. Ricordo come mi ha guardato, ricordo la minuscola bocca che mi si apriva e chiudeva contro il braccio, simile a quella di un pesce, e quella prima ondata di amore materno che mi ha tolto il respiro. Le speranze, i progetti e i timori. Niente in confronto a ciò che provo ora.
«Dio, quanto mi mancherai». Lo stringo in un abbraccio rapido, intenso e forte abbastanza da non consentirgli di divincolarsi. Sento il suo familiare odore: shampoo, sapone e un sentore di cucciolo.
«Sei pronto, Ethan?». La signorina Emma gli tende una mano, mi guarda e sorride. «Lo tratteremo bene, non si preoccupi».
Annuisco e glielo consegno e mi dico che starà benissimo. Ethan sarà ben accudito. Forse al di fuori del cortile della scuola e dei limiti dell’aula, riuscirà persino a farsi un amico.
Ti prego, Dio, fa che trovi un amico.
Con un ultimo cenno della mano, la signorina Emma spinge Ethan verso il pullman rombante. Tra qualche ora, ripenserò a questo preciso istante, ripercorrendo mentalmente di continuo la scena, non la parte in cui mio figlio scompare dietro il vetro affumicato, ma quella in cui un brivido gelido mi corre per la schiena e mi spinge quasi a fermarlo.
KAT
3 ore e 13 minuti dalla scomparsa
Mi sveglia prima dell’alba un trambusto alla porta d’ingresso, e il mio primo pensiero va ad Andrew. Non il dolce, il delizioso Andrew che intrecciava il suo mignolo al mio dal droghiere o mi lavava la macchina ogni sabato, ma la versione ubriaca e dispotica apparsa sempre più spesso nel corso del nostro matrimonio. La pila di libri di autoaiuto sul comodino definirebbe il mio pensiero su di lui un classico esempio di condizionamento, una reazione acquisita a uno stimolo reiterato, come scansarsi da un ceffone in arrivo. Non mi serve un libro o uno psicologo per capire che ora quello che batte alla porta del piano terra è il pugno di Andrew.
Mi metto il cuscino sulla testa, in attesa che le sue grida si insinuino attraverso la porta in legno della camera da letto. Kat, posso sistemare le cose. Perché non vuoi che sistemi le cose?
Ma la voce di Andrew non arriva. Solo una pioggia costante tamburella sul tetto e la vecchia casa traballante trattiene il respiro.
Getto via il cuscino e guardo il quadro dell’allarme sulla parete opposta, una linea difensiva elettronica che ho installato dopo che gli oggetti in casa continuavano a spostarsi. Le mie
foto alle pareti storte. Una pila di documenti rimescolata e spostata. Il tappeto tirato da sotto la poltrona. Era il modo di Andrew di prendermi per il culo, di farmi sapere che anche se non aveva le chiavi, era ancora lui a controllare la situazione. È tutto finito sei mesi fa, il giorno in cui un giudice della contea di DeKalb ha firmato un documento che gli ingiunge di mantenere una distanza di sessanta metri. Per sicurezza, ho piantato davanti ai gradini d’ingresso il cartello di una società di sorveglianza. Questo luogo è protetto da adt, stronzo. Non provarci nemmeno.
Una luce rossa mi dice che il sistema è attivo, ma un altro colpo dabbasso mi dice invece che Andrew è deciso più che mai a tirarmi giù dal letto. L’ordinanza restrittiva è fantastica in teoria, ma per quanto mi riguarda si è dimostrata inutile. So per esperienza che, quando arriverà la polizia, Andrew se ne sarà già andato da un pezzo. Faccio per prendere il telefono, poi ricordo di averlo lasciato giù in cucina.
Da sotto arrivano altri cinque forti colpi alla porta.
Di solito, a questo punto Ethan entra barcollando in camera mia, con i ricci per aria, stropicciandosi gli occhi per scacciare il sonno. Ho cercato di proteggerlo dalle scenate mie e del padre, ma i momenti come questo sono stati così tanti che è ben possibile che i nostri costanti scontri gli abbiano lasciato cicatrici permanenti. Il divorzio è una immonda fonte di atroci dolori, soprattutto per un bimbo innocente che ci si trova in mezzo.
Scanso le coperte e scendo dal letto, ho paura che il baccano di Andrew svegli i vicini. Ho paura che plachi la collera sulle mie rose, o che spacchi un vetro col pugno. O che faccia qualcosa che non mi è ancora venuto in mente.
E poi apro la porta della camera da letto.
Il corridoio, di solito illuminato dal tenue chiarore giallo di un lampione, è invaso da un bagliore rosso e blu. I colori si arrampicano sulle pareti e squarciano il soffitto. Corro a precipizio sulla moquette. Inciampo in un cesto della biancheria strabordante e in un paio di logore scarpe da ginnastica di Ethan, evitando per un soffio di volare giù dalle scale. Scendo i gradini a due e a tre, con le gambe d’improvviso molli per il terrore. Siamo nel cuore della notte, mio figlio si trova a chissà quanti chilometri di distanza e c’è un’auto della polizia davanti casa.
Dio mi perdoni, ma prego che sia per Andrew.
Ha avuto un incidente. È stato arrestato.
Ti prego Dio, fa che non sia per Ethan.
In fondo alle scale, la sagoma di un uomo riempie la finestra verticale accanto alla porta. È enorme, più di uno e ottanta, spalle larghe e una stazza che si acquisisce a forza di kickboxing e pesi, non ciambelle. Mi fissa con gli occhi azzurri e mi si rizzano uno a uno i peli sul collo.
Appoggia un distintivo alla finestra. «Brent Macintosh, Dipartimento di polizia di Atlanta. Cerco Kathryn Jenkins».
Resto impietrita. Se apro la porta, se confermo che, sì, sono Kat Jenkins, mi dirà qualcosa che non voglio sentire. Per un lunghissimo momento, si sente solo il rumore del mio respiro, troppo forte, troppo aspro.
Non è in uniforme, ma indossa abiti scuri. Camicia scura, pantaloni scuri, di una stoffa color inchiostro come il cielo alle sue spalle. «Signora, è lei Kathryn Jenkins?».
Mi schiarisco la voce. Annuisco. «Sì, sono Kat».
Si rimette il distintivo in tasca e indietreggia rivelando l’auto sul vialetto. Le luci tingono di rosso e blu le gocce di pioggia, punti di colore che turbinano nel cielo come un caleidoscopio. «Può gentilmente aprire la porta?».
Accendo la luce dell’ingresso, tolgo il chiavistello, abbasso la maniglia e una sirena squarcia l’aria. Oh cazzo, penso mezzo secondo prima che il corpo mi entri in azione, balzando verso il quadro di controllo per digitare il codice. Le dita tremanti non collaborano. Mi ci vogliono tre maldestri tentativi per trovare la sequenza giusta.
Il silenzio in cui sprofonda la casa è di una tale intensità che quasi mi rimbomba nelle orecchie.
L’uomo ha un’espressione neutra, ma il linguaggio del corpo mi prepara a ciò che sta per dire. «Suo figlio, Ethan Maddox, è qui con lei?»
«No». Il cuore mi batte minaccioso. «Non c’è, è in gita scolastica».
«Allora mi dispiace doverglielo dire, ma è stata segnalata la scomparsa di Ethan da Camp Crosby».
Sento un sibilo nelle orecchie. Il cervello ha eliminato tutte le parole tranne una: la più importante.
«Ethan è scomparso?». Ho bisogno che quest’uomo me lo spieghi. Ho bisogno che sia preciso e puntuale.
Lo fa senza bisogno di consultare gli appunti. «L’insegnante di Ethan ha contato i bambini intorno alle 2:30 e ha scoperto che Ethan non c’era. Insieme a un accompagnatore ha perlustrato la zona circostante e non avendo trovato alcuna traccia di suo figlio, ha avvisato le autorità alle 3:07. Gli uomini dello sceriffo della contea di Lumpkin sono arrivati sul posto poco dopo e hanno avviato una ricerca meticolosa del campo. Finora non sono stati in grado di localizzarlo».
«Sono sicura che… Probabilmente è solo… andato al bagno o qualcosa di simile e non è riuscito a ritrovare la strada».
«È una delle ipotesi che stanno verificando. Un bambino di città nel bosco può smarrirsi facilmente, soprattutto al buio».
«Quali… quali sono le altre ipotesi?»
«In questa fase, non escludono niente».
Immagino mio figlio in mezzo al bosco, più buio di un incubo, e mi pare di perdere l’equilibrio, mi sento stringere il petto. Ethan dorme ancora con un lumino. Vuole la porta della camera aperta e le lampade del corridoio accese, in modo che la luce filtri fino ai piedi del letto. Lo penso là fuori, nel bosco buio e freddo e sento il suo panico, tangibile come l’elettricità nell’aria.
Tutte noi madri viviamo con questo segreto terrore. Che s’insinua in noi nei momenti più cupi. Ci soffia nelle orecchie con un alito bollente e aspro una paura primordiale: che accada qualcosa di brutto ai nostri piccoli. Ci consoliamo, liquidandola come una cosa impossibile. Non a noi, ci diciamo. Non ai nostri figli. È così che sopravviviamo alla minaccia che possa accadere il peggio, relegando le nostre paure negli angoli più reconditi e dimenticati della mente.
Ma a volte, quando la casa è silenziosa e tutti dormono, capita di chiederci cosa faremmo, come reagiremmo.
Io reagisco con gambe di gelatina e polmoni cementati, senza alcun passaggio d’aria. Mi sento la pelle infiammarsi e il sangue raggelarsi, la vista mi si offusca per le lacrime o la mancanza di ossigeno o entrambi. Qualcosa di aguzzo e tagliente mi squarcia lo stomaco, facendomi piegare in due.
Ethan è scomparso.
Le parole mi risuonano di continuo nella mente, insieme a immagini del mio bambino nel buio pesto del bosco, con un branco di bestie feroci che gli mordono i piedi o lo trascinano per il collo tra la vegetazione. È ferito? È cosciente? È vivo?
Mi raddrizzo barcollante e riprendo a respirare con una serie di singhiozzi strozzati.
Il poliziotto entra, chiudendo la porta con un leggero scatto, e mi prende per il gomito. «Venga a sedersi».
Gli scaccio la mano. «Da quanto lo stanno cercando?». Ho la voce troppo alta e troppo stridula. L’isteria si è addensata in un nodo puntuto in mezzo al petto. Posso a malapena girarci intorno. «Da quanto?».
Guarda l’orologio. «Sono ormai un po’ meno di tre ore ed è da allora che cerchiamo di contattarla».
«Tre ore! Tre… Quante persone?»
«Non conosco il numero esatto, signora, ma un bambino scomparso ha la priorità assoluta, come può immaginare. Se non hanno gente a disposizione, chiameranno qualcuno dai distretti vicini e cercheranno volontari. In piena notte ci vuole un po’ più di tempo per riunire una squadra di ricerca, ma lo sceriffo sa il fatto suo e i suoi uomini conoscono quei boschi come le loro tasche».
Se fosse vero, se lo sceriffo e i suoi uomini conoscessero ogni masso ricoperto di muschio, ogni grotta e ogni tronco di albero caduto dietro, dentro o sotto cui Ethan poteva nascondersi, a quest’ora non l’avrebbero già trovato?
«Sono davvero desolato, signora, ma devo chiederle a che ora è tornata a casa ieri sera».
Forse è la mancanza di sonno o lo shock o il terrore, ma il mio cervello non riesce a elaborare la domanda. «Come?»
«Ieri sera». Lo sguardo gli vaga oltre la mia spalla per scrutare l’ingresso buio. «A che ora è rientrata a casa? E c’è qualcuno che può confermare i suoi spostamenti?».
Allora capisco e mi si serra la gola: mi sta chiedendo se ho un alibi. Mio figlio è smarrito in una foresta a ore da qui e quest’uomo è stato mandato per accusarmi di averlo rapito.
«Sono stata al lavoro quasi fino alle nove», rispondo a denti stretti. «Dopo, sono tornata subito a casa. E da allora non sono uscita. Se non mi crede può chiedere alla società di sorveglianza. Sono certa che abbiano registrato quando ho spento e riacceso l’allarme».
E poi mi rendo conto di un’altra cosa, che mi formicola sotto la pelle come una scarica elettrica. «Oddio. Pensate sia stato rapito?»
«Non necessariamente, ma visto che non riuscivamo a contattarla… Come dicevo, dovevo chiederglielo». Ha quasi un tono di scuse, ma c’è in lui una sorta di pacata allerta che mi fa venire una stretta allo stomaco. «Lo sceriffo vorrebbe che andasse a Dahlonega il prima possibile. Sa dove deve andare o devo scriverle l’indirizzo?».
Mi volto in fretta e corro per il corridoio, con la vestaglia che mi sbatte contro le caviglie. In cucina, rovisto tra le cianfrusaglie sul bancone in cerca del telefono, lo attivo e vedo ventisette chiamate perse. Ventisette.
Con il figlio fuori per la notte, una brava madre avrebbe dormito con il cellulare accanto al letto. Nel momento in cui fosse scomparso nel cuore della notte non sarebbe rimasta ignara. L’avrebbe saputo.
«C’è qualcuno che può chiamare? Un amico o un familiare che può accompagnarla?». Il poliziotto incombe nella cucina, posando lo sguardo sull’informe caos lasciato da una madre lavoratrice e un disordinato bambino di otto anni. Un lavello straripante di tazze sporche e piatti pieni di briciole, una piccola montagna di comunicazioni scolastiche, fogli e lettere, le due ciotole di cereali sul tavolo, incrostate dei resti della colazione.
Scuoto il capo, poi annuisco, poi lo riscuoto. Sono figlia unica, orfana, e le persone che potrei chiamare vivono da tutt’altra parte. Compagni delle superiori della mia città natale, un posto minuscolo all’estremità settentrionale del Tennessee. Lucas, mio fratello in tutto tranne che nel sangue. Izzy – la mia unica amica di Atlanta del periodo Avanti Divorzio – è in barca a vela nelle Isole Vergini con il suo ultimo compagno, Tristano, Tanner o un altro pomposo nome che comincia per T. Resta solo Andrew.
Non se ne parla nemmeno.
Lascio cadere rumorosamente il cellulare sul bancone e mi precipito verso la porta posteriore. Il gancio delle chiavi accanto al quadro dell’allarme è vuoto. Per essere sicura, tasto con la mano. Niente chiavi. Accendo le luci e perlustro il pavimento, scalciando via le cartelle di Ethan, la giacca che non ricorda mai di appendere, un paio di pantofole pelose rosa. Niente. Non sono neanche lì.
Dove sono?
Mi invade un’altra ondata di panico, che mi formicola in testa come uno sciame di zanzare infuriate. Devo andare a Dahlonega. Devo andare in quel bosco a urlare il nome di Ethan fino a perdere la voce. Devo aiutarli a cercare mio figlio. No. Devo escogitare un modo per tornare a ieri mattina, per spingere l’acceleratore a tavoletta e superare di corsa l’uscita in direzione della scuola e fare in modo che niente di tutto ciò sia accaduto. Ethan sarebbe sano e salvo a dormire di sopra nel suo letto. Io sarei dall’altro lato della parete e mi sveglierei di soprassalto tra le lenzuola sudate e ingarbugliate, accasciandomi per il sollievo di scoprire che è stato solo un terribile e spaventoso incubo.
Mi volto in fretta e vado a sbattere contro il corpo massiccio dell’agente, compatto come un muro di mattoni. Indietreggia per farmi passare, dicendo qualcosa che mi colpisce i pensieri convulsi come una musica in un grande magazzino: un suono in sottofondo di cui non viene registrata una singola nota.
Devo trovare le chiavi. Rifletti, maledizione.
Torno in cucina, rovisto nella borsa, capovolgendo il contenuto sul bancone. Portafoglio, una quantità assurda di scontrini accartocciati, una manciata di mentine, ma nessuna chiave.
Il poliziotto continua a parlare, dice di sedermi, calmarmi, e io con quella voce non riesco a pensare. Mi metto le mani tra i capelli e chiudo forte gli occhi, cercando di ignorarlo, cercando di ricordare dove ho lasciate quelle maledette chiavi. Sono entrata ieri sera, ho gettato la borsa e il telefono sul bancone, mi sono versata un bicchiere di vino e… scanso l’agente, tiro la maniglia del frigorifero e alleluia, ecco il groviglio di metallo argentato che luccica sotto la luce dorata del Whirlpool.
Faccio per afferrare le chiavi, ma non sono abbastanza veloce. Un lungo braccio mi supera e un grosso pugno le avvolge prima che possa toccarle.
Chiudo lo sportello, mi volto di scatto e all’improvviso è troppo. La paura, lo shock, la preoccupazione, uniti alla stanchezza, al poliziotto che mi ha preso le chiavi, e al fatto che sono sola. Mi sgorgano lacrime di frustrazione, impotenza e forse anche un po’ di autocommiserazione.
Le spalle del poliziotto si rilassano, s’infila le chiavi nella tasca dei pantaloni. «Vada a vestirsi. Indossi abiti comodi e scarpe da ginnastica. Prepari una valigia per la notte con l’indispensabile: un cambio, spazzolino da denti, articoli da bagno necessari. Ne prepari una anche per Ethan e ci metta giocattoli o pelouche che potrebbe volere quando lo ritroveremo». Prende il mio cellulare dal bancone e lo scuote in aria. «Dov’è il caricatore?».
Sono troppo scioccata per dire altro e rispondo solo: «Di sopra, credo».
«Prenda anche quello. Partiamo non appena sarà pronta».
KAT
3 ore e 23 minuti dalla scomparsa
Il posto dove abito nella zona est di Atlanta, un agglomerato degradato nella parte sbagliata di Tucker, è il genere di quartiere dove si è abituati a vedere auto della polizia in piena notte. Nella mia strada abita gente tosta: donne che fumano una sigaretta dietro l’altra e dal portico agitano il pugno verso gli estranei, uomini obesi dai denti d’oro e braccia ricoperte di tatuaggi sbiaditi, giovani con pantaloni mezzo calati che ciondolano sui marciapiedi insieme a ragazzini troppo piccoli per fumare. Le case non sono molto meglio: malconce e fatiscenti, con grondaie cadenti, vernice scrostata e a chiazze, cortili soffocati dalle erbacce. Le vedo passare dal finestrino bagnato di pioggia nell’auto del poliziotto e ne osservo il misero stato sotto il tetro bagliore dei lampioni e le sporadiche luci delle verande. Avevo pensato che sposare Andrew mi avrebbe salvato da un quartiere così, ma grazie alle subdole cortine fumogene erette per nascondere i soldi e i beni della sua società, mi ritrovo qui.
«Come va?», chiede l’agente, e io trasalisco. «Scusi, non volevo spaventarla».
«Come mai non ha l’uniforme?». La domanda esce incerta e senza ritmo. Anzi mi sorprende che riesca a parlare, ho la gola inaridita e la lingua è come un peso morto, gonfia e grande il doppio.
Ebook 2,99