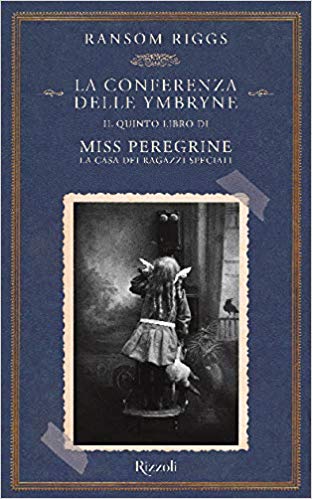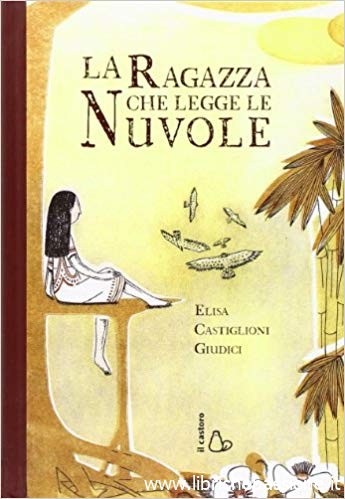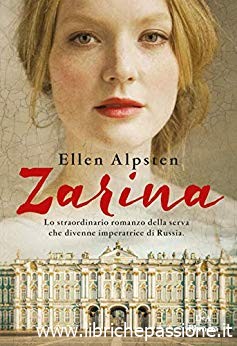
trama
Lo straordinario romanzo della serva che divenne imperatrice di Russia.
Palazzo d’Inverno, febbraio 1725. Quando lo zar Pietro il Grande esala l’ultimo, travagliato respiro, sua moglie Caterina i è la regina astuta e seducente che tutti hanno imparato a temere e ad ammirare. La donna piena di risorse che ha profuso ogni sforzo pur di rimanere al fianco dell’imperatore; colei che più di ogni altra lo ha amato e odiato, aiutato e tradito, subìto e saputo domare. Ma nel passato di Caterina c’è molto di più. Figlia illegittima di un contadino della Livonia, prima che l’incontro con l’imperatore di Russia le cambiasse il nome e la vita, Caterina era Marta: sposa poco più che bambina di un soldato svedese, domestica al servizio di un pastore in Lettonia, salvata da un ufficiale dell’esercito russo, serva del principe Menšikov. Non c’è sopruso, violenza o barbarie che Marta non abbia provato sulla propria pelle e, adesso che lo zar è morto, l’ultima, decisiva battaglia la attende: quella per il potere. La parabola drammatica e trionfale di Caterina i di Russia rivive in un racconto storicamente accurato, trascinante, appassionato e appagante come solo la vita vera sa essere.
Estratto
Ellen Alpsten
ZARINA
Traduzione di Francesco Zago
a Tobias: grazie
Prologo
—
Palazzo d’Inverno, 1725
È morto. Il mio adorato marito, il potente zar di tutte le Russie, è morto. E appena in tempo.
Pochi istanti prima che la morte lo cogliesse, Pietro ha chiesto che gli venissero portate carta e penna nella sua camera da letto al Palazzo d’Inverno. Il mio cuore si è quasi fermato. Non aveva dimenticato, mi avrebbe trascinato con sé. Quando ha perso conoscenza per l’ultima volta e l’oscurità lo ha tratto più vicino al suo cuore, la penna gli è scivolata dalle dita. L’inchiostro nero è schizzato sui fogli sporchi; il tempo ha trattenuto il respiro. Quale volontà aveva voluto affermare lo zar con quell’ultimo slancio del suo formidabile spirito?
Conoscevo già la risposta.
I ceri negli alti candelabri spargevano per la stanza un odore intenso e una luce incerta; il loro chiarore faceva danzare le ombre negli angoli e animava le figure intessute negli arazzi fiamminghi, i volti grossolani colmi di dolore e incredulità. Fuori dalla porta, le voci di coloro che erano rimasti tutta la notte in attesa erano sovrastate dal vento di febbraio che faceva sbatacchiare furiosamente le imposte. Il tempo si propagava lento, come olio sull’acqua. Pietro si era impresso nelle nostre anime al pari del suo anello con sigillo nella cera calda. Sembrava impossibile che il mondo non avesse smesso di girare nell’istante della sua scomparsa. Mio marito, la cui ferrea determinazione aveva cambiato il volto della Russia, era stato più di un sovrano. Era stato il nostro destino. Ed era ancora il mio.
I dottori, Blumentröst, Paulsen e Horn, erano in piedi attorno al suo letto, e lo fissavano, intimoriti e silenziosi. Una medicina da cinque copechi, somministrata in tempo, avrebbe potuto salvarlo. Ringrazio Dio per la mancanza di buonsenso di quei ciarlatani.
Senza bisogno di voltarmi a guardarli, sapevo che Feofan Prokopovič, l’arcivescovo di Novgorod, e Aleksandr Menšikov mi stavano osservando. Prokopovič aveva reso eterna la volontà dello zar, e Pietro aveva molto di cui essergli grato. Quanto a Menšikov doveva la sua fortuna e la sua influenza a Pietro. La volta in cui qualcuno aveva tentato di infangare il nome di Aleksandr Danilovič accennando ai suoi loschi rapporti d’affari, lo zar si era limitato a commentare: «Menšikov rimarrà sempre Menšikov, qualunque cosa faccia!». E questo aveva posto fine alla questione.
Il dottor Paulsen aveva chiuso gli occhi dello zar e gli aveva incrociato le mani sul petto, ma non aveva liberato il foglio con il testamento dalla sua stretta. Quelle mani, troppo delicate per un corpo così possente, ormai erano immobili, inermi. Solo poche settimane prima le aveva affondate nei miei capelli, avvolgendoseli attorno alle dita, inspirando il profumo di acqua di rose e sandalo.
«Mia Caterina» aveva detto, chiamandomi col nome che lui stesso mi aveva dato, e aveva sorriso. «Siete ancora bellissima. Ma che aspetto avrete in un convento, smagrita e senza capelli? Lì il freddo fiaccherà il vostro spirito, anche se avete il fisico forte di una giumenta. Sapete che Evdokija mi scrive ancora supplicando una seconda pelliccia? Poveretta! Meno male che non sapete scrivere!»
Evdokija era rinchiusa in convento da trent’anni. L’avevo incontrata una sola volta. I suoi occhi scintillavano di follia, la testa rasata era coperta di croste e bubboni dovuti al freddo e alla sporcizia, e la sua unica compagnia era una nana con la gobba che la serviva nella sua cella. Pietro aveva ordinato che a quella povera creatura venisse tagliata la lingua, di modo che in risposta ai mugugni e alle lamentazioni di Evdokija potesse rispondere soltanto con gorgoglii senza senso. Lo zar era stato nel giusto nel prevedere che la vista di Evdokija mi avrebbe riempito di eterno terrore.
Mi inginocchiai accanto al letto di mio marito e i tre dottori si ritirarono nell’ombra in fondo alla stanza come corvi scacciati da un campo. I corvi: gli uccelli che tanto avevano terrorizzato Pietro negli ultimi anni della sua vita. E così aveva dichiarato aperta la stagione di caccia agli sfortunati volatili in tutto il suo impero. I contadini potevano catturarli, ucciderli, spennarli e arrostirli come ricompensa. Nulla di tutto ciò era servito: in silenzio, di notte, l’uccello si era insinuato attraverso le pareti imbottite e aveva serrato le porte della camera da letto dello zar. Le ali d’ebano avevano oscurato la luce e, nella loro fredda ombra, il sangue sulle sue mani non si era più asciugato. Le dita non erano ancora quelle di un cadavere, ma soffici e calde. Per un istante, la paura e la rabbia di quegli ultimi mesi scivolarono dal mio cuore come un ladro nella notte. Baciai le sue mani e ne inspirai il familiare odore di tabacco, inchiostro e cuoio misto alla fragranza che veniva preparata esclusivamente per lui a Grasse.
Fu facile sfilargli il rotolo dalle mani, malgrado il sangue si fosse addensato di paura nelle mie vene gelate come i rami dell’inverno baltico. Era importante mostrare a tutti che io sola
ero autorizzata a farlo: io, sua moglie, e la madre dei suoi figli. Dodici volte avevo dato la vita.
Il foglio frusciò mentre lo srotolavo. Non per la prima volta, mi vergognai di non saper leggere, e consegnai il testamento a Feofan Prokopovič. Menšikov, perlomeno, era ignorante quanto me. Sin da quando Pietro ci aveva attratto nella sua orbita e aveva operato il suo incantesimo su di noi, eravamo stati due bambini che si contendono l’affetto e l’attenzione paterni. Batjuška zar, lo chiamava la sua gente. Il nostro Piccolo Padre.
Prokopovič doveva essere al corrente di ciò che Pietro aveva in mente per me. Era una vecchia volpe dallo spirito arguto, a suo agio tanto nelle questioni celesti quanto in quelle terrene. Una volta Daria aveva giurato di custodire tremila volumi nella sua biblioteca. Che cosa, di grazia, può farsene un uomo di tremila libri? Ora teneva con delicatezza il foglio tra le mani costellate di macchie. Dopotutto, era stato lui stesso ad aiutare Pietro a redigere il decreto che aveva scioccato tutti noi. Lo zar aveva messo da parte ogni consuetudine, ogni legge: avrebbe nominato il proprio successore, preferendo lasciare il suo impero a un estraneo meritevole piuttosto che a un figlio indegno.
Com’era stato timido Alessio quando ci eravamo incontrati la prima volta; il ritratto sputato della madre Evdokija, il medesimo sguardo velato e la fronte alta e sporgente. Non riusciva a stare seduto dritto, tanto Menšikov lo aveva percosso a sangue sulla schiena e sulle natiche. Solo quando fu troppo tardi Alessio aveva compreso fino in fondo il proprio destino: nella sua volontà di forgiare una nuova Russia, lo zar non avrebbe risparmiato nessuno, neppure se stesso o il suo unico figlio. Tu non eri sangue del mio sangue, Alessio, né carne della mia carne; e così io ho continuato a dormire sonni tranquilli. Pietro, invece, da quel giorno fu perseguitato dagli incubi.
Il mio cuore martellava contro il corsetto – ero sorpresa che il battito non riecheggiasse amplificato tra le pareti della stanza – ma incrociai lo sguardo di Prokopovič ostentando calma. Contrassi le dita dei piedi nelle pantofole: non potevo permettermi di svenire. Il sorriso di Prokopovič era sottile come le ostie che distribuiva in chiesa. Conosceva i segreti del cuore umano. In special modo i miei.
«Leggete, Feofan» lo esortai a bassa voce.
«Lascio tutto a…» Fece una pausa, alzò lo sguardo e ripeté: «A…».
Menšikov avvampò di rabbia e arretrò; sembrava che qualcuno lo avesse colpito con una frusta, come ai bei tempi. «A chi?» ringhiò rivolto a Prokopovič. «Vi prego, parlate, Feofan, a chi?»
Mi mancava il respiro. D’un tratto la pelliccia era troppo calda a contatto con la mia pelle.
Feofan scrollò le spalle. «È tutto. Lo zar non ha concluso la frase.» L’ombra di un sorriso guizzò sul suo volto rugoso. Nulla dava più piacere a Pietro che spiazzare tutti quanti: e, oh sì, anche dall’oltretomba continuava a tenerci in pugno. Feofan abbassò lo sguardo. Io tornai d’un tratto a vivere. Nulla era deciso. Pietro era morto; il suo successore non aveva un nome. Ma questo non significava che fossi al sicuro. Anzi, l’opposto.
«Cosa? È tutto?» Menšikov strappò il foglio dalle mani di Feofan. «Non ci credo!» Fissò le lettere, ma Prokopovič gli sottrasse il rotolo.
«Oh, Aleksandr Danilovič. Ecco cosa si rischia quando si ha sempre di meglio da fare che imparare a leggere e scrivere.»
Menšikov stava per ribattere piccato, ma glielo impedii. Accidenti agli uomini! Era forse quello il momento di dare sfogo alla propria rivalità? Dovevo agire in fretta se non volevo finire i miei giorni in un monastero, essere spedita in Siberia a bordo di una slitta, o ritrovarmi riversa nella Neva con il corpo alla deriva schiacciato dalla forza cieca dei banchi di ghiaccio.
«Feofan, lo zar è morto senza nominare un erede?» Dovevo accertarmene.
Lui annuì, gli occhi iniettati di sangue per le lunghe ore di veglia al capezzale del suo signore. Portava i capelli sciolti, secondo l’uso dei sacerdoti ortodossi, lunghi fino alle spalle e striati di grigio, e la tunica scura di un prete qualunque. Nulla in lui tradiva i privilegi e le cariche con cui Pietro lo aveva ricompensato; nulla se non la panaghia, la pesante croce tempestata di gemme che gli pendeva sul petto. Feofan era anziano, ma avrebbe potuto vivere ancora abbastanza da servire diversi altri zar. Si inchinò e mi porse il foglio. Lo infilai nella manica del vestito. Feofan si rialzò. «Zarina, affido il futuro della Russia nelle vostre mani.» Il mio cuore sussultò quando si rivolse a me con quel titolo. Anche Menšikov drizzò la testa, in allerta, al pari di un segugio che fiuta la traccia, gli occhi ridotti a due fessure.
«Andate a casa a riposarvi, Feofan. Vi farò chiamare quando avrò bisogno di voi. Fino ad allora, non dimenticate: le ultime parole dello zar sono note a noi tre soli» dissi. «Spero che resterete al mio servizio per molti anni, Feofan» aggiunsi. «Vi conferisco l’Ordine di Sant’Andrea e una proprietà fuori Kiev con dieci… no, ventimila anime.» Prokopovič si inchinò soddisfatto mentre riflettevo su chi spedire in esilio per confiscarne la proprietà. In un giorno simile, qualcuno avrebbe fatto fortuna e qualcun altro si sarebbe visto togliere ogni cosa. Feci un cenno al valletto che stava di guardia accanto alla porta. Aveva colto i nostri sussurri? Mi augurai di no.
«Fai preparare la carrozza di Feofan Prokopovič. Aiutalo a scendere le scale. Nessuno deve parlare con lui, intesi?» bisbigliai.
Il valletto annuì, le lunghe ciglia che si abbassavano sulle guance rosee. Davvero un giovane affascinante. D’un tratto il suo viso mi ricordò qualcun altro. Il più bel volto che avessi mai visto. Pietro aveva messo fine a tutto in maniera brutale. E poi aveva ordinato che la testa, quella testa così soave, venisse posta accanto al mio letto in un grosso barattolo di vetro, sotto spirito, proprio come si conservano le mele nella vodka in inverno. Gli occhi sbarrati mi fissavano mesti, in preda agli spasmi della morte; le labbra, un tempo così morbide da baciare, ora raggrinzite ed esangui, avevano lasciato scoperti i denti e le gengive. Quando la vidi e, inorridita, chiesi alla mia dama di compagnia di farla sparire, Pietro minacciò di frustarmi e rinchiudermi in convento. E così la testa rimase dov’era.
Feofan ridacchiò, il volto solcato da così tante rughe da far assomigliare la sua pelle al terreno riarso di fine estate. «Non preoccupatevi, zarina. Vieni, figliolo, porgi il braccio a un vecchio.»
I due uscirono in corridoio. I pantaloni di seta chiara fasciavano le gambe e le natiche muscolose del valletto. C’era qualcosa di vero nelle voci secondo cui Prokopovič aveva un debole per i giovinetti? Be’, a ciascuno i suoi diletti. Rimasi immobile sulla soglia per impedire a sguardi indiscreti di posarsi sul letto dello zar. Volti pallidi e spaventati si volsero verso di me: nobili e servi se ne stavano lì seduti come conigli in trappola. Madame de la Tour, la scheletrica governante francese di Natal’ja, la più piccola delle mie figlie, stava abbracciando forte la bambina. Mi accigliai, poiché in corridoio faceva troppo freddo e la piccola tossiva dal pomeriggio del giorno precedente. Le sue sorelle maggiori, Elisabetta e Anna, erano accanto a lei, ma evitai i loro sguardi. Erano troppo giovani: come avrebbero potuto capire?
Nessuno sapeva ancora se fossi io quella da temere. Cercai tra la folla il giovane Petruška, il nipote di Pietro, e i principi Dolgorukij, suoi sodali, senza riuscire a individuarli. Mi morsi
il labbro. Dov’erano? Magari impegnati a ordire un complotto per impadronirsi del trono? Dovevo stanarli al più presto. Schioccai le dita e la guardia più vicina scattò sull’attenti.
«Manda a chiamare il Consiglio privato: il conte Tolstoj, il barone Osterman e Pavel Jagušinskij. Fa’ in fretta, lo zar vuole vederli» dissi ad alta voce, assicurandomi che le mie ultime parole venissero udite in tutto il corridoio.
Menšikov mi fece rientrare nella stanza, chiuse la porta e sogghignò.
«Venite» dissi seccamente. «Spostiamoci in biblioteca.» Raccolse il suo cappotto di broccato verde ricamato dalla sedia da cui aveva sorvegliato il capezzale di Pietro negli ultimi giorni e settimane. Un contadino avrebbe potuto tirare avanti due anni interi con i fili d’argento intessuti in quella stoffa. Sotto il braccio stringeva il bastone da passeggio con l’impugnatura in avorio. Dalla porta segreta che conduceva alla piccola biblioteca di Pietro mi voltai verso i dottori. «Blumentröst, non vi è consentito lasciare questa stanza né convocare chicchessia.»
«Ma…» provò a ribattere il medico.
Sollevai una mano. «La morte dello zar non può essere resa nota. Non ancora.»
Pietro avrebbe approvato il mio tono.
«Come desiderate.»
«Bene. Più tardi verrete pagato. E lo stesso vale per i vostri colleghi.»
Menšikov vacillò lievemente. Era la stanchezza a renderlo malfermo sulle gambe o la paura? Lo precedetti nell’accogliente biblioteca, dove mi seguì dopo aver afferrato l’alta caraffa di bordeaux da cui stava bevendo insieme a due calici veneziani. «Non è questo il momento per essere sobri o taccagni» dichiarò con un sorriso sghembo prima di sbattere la porta come un volgare oste. Il fuoco nel camino si era spento, ma i pannelli di legno alle pareti ne trattenevano il calore. Gli sgargianti tappeti di seta che avevamo riportato dalla campagna persiana – con una buona dozzina di carri aggiunti al convoglio – sfoggiavano tutto lo splendore dei fiori e degli uccelli del Creato. Le semplici sedie disposte accanto allo scrittoio, al caminetto e agli scaffali erano state realizzate da Pietro con le sue stesse mani. Mi capitava di sentirlo lavorare e martellare ben oltre la mezzanotte. La falegnameria scacciava i suoi demoni e gli ispirava le idee migliori, diceva sempre, cosa che spaventava i suoi ministri più di qualunque altra cosa. Alla fine, esausto, si addormentava riverso sul banco da lavoro. Solo Menšikov era abbastanza forte per caricarselo sulle spalle e portarlo a letto. Se non ero lì ad attenderlo, Pietro usava la pancia di un valletto come cuscino. Aveva sempre bisogno del contatto con la pelle per tenere a bada i fantasmi del passato. Le alte finestre erano incorniciate dalle tende a righe che aveva acquistato in gioventù nel corso di un viaggio in Olanda, molto tempo prima della Grande guerra del Nord e i suoi due decenni di lotta contro gli svedesi per la sopravvivenza e la supremazia. Le mensole erano gravate dal peso dei libri, che avevo appreso essere diari di viaggio, racconti marinareschi, storie di guerra, biografie di sovrani, trattati sull’arte del governo e opere religiose. Pietro li aveva sfogliati uno a uno innumerevoli volte. Era un mondo in cui non avrei mai potuto seguirlo. C’erano ancora rotoli aperti sulla scrivania o ammonticchiati negli angoli. Alcuni volumi erano stampati e rilegati in pelle di maiale, altri vergati a mano nei monasteri. Sulla mensola sopra il camino faceva mostra di sé un modellino dalla Natal’ja, la gloriosa fregata di Pietro; più in alto era appeso un ritratto di mio figlio, Pëtr Petrovič. Il dipinto era stato realizzato diversi mesi prima che la sua morte spezzasse i nostri cuori. Da anni evitavo la biblioteca proprio per questo: il ritratto era troppo realistico, come se da un momento all’altro mio figlio potesse lanciarmi la palla rossa di cuoio che teneva in mano. I riccioli biondi ricadevano sulla camicia bianca di pizzo, il sorriso lasciava intravedere una fila di dentini. Avrei dato la vita per averlo lì, con me, e dichiararlo zar di tutte le Russie. Era ancora un bambino, certo. Ma sangue del nostro sangue, Pietro, mio e vostro. Una dinastia. Non è ciò a cui ambisce ogni sovrano? Invece sono rimaste solo figlie femmine, e un temibile nipote, il piccolo Petruška.
Il pensiero di Petruška mi tolse il respiro. Alla sua nascita Pietro lo aveva cullato fra le braccia voltando le spalle alla madre infelice. Povera Carlotta. Era una purosangue bizzosa, e il padre l’aveva venduta alla Russia proprio come si fa coi cavalli. Dov’era adesso suo figlio? Al palazzo dei Dolgorukij? Alle caserme? Fuori dalla porta? Petruška aveva solo dodici anni e Pietro non gli aveva concesso il titolo di zarevič. Eppure lo temevo più del diavolo.
Menšikov disse in tono maligno: «Avete fatto bene a convocare il consiglio e a sbarazzarvi di Feofan, quel vecchio idiota».
Mi voltai a guardarlo. «Gli idioti siamo noi. Spero che mantenga la parola.»
«Che cosa vi ha promesso?» domandò, sorpreso.
«Ecco, vedete? Proprio non riuscite a capire.» Lo afferrai per il collo della camicia e sibilai: «Voi e io siamo sulla stessa barca. Dio abbia pietà di voi per ogni istante che state sprecando. In corridoio non ho visto né Petruška né i suoi amabili amici, e voi? Per quale motivo il legittimo erede dell’impero russo non è qui al capezzale del nonno, come si conviene?».
La fronte di Menšikov si imperlò di sudore.
«Perché è con le truppe alle caserme imperiali, dove se lo isseranno sulle spalle per salutarlo con tre urrà non appena sapranno che lo zar è morto. Cosa ci succederà allora? Credete che Petruška abbia dimenticato coloro che hanno firmato la condanna a morte di Alessio, anche se solo con una croce accanto al loro nome perché non sapevano scrivere?»
Mollai la presa. Menšikov si riempì il calice e prese una lunga sorsata di vino, le mani tremanti, le dita robuste coperte di anelli massicci. La sua innata furbizia era offuscata dalla stanchezza della veglia, ma con lui non avevo ancora finito. «Ci spediranno in Siberia oggi stesso, e i Dolgorukij spargeranno al vento le nostre ceneri. Solo noi sappiamo che lo zar è morto» sussurrai. «Il nostro segreto ci permetterà di guadagnare tempo.» Tempo che avrebbe potuto essere la nostra salvezza. Non potevamo sperare di tenere nascosta la morte dello zar troppo a lungo; la notizia si sarebbe diffusa entro la mattina, allorché un’alba di piombo sarebbe sorta sulla città di Pietro.
Menšikov, l’uomo che aveva saputo volgere a suo favore tante battaglie, il cui collo era sgusciato in così tante occasioni dai cappi più pericolosi, sembrava confuso. Il mio terrore era contagioso. Si lasciò cadere in una delle poltrone più confortevoli, che Pietro aveva portato da Versailles, e allungò le gambe ancora ben tornite. Era un miracolo che quel delicato pezzo d’arredamento riuscisse a reggere il suo peso! Bevve dell’altro vino e poi rigirò il vetro colorato davanti al fuoco. Le fiamme accesero la liscia superficie sfumata del calice; pareva colmo di sangue. Mi sedetti di fronte a lui. Non era serata per i giochi alcolici.
Menšikov alzò il bicchiere verso di me in segno di scherno. «A voi, Ekaterina Alekseevna. È valsa la pena donarvi allo zar, mia signora. Salute a voi, la mia più grande perdita. A voi, la mia più grande conquista.» D’un tratto scoppiò in un riso così sguaiato che la parrucca gli scivolò sugli occhi, un suono simile all’ululato dei lupi in inverno: stridulo e sprezzante. Si tolse la parrucca e la scagliò via. Pietro lo avrebbe fatto frustare, tuttavia io mantenni la calma di fronte alla sua insolenza. Menšikov stava soffrendo come un cane: era morto il suo signore, nonché l’amore della sua vita. Cosa c’era in serbo per lui? Il dolore lo rendeva imprevedibile. Ora avevo bisogno dell’uomo davanti a me. Disperatamente. Di lui, del Consiglio privato e delle truppe. Il testamento dello zar era infilato nella mia manica. Il volto di Menšikov era gonfio e paonazzo sotto la chioma biondo scuro arruffata. Smise di ridere e mi guardò incerto da sopra le lenti.
«Eccoci qui. Che vita eccezionale avete vissuto, mia signora. La volontà divina è la sola spiegazione.»
Annuii. È quello che dicono di me nelle corti europee. Le mie origini sono il sollazzo che non manca mai di mettere di buonumore i delegati. Ma per Pietro, abituato a vedere ogni suo desiderio convertito in realtà, non avevano nulla di straordinario.
All’improvviso, il calice scivolò dalle dita di Menšikov, il mento gli ricadde sul petto e il vino si rovesciò, allargandosi in una grossa macchia rossa sulla camicia di pizzo bianco e sul panciotto blu. Le settimane, i giorni e le ore passati al capezzale dello zar lo avevano provato duramente, e adesso eccolo lì a russare in poltrona, afflosciato come una bambola di pezza. Potevo concedergli qualche istante di tregua prima dell’arrivo di Tolstoj e del Consiglio privato. In seguito, sarebbe stato condotto al suo palazzo a riprendersi. Menšikov aveva già ricevuto l’Ordine di Sant’Andrea, oltre a un numero di servi e titoli che io non avrei potuto concedergli. Non c’era nulla dunque che potessi promettergli. Se fosse rimasto, lo avrebbe fatto per sua volontà: niente lega con più forza le persone del timore per la propria vita, Caterina, mi suggeriva la voce di Pietro.
Andai alla finestra che dava sul cortile interno. Le icone d’oro cucite all’orlo del mio abito tintinnavano a ogni passo. Quando la principessina Guglielmina di Prussia, di ritorno a Berlino, aveva visto il mio abbigliamento, era scoppiata a ridere: «L’imperatrice di Russia sembra la moglie di un cantore di strada!».
Scostai la pesante tenda che teneva fuori il cupo gelo delle notti invernali di San Pietroburgo: la nostra città, Pietro, il nostro sogno! La Prospettiva Nevskij e la Neva erano avvolte dall’oscurità che adesso ti stringeva in un abbraccio eterno, e la notte celava l’abbacinante bellezza di ciò che avevi creato: le sfumature verde ghiaccio delle onde che si fondevano alla perfezione con il caleidoscopio di colori dei palazzi e delle case, una tale novità vent’anni prima. Questa città che hai strappato alle paludi, con la forza della tua assoluta, formidabile volontà e la sofferenza di centinaia di migliaia di sudditi, sia nobili che servi. Le ossa dei condannati ai lavori forzati sepolte nel terreno acquitrinoso a fare da fondamenta. Uomini, donne, bambini, senza un nome e senza un volto: chi li ricorda alla luce di tanta magnificenza? Se c’è qualcosa che abbonda in Russia, è la vita umana. Il mattino sarebbe sorto freddo e grigio; poi, più tardi, sulla facciata vivace e maestosa del palazzo si sarebbe riflesso il pallido fuoco del giorno. Attiravi qui la luce, Pietro, e le davi una dimora. Cosa accadrà ora? Aiutami…
La luce delle candele tremolava dietro i vetri delle case alte e slanciate, volteggiando per stanze e corridoi, come sorretta da mani spettrali. Nel cortile una sentinella era curva sulla baionetta, quando, in un clangore di zoccoli che sprizzavano scintille sull’acciottolato, un uomo a cavallo uscì dal cancello. Le mie dita si strinsero intorno alla maniglia della finestra. Blumentröst aveva obbedito al mio ordine? O il cavaliere era partito per confermare l’impensabile? Cosa sarebbe accaduto ora? Volja – grandiosa, inimmaginabile libertà – o l’esilio e la morte?
La paura mi seccava la bocca e mi annodava lo stomaco, mi faceva sudare freddo e mi scioglieva le viscere. Non mi ero mai sentita così… Basta! Non dovevo pensare a certe cose adesso. Riuscivo a concentrarmi su una questione alla volta io, mentre Pietro si destreggiava come un acrobata tra decine di idee e progetti.
Menšikov borbottava nel sonno. Se solo Tolstoj e il Consiglio privato fossero arrivati. L’intera città sembrava in agguato. Mi mordicchiai le unghie finché non sentii il sapore del sangue.
Tornai a sedermi vicino al fuoco e mi tolsi le pantofole appesantite da ricami e gioielli. Il calore delle fiamme mi faceva formicolare la pelle. Febbraio era uno dei mesi più freddi a San Pietroburgo. Di certo vino speziato e brezel mi avrebbero ritemprato più in fretta del bordeaux. Pietro era abbastanza al caldo nella stanza accanto? Non sopportava il freddo, e sul campo di battaglia gelavamo sempre. Nulla è più gelido del mattino dopo una battaglia. Di notte, quando si abbandonava ai nostri amplessi, lo riscaldavo.
Le persone addormentate appaiono ridicole oppure commoventi. Menšikov che russava a bocca aperta rientrava nella seconda categoria. Estrassi il testamento di Pietro dalla manica e me lo srotolai in grembo, vicino al camino. Le lettere si confusero appena le lacrime affiorarono: lacrime autentiche, sincere, nonostante il sollievo. Mi attendeva una lunga giornata e settimane che lo sarebbero state ancora di più, di lacrime dunque avrei avuto gran bisogno. Il popolo e la corte avrebbero preteso una moglie sconvolta dal dolore, scarmigliata, con le guance rigate, la voce rotta e gli occhi gonfi. Soltanto la mia capacità di mettere in scena l’amore e il lutto avrebbe potuto rendere accettabile l’inaudito: le lacrime erano più potenti di qualunque linea di sangue. Forse avrei dovuto cominciare a piangere subito, adesso. Non sarebbe stato difficile evocare le lacrime: nel giro di qualche ora avrei potuto essere morta o desiderare di esserlo, oppure sarei potuta diventare la donna più potente di tutte le Russie.
1
—
La mia vita cominciò con un crimine. Naturalmente non mi riferisco al momento della mia nascita né ai miei primissimi anni. È preferibile non sapere nulla della vita da servo, da anima, che conoscerla un poco. Le anime tedesche – nemtsy, proprietà della chiesa russa – erano quanto di più miserabile si possa concepire. Il luogo dimenticato da Dio in cui sono cresciuta è sperduto nelle vaste pianure della Livonia: un villaggio, e un paese, che non esistono più. Chissà se le sue capanne malmesse, le isbe, sono ancora in piedi. Non lo so, né mi importa. Quando ero giovane, però, le isbe allineate come i grani del rosario di un monaco lungo la terra rossa della strada del villaggio erano il mio mondo. Usavamo la stessa parola per entrambi: mir. Il nostro era come tanti altri piccoli villaggi della Livonia svedese, una delle regioni baltiche sotto il dominio di Stoccolma, dove polacchi, lettoni, russi, svedesi e tedeschi vivevano insieme in maniera più o meno pacifica. All’epoca, almeno.
Nel corso dell’anno, la strada principale teneva insieme le nostre vite come la cintura di un ampio sarafan. Dopo il disgelo primaverile, o le prime forti piogge autunnali, immersi
fino alle ginocchia guadavamo la fanghiglia rossa quanto sangue di bue dalla nostra isba verso i campi e poi giù fino al fiume, la Dvina. In estate, nuvole di polvere rossa si alzavano dalla terra per insinuarsi nella pelle screpolata dei talloni. E in inverno a ogni passo affondavamo nella neve fino alle cosce, o scivolavamo verso casa sul ghiaccio liscio come uno specchio. Galline e maiali vagavano per le strade, la sporcizia che si appiccicava alle piume e alle setole. Lì giocavano i bambini, coi capelli arruffati infestati dai pidocchi, prima di diventare abbastanza grandi per lavorare, mentre i ragazzi se ne stavano nei campi a scacciare gli uccelli selvatici con sonagli, pietre e bastoni. Le fanciulle lavoravano ai telai del monastero, le dita esili che davano vita ai tessuti più raffinati. Io aiutavo nelle cucine fin dall’età di nove anni. Di tanto in tanto un carro tirato da cavalli con lunghe criniere e zoccoli pesanti attraversava con fracasso il villaggio per consegnare le sue mercanzie al monastero e andare poi a venderle al mercato. A parte questo, succedeva ben poco.
Un giorno di aprile, poco prima di Pasqua – era l’anno 1699, secondo il nuovo calendario che lo zar aveva imposto ai suoi sudditi –, con Christina, la mia sorella minore, percorrevamo la strada dirette ai campi e da lì al fiume. L’aria era pura e profumava della più grande meraviglia delle nostre terre baltiche: l’ottepel’, il disgelo. Christina danzava: girava in tondo e batteva le mani, felice per la fine della cupezza e del freddo invernali. Io cercavo goffamente di prenderla senza far cadere il bucato, ma lei si sottraeva.
Durante l’inverno la vita nel mir andava in letargo, simile al respiro leggero di un orso che si nutre del grasso sotto la pelliccia fino a primavera. In quella lunga stagione, la luce plumbea ci offuscava la mente; sprofondavamo in una tristezza apatica affogata nel kvass. Nessuno poteva permettersi la vodka, e la bevanda fermentata e amarognola dal forte sapore di lievito era davvero inebriante. Vivevamo di cereali – avena, segale, orzo, grano e farro, che cuocevamo in focacce non lievitate o usavamo per preparare i dolci nei giorni di festa, stendendo la pasta sempre più sottile, per poi farcirla con verdure sottaceto e funghi. La kaša, polenta d’avena, veniva addolcita con miele e bacche essiccate, oppure insaporita con cotenna di maiale e cavolo. Di quest’ultimo preparavamo grandi quantità ogni autunno, sminuzzandolo, salandolo e riducendolo a una poltiglia che mangiavamo tutti i giorni. Ogni inverno pensavo di sentirmi male all’idea di dovermi nutrire di nuovo con quella roba, ma d’altro canto se eravamo vivi lo dovevamo ai crauti. Mangiarli ci aiutava a sopportare un freddo che ti congelava il catarro in gola prima ancora di riuscire a sputare.
Proprio quando stavano per diventare insopportabili, la neve e il gelo svanivano lentamente. Dapprima la luce, che indugiava qualche istante in più, o i ramoscelli che si raddrizzavano non più gravati del peso della neve. Poi, di notte, il suono assordante del ghiaccio che si spaccava sulla Dvina a svegliarci; l’acqua sgorgava libera, impetuosa, e la corrente lacerava i lastroni di ghiaccio. Nulla poteva contenerne la potenza, persino i ruscelli più piccoli si gonfiavano e rompevano gli argini, mentre i pesci squamosi della Dvina saltavano nelle reti di loro spontanea volontà. A una breve e fragrante primavera seguivano i febbrili mesi estivi, con il nostro mondo ebbro di fertilità e vigore. Le foglie sui rami erano rigogliose e grasse, le farfalle mulinavano nell’aria, le api, appesantite dal nettare e con le zampe cariche di polline, e tuttavia smaniose di indugiare sull’ennesimo fiore. Nessuno dormiva in quelle notti bianche, persino gli uccelli non la smettevano più di cantare, per non perdersi neppure un istante di quell’atmosfera festosa.
«Pensi ci sia ancora ghiaccio sul fiume, Marta?» mi domandò Christina un po’ nervosa, chiamandomi con il mio antico nome. Quante volte me l’aveva già chiesto dacché eravamo uscite di casa? La fiera di primavera si sarebbe tenuta l’indomani, e proprio come lei desideravo strofinarmi via dalla pelle il puzzo di fumo e cibo e i monotoni mesi invernali per quello che era il momento più bello dell’anno. Avremmo assistito a spettacoli meravigliosi e assaggiato vere delizie, quelle che potevamo permetterci almeno. Sarebbero giunti spettatori dal mir vicino, oltre a qualche bizzarro e affascinante forestiero, a cui Christina poi non smetteva di pensare. «Facciamo a chi arriva prima?» propose, ridacchiando. Senza darmi il tempo di rispondere scattò, ma io le feci lo sgambetto per poi afferrarla prima che inciampasse e cadesse. Christina urlò e si aggrappò a me come un ragazzo che tenta di cavalcare un toro alla fiera, prendendomi a pugni; persi l’equilibrio e cademmo sul terrapieno, dove le primule e l’aubrezia erano già in fiore. L’erba giovane mi solleticava le braccia e le gambe nude mentre cercavo di rimettermi in piedi. Oh, benissimo: i vestiti erano tutti sparsi sulla strada polverosa. Ora sì che andavano lavati. Almeno potevamo farlo giù al fiume, solo qualche settimana prima avevo dovuto rompere il ghiaccio con un bastone nella vasca sul retro dell’isba e scansare i blocchi mentre sfregavo. Le mani mi si erano congelate, e i geloni sono lenti e dolorosi a guarire.
«Forza, ti aiuto» disse Christina, lanciando un’occhiata verso il villaggio. Dall’isba non potevano vederci.
«Non c’è bisogno che mi aiuti» dissi, anche se il bucato mi pesava.
«Non essere sciocca. Prima laviamo tutto quanto, prima potremo fare il bagno.» Prese metà della biancheria che tenevo col braccio. Di solito non ci dividevamo le incombenze, perché Christina era la figlia di Tanya, la moglie di mio padre. Io ero nata nove mesi dopo il solstizio d’estate da una ragazza del villaggio vicino. Mio padre, già fidanzato con Tanya quando mia madre scoprì di essere incinta, non era obbligato a sposarla: in simili questioni erano i monaci ad avere l’ultima parola, e loro, naturalmente, preferivano fargli sposare una delle loro fanciulle. Quando mia madre morì dandomi alla luce, Tanya mi prese con sé. Non aveva molta scelta: i miei parenti materni si erano presentati sulla soglia dell’isba e le avevano consegnato quel fagottino. Se si fosse rifiutata, mi avrebbero abbandonato sul limitare della foresta e lasciato in balia dei lupi. Tanya non mi trattava così male, in fondo. Tutti dovevamo sgobbare, e io ricevevo la mia razione di cibo, né più né meno. Spesso però era perfida, e mi tirava i capelli o mi pizzicava le braccia al minimo errore. «Sei proprio una bastarda. Tua madre apriva le gambe per chiunque. Chi lo sa da dove vieni davvero?» mi diceva quando era in vena di malignità. «Guardati, con quegli occhi verdi a mandorla e i capelli neri come le ali di un corvo. Ti conviene fare molta attenzione.» Se mio padre la sentiva, non le diceva niente, ma si rattristava più del solito, la schiena piegata dal lavoro nei campi del monastero. Riusciva a esplodere nella sua risata sdentata solo quando beveva qualche tazza di kvass, che gli instillava una luce spenta negli occhi incavati.
Prima di rimetterci in cammino, Christina mi prese per un braccio e mi fece voltare verso il sole. «Uno, due e tre… chi riesce a guardare il sole più a lungo?» disse d’un fiato. «Fallo. Anche se ti brucerà le palpebre! Fra le macchie che danzano davanti ai tuoi occhi, vedrai l’uomo a cui andrai in sposa.»
Eravamo così impazienti di sapere chi sarebbe stato: a mezzanotte accendevamo tre preziose candele intorno a una ciotola d’acqua e le circondavamo di braci, poi restavamo lì a fissare la superficie, che tuttavia rifletteva soltanto i nostri volti. Non passava festa di mezza estate senza che raccogliessimo sette tipi di fiori selvatici per farne un mazzolino da mettere fra i cuscini per attirare in sogno i nostri futuri mariti. Sentivo il caldo sole del pomeriggio sul viso e le macchie danzavano dorate e caotiche sotto le palpebre, così baciai Christina sulla guancia. «Andiamo» dissi, pregustando le rocce tiepide in riva al fiume. «Voglio asciugarmi per bene, dopo aver fatto il bagno.»
Nei campi, tra gli schiavi piegati sul loro lavoro, notai mio padre. In primavera soltanto una parte della terra veniva coltivata per il primo raccolto, mentre in estate venivano piantati rape, barbabietole e cavoli in una diversa area del campo – tutte colture in grado di sopravvivere anche in inverno, quando il terreno era indurito dal gelo. Il resto veniva lasciato a maggese fino all’anno successivo. Il periodo di raccolta delle provviste per i mesi a venire era breve, e anche qualche giorno sprecato poteva significare la fame. In agosto mio padre trascorreva fino a diciotto ore nei campi. No, non amavamo la terra che ci sfamava: era una padrona spietata, che ci puniva per il più piccolo errore. Sei giorni alla settimana appartenevano al monastero, il settimo a noi. Dio non concedeva neppure una giornata di riposo ai servi. I monaci facevano avanti e indietro fra i contadini nelle loro lunghe tonache nere, controllando attentamente la loro proprietà, ossia la terra e gli individui che la lavoravano.
«Cosa pensi che ci sia sotto la tonaca di un monaco?» mi domandò Christina, allusiva.
Mi strinsi nelle spalle. «Non dev’esserci granché, altrimenti si vedrebbe attraverso l’abito.»
«Soprattutto quando ti guardano» ribatté lei.
Le sue parole mi fecero tornare alla mente gli insulti di Tanya. «Cosa intendi dire?» domandai in tono brusco.
«E pensare che sei più grande di me, Marta» esclamò lei. «Non dirmi che non hai mai notato come ti guardano gli uomini. Alla fiera vogliono tutti ballare con te, e nessuno mi degna di uno sguardo.»
«Non dire sciocchezze! Tu sembri un angelo… un angelo con un disperato bisogno di un bagno! Andiamo!»
Al fiume ci sistemammo nello stesso punto poco profondo dell’anno precedente. Un sentierino serpeggiava attraverso un boschetto di betulle e bassi cespugli. I rami erano ricoperti di boccioli; presto sarebbero fioriti l’erba zolfina e l’iris selvatico. Sulla riva divisi il bucato, le camicie e i calzoni di lino degli uomini da una parte, e i sarafan e le tuniche di lino che noi donne indossavamo nei giorni di festa dall’altra. Avevamo trascorso molte delle lunghe serate invernali a ricamare colorati motivi floreali sui colletti. Forse alla fiera dell’indomani avremmo dovuto scambiare alcuni dei lavoretti in legno di mio padre – piccole pipe e tazze – con del filo nuovo? Raccolsi i capelli in una crocchia morbida in modo che non finissero nella schiuma sporca e mi sistemai il fazzoletto sbiadito sulla testa per ripararmi dal sole. Poi infilai l’orlo della gonna nella cintura e tirai i lunghi nastri delle maniche. Da lontano dovevo sembrare una nuvola appoggiata su un paio di lunghe gambe nude.
«Forza.» Allungai le braccia per prendere il primo capo e Christina mi passò il prezioso sapone, che strofinai con cura sulle scanalature dell’asse per il bucato immerso nell’acqua limpida fino a creare uno strato scivoloso. Fare il sapone era un lavoro faticoso; una volta finito avevi dolori dappertutto. Quasi sempre Tanya mi affidava questo incarico in autunno, quando i monaci, dopo aver macellato le bestie per affumicare, salare e mettere in salamoia la carne per la scorta invernale, lasciavano parte delle ossa; oppure in primavera, sfruttando la cenere conservata durante l’inverno. Tutte le donne contribuivano a mescolare acqua piovana e cenere con grasso di maiale o di bue e a macinare le ossa degli animali per preparare la liscivia, che veniva bollita per ore in grandi pentoloni. Il miscuglio, grigio e viscido, si addensava molto lentamente, con grosse bolle incandescenti che salivano in superficie con sonore esplosioni. Bisognava girarlo in continuazione, finché ti sembrava di non sentire più le braccia, e la sera versavamo quell’ammasso appiccicoso in stampi di legno. Se potevamo permetterci di aggiungere del sale, alla fine ottenevamo un pezzo di sapone compatto. Il sale però ci serviva soprattutto per gli animali, o per la salamoia della carne e i cavoli in vista dell’inverno: il sapone era più che altro una poltiglia che si aggiungeva all’acqua del bucato.
Il fiume scintillava, Christina e io lavoravamo leste: la prospettiva del bagno ci spronava mentre immergevamo i vestiti nell’acqua, li strofinavamo con forza e li battevamo sulle pietre piatte. «Immagina che sia l’abate» dicevo a Christina perché li battesse più forte, e lei buttava la testa indietro e rideva, i capelli biondi che le si sfilavano dalla crocchia. Strizzavamo e appendevamo il bucato ad asciugare sui rami bassi lungo la riva. «Pronti, partenza… via!» urlò lei a un tratto, mentre stavo ancora sistemando e lisciando le ultime camicie. Si slacciò il nodo della cintura, sfilandosi il sarafan e la sottoveste grezza dalla testa mentre correva, poi rimase in piedi nuda nel sole di primavera. Com’era diversa da me! La sua pelle era candida come il latte, il corpo snello, con fianchi stretti e alti seni acerbi che la mano a coppa sembrava contenere alla perfezione. I capezzoli somigliavano a piccoli lamponi. Poteva già partorire: aveva cominciato a perdere sangue un anno prima. Io, invece… be’, forse Tanya aveva ragione nel dire che assomigliavo a mia madre. Avevo folti capelli neri e la pelle del colore del miele selvatico – o del moccio secco, come diceva sempre la mia matrigna. Fianchi ampi, gambe lunghe e forti, e seno sodo e generoso.
Christina sguazzava nella corrente poco profonda vicino alla riva. La testa andava su e giù fra le rocce dove l’acqua si raccoglieva in pozze, e la sabbia sul greto del fiume risplendeva candida fra i suoi piedi quando riemergeva. «Vieni! Cosa stai aspettando?» chiese ridendo, poi si tuffò di testa fra le onde, lasciando che la corrente la trascinasse a fondo. Mi spogliai in fretta, mi sciolsi i capelli e la raggiunsi correndo…