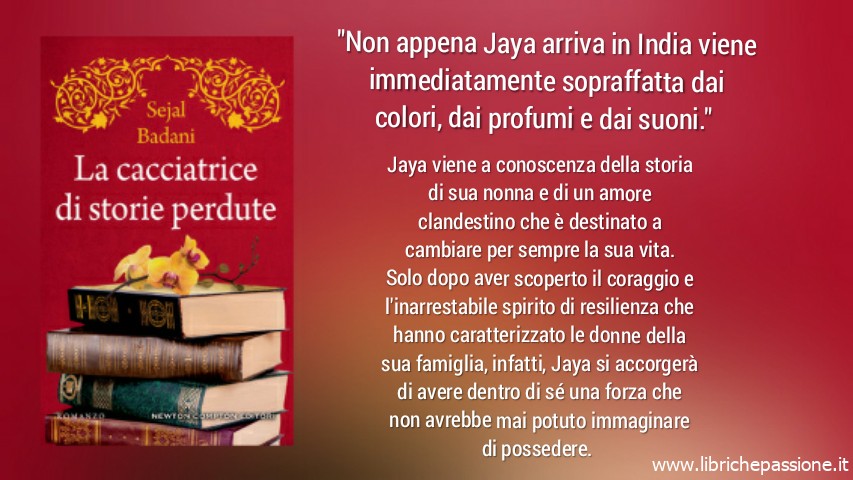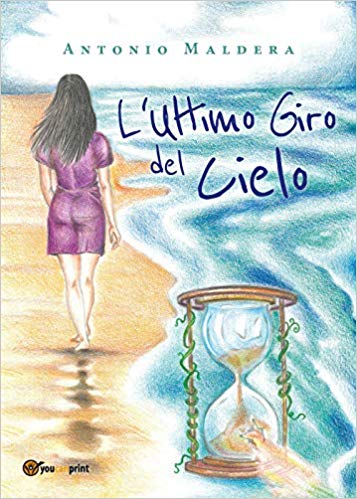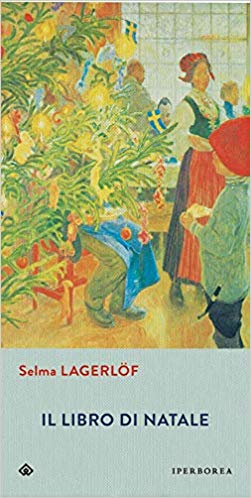Un grandissimo talento, una favolosa bellezza, un’intelligenza acuta e sensibile. Nata a Boston nel 1932, Sylvia Plath mostra segni della sua eccezionalità fin da bambina e sembra destinata a una vita di soddisfazioni e successi. Pubblica la prima poesia a dieci anni, a diciotto vince una borsa di studio per il più prestigioso college femminile della East Coast americana, a ventitré va a terminare gli studi a Cambridge grazie a una borsa Fulbright. Qui incontra l’uomo della sua vita, Ted Hughes, giovane poeta dal brillante futuro, di cui si innamora perdutamente e che sposa. Belli e talentuosi, vivono tra le due coste dell’Atlantico, dedicandosi pienamente alla loro poesia e ai due figli. Una favola perfetta? All’alba dell’11 febbraio 1963, a trent’anni, Sylvia Plath si toglie la vita. Dietro di sé lascia incredibili poesie e un triste interrogativo su questa drammatica scelta. Attraverso la sua voce, ascoltiamo la storia di una delle più grandi poetesse del Novecento, la dolorosa lotta tra le sue luci e le sue ombre, l’ascesa e la caduta. La divina fragilità di un’anima.

A mio padre, che era Elvis, era il re
Prologo
11 febbraio 1963
Non esiste stazione finale, solo valigie.
Totem
Liscio e freddo, così sospetto sia infine il ventre della balena che t’inghiotte. Silenzioso, glabro e dannatamente confortevole.
Sto comoda, come se avessi la faccia posata sulla pietra liscia, sopra la scogliera. La testa appoggiata sul fianco, gli occhi aperti sul fondo oscuro di questa caverna. La sensazione deve essere simile a quella dell’attore che sta dietro al sipario prima dell’inizio della scena, nell’oscurità che ti penetra le pupille e ti si allarga fino al cuore e ne spegne il tumulto.
Sì, credo sia questo il silenzio favoloso che si sparge nelle molecole d’aria e le fa sottili, rade, infinitamente importanti. L’istante prima del debutto è il migliore, il più bello, l’unico per cui valga la pena di avere i piedi nei sandali dal profilo appuntito, le narici invase dall’odore asciutto della polvere attaccata al velluto del sipario, la lingua vigile nell’incavo della bocca, tesa e pronta alla battuta.
Mi chiamo Sylvia e ho la testa nel forno.
Così ha cessato la sua lugubre danza di piume l’uccellino raccolto da terra e accudito nella scatola di cartone. Ci abbiamo provato, lo abbiamo nutrito, ma non era abbastanza. I confini della scatola gli ferivano le ali, indelebilmente. Sembrava un pazzo, ostinato a cercare il varco nel muro, la formula segreta del volo. Fremeva e io sentivo sotto pelle quel dolore. Ted ha preso un tubo di gomma, ne ha inserita un’estremità nel beccuccio del gas e l’altra in un foro nella scatola. Il povero essere piumato agitava le zampette, spalancava il piccolo becco. Il gas ha infine stremato le sue convulsioni, le sue ambizioni inadeguate allo spazio, gli ha ridato la pace che aveva perduto venendo al mondo. Una pace pulita, integra, il lenzuolo perfettamente steso prima dell’amplesso. Il gas è stato il filo per ricongiungerlo con l’inizio. Per questo l’ho scelto. Perché pulito, invisibile, deterso dall’orrore.
Sento un leggero sfarfallio a una gamba, la posizione immobile rende forse inutile il flusso del sangue, che pertanto si assopisce, diventa più languido, tende ad arrestarsi. È bello pensare che il mio corpo si senta libero da impegni, sgravato per una volta dall’onere di sostenere la mia esistenza. Mi piace immaginare le mie cellule sciogliersi da un abbraccio forzato e sentirsi libere di sovvertire un ordine definito, di svincolarsi dal dovere del miracolo. La vita è un’immensa forzatura, un’enorme catena di continui meccanismi perfetti: sessanta battiti al minuto, un circuito di vene, arterie, capillari da riempire, una rete di sottili impulsi elettrici da diffondere per attivare altrettanti muscoli da impegnare in uno sforzo per noi impercettibile. Tanto costa al nostro corpo lo stupido sorriso lanciato senza pensiero al lattaio.
Sento ora dentro di me la pace della perfezione, la compiutezza del gesto. Loro dormono nei propri lettini, l’aria fredda di febbraio li protegge da scelte che non hanno compiuto. Il latte nei minuscoli bicchieri, il pane e il burro, le gioie bambine. L’ho fatto per loro, perché al risveglio il bianco sia la risposta alla notte. Ho voluto essere madre finché possibile, ho voluto sorprendermi con una quotidianità che è stato l’ultimo sguardo dell’uccellino rivolto verso l’interno della gabbia, intinto di assurda benevolenza.
avidi il fondo del suo mantello, la voglia nuda e inerme. Da qui, nulla trapela. Mi sorprende osservare questo buio, che è diverso da quello che c’era dietro alla finestra fino a qualche istante fa o dentro alle stanze che percorrevo a piedi nudi. Mi sembrava quasi di nuotare in un’acqua gelida e assolutamente immobile, di guadare fiumi le cui sponde non trovavo. Da una stanza all’altra, aggrappandomi ai mobili come fossero rocce affioranti dagli spigoli taglienti. Nulla riconosci nel buio di ciò che alla luce vive. È un altro universo, retto da altre leggi, dove non contano i dettagli, ma solo l’insieme. Che importanza vuoi che abbia se hai una sedia Chippendale o Thonet, un comò in stile Impero o una lampada in vetro di Murano? Nella notte sono solo masse che interrompono la linearità del buio, lo fanno più denso, più profondo, lo fanno materia solida. In effetti, a pensarci bene, sono molti gli aspetti del buio che ho conosciuto.
Quello della notte, denso e colloso, come l’afa che ti stringe, l’abbraccio di un amante che pretende il possesso di ogni linea del tuo corpo.
Quello del sonno, vivo di colori smorti, mai fino in fondo compiuti, sciolti o spenti prima ancora di averli afferrati.
Quello del silenzio, che ti passa dalle orecchie, ti ottunde la vista con piccole scintille, diventa liquido fiume nelle vene e ti appaga fino a stordirti.
Mi sono vestita, con cura. Non amo la trascuratezza della morte, la trovo oscena e imperdonabile. Vorrei che le mie ossa non ingiallissero, non si corrompessero in altro pasto che non sia l’eternità, mi piace pensare una compostezza nel nostro divenire asciutti atomi, un’eleganza da perpetuare come un segno distintivo dell’universo. Ho scelto i sandali bianchi, perché sono quelli che ho indossato in occasioni speciali e che quando ho comprato mi sono costati una fortuna. Un vezzo femminile che non riesco a sprecare, giustificandolo come una necessità, fino in fondo. Immagino che il mattino stia proseguendo la sua corruzione della notte, le stia strappando con morsi avidi il fondo del suo mantello, la voglia nuda e inerme. Da qui, nulla trapela. Mi sorprende osservare questo buio, che è diverso da quello che c’era dietro alla finestra fino a qualche istante fa o dentro alle stanze che percorrevo a piedi nudi. Mi sembrava quasi di nuotare in un’acqua gelida e assolutamente immobile, di guadare fiumi le cui sponde non trovavo. Da una stanza all’altra, aggrappandomi ai mobili come fossero rocce affioranti dagli spigoli taglienti. Nulla riconosci nel buio di ciò che alla luce vive. È un altro universo, retto da altre leggi, dove non contano i dettagli, ma solo l’insieme. Che importanza vuoi che abbia se hai una sedia Chippendale o Thonet, un comò in stile Impero o una lampada in vetro di Murano? Nella notte sono solo masse che interrompono la linearità del buio, lo fanno più denso, più profondo, lo fanno materia solida. In effetti, a pensarci bene, sono molti gli aspetti del buio che ho conosciuto.
Quello della notte, denso e colloso, come l’afa che ti stringe, l’abbraccio di un amante che pretende il possesso di ogni linea del tuo corpo.
Quello del sonno, vivo di colori smorti, mai fino in fondo compiuti, sciolti o spenti prima ancora di averli afferrati.
Quello del silenzio, che ti passa dalle orecchie, ti ottunde la vista con piccole scintille, diventa liquido fiume nelle vene e ti appaga fino a stordirti.
Quello della morte, con cui ho sempre avuto maggiore confidenza, che ti accarezza, ti sfiora, ma mai lo afferri finché respiri.
Qui, in questo utero di latta, il buio è asettico, privo di giudizi, primordiale e amichevole. C’è spazio per entrambi, lui mi circonda come una corona, un’aureola di santità purificata dall’assenza totale di gesti. Non posso muovermi, né in realtà lo vorrei anche se potessi. Non ne ho necessità, poiché ho già tutto preparato, tutto compiuto. Posso però ripercorrerlo chiudendo gli occhi, che dietro alle palpebre si muovono intermittenti, come un singhiozzo muto. Posso ripercorrerlo, perché ho tempo e ancora il fiato lo alimenta.
All’inizio sono tutte saette, brevi lampi crudi, fotogrammi impazziti che non mi danno il tempo di avvinghiarmi, di attaccarmi con le unghie allo stretto bordo per poterli seguire, distinguere uno dall’altro. Sono confusi, ostinatamente annebbiati, quasi lo facessero apposta per non svelarsi, per confondermi. Il paesaggio che scorgi dal finestrino di un treno che passa attraverso innumerevoli gallerie, sincopato. Sul più bello, beffardo. Quando ti sembra di aver capito, di aver afferrato i confini, l’orizzonte, lo stacco tra terra e cielo, ecco che arriva un taglio in nero, senza preavviso. Stai con il fiato sospeso, per quanti minuti? Uno, due, dieci? L’eternità? Poi, con la stessa violenza, il buio si strappa e ritorna un chiarore lanuginoso e un paesaggio che ha contorni diversi, diversi colori, geometrie con altri nomi. E tutto ricomincia da capo, devi ritrovare i punti cardinali e una storia da ricostruire. Cerchi gli elementi comuni, quelli che si ripetono, che ti sono famigliari. O ti lasci guidare da sensazioni che appaiono vaghe, ma di cui senti il sapore penetrante nella gola.
Dietro ai miei occhi chiusi, cerco di ricomporre un paesaggio, il mio. La mia vita che si è disegnata fuori dal finestrino, stazione dopo stazione, tra una galleria e l’altra, tra un buio e l’altro. Torno indietro, prima di entrare in questa che è l’ultima, l’ultima galleria.
Cerco di capire. Lo devo a questi ultimi istanti.
Come sono arrivata fino a qui, la strada che ho fatto, i luoghi che ho vissuto. Come sono arrivata all’ultima galleria.
23 Fitzroy Road, London
La poesia
1962-1963
È un cuore, questo olocausto in cui cammino…
Il canto di Maria
Per cena avevo riscaldato i resti dello stufato di manzo. Frieda faceva i capricci perché non lo voleva e invidiava a Nicholas il suo latte. Girava la forchetta nel piatto, trascinandola in senso orario, sporcandone i bordi con il dispetto negli occhi. Il freddo della stanza aveva già rappreso il grasso che sembrava lucido e splendente sotto la luce elettrica, una disgustosa brillantina di cui la carne si ammantava, sfavillante e unta coscia di ballerina già vecchia e andata a male, lo spettacolo deprimente di una bettola di quart’ordine. Sapevo che avrei dovuto sentirmi avvilita da tutto quello, ma avvertivo invece quasi un’esaltazione perversa. Per quella sera, quella era la cena. Uno stufato di manzo come chissà quanti altri, né meglio, né peggio.
Frieda però pareva non arrendersi, non si placava all’ineluttabilità di quell’offerta e continuava a piagnucolare. Li guardavo in quel loro essere piccoli e lagnanti, liberi dall’obbligo dell’apparenza, con le guance arrossate, lei dalla frustrazione e lui dall’ignara soddisfazione. Due nanetti presi in un battibecco da circo, due clown bambini con una tristezza bianca e rossa dipinta sotto gli occhi, che colava via con finte lacrime. Mi facevano venire in mente me e Warren, perché niente di quel che noi eravamo c’era in loro. Era un conforto che mi dava un breve sorriso. Mi faceva sperare che da grande Frieda sarebbe rimasta lontana dalla poesia, così come ora rifuggiva l’orco delle fiabe. Mi faceva sperare nella sua salvezza, in una sua quieta e domestica dannazione.
«Mami, non mi piace questo cibo, ti prego, non lo voglio.»
La osservavo semplicemente, senza una reazione, con lo sguardo che la trapassava come se fosse stata una brocca d’acqua trasparente, il cui mondo al di là era confuso in una vaga nebbia d’azzurro e celeste, dai contorni imprecisi, sfumati, dalle identità molteplici. Frieda ricambiava il mio sguardo ammutolendo per qualche istante il suo lamento, cercando forse di comprendere il mio silenzio privo d’espressione. Poi ricominciava a chiamare la mia attenzione. «Mami, mami, mami.» Guardare al di là della trasparenza della sua infanzia, mi dava qualche briciola di sollievo. Un breve tempo attonito nel quale accoccolarmi, gatto randagio nell’anfratto di un muro. Era la nostra prima cena al 23 di Fitzroy Road. Eravamo venuti a vivere qui da poche ore e mi era parso subito chiaro che quelle erano le quattro mura che delimitavano una tomba.
Ero tornata a Londra dal Devon il 29 e il 30 ottobre per incontrare Al Alvarez e mostrargli il raccolto mietuto delle mie ultime poesie. Per la prima volta affrontavo le voci della città, gli amici, gli incontri, nella veste di donna separata. Tutti probabilmente ormai sapevano che Ted era a Londra con lei, Assia, la “donna di cenere”. Mi ero decisa a esporre la sottile pellicola con cui contenevo il mio dolore ai graffi degli sguardi compassionevoli e imbarazzati dei conoscenti, anche a rischio che si potesse strappare in qualche punto e qualcosa di quel dolore amaro fuoriuscisse senza poterlo evitare. Ma dovevo farlo, dovevo riportarmi al mondo.
Dopo il ritorno dall’Irlanda, Court Green era stata quasi una serra per me. Lì avevo dedicato instancabili cure alla mia poesia, assottigliando me stessa giorno dopo giorno per nutrirla, accudendola in notti di veglia appena imbastardite dalle pillole. Sapevo che per rinascere dovevo distruggere quella me che non ero io e per questo brandivo le parole come coltelli, per fare a pezzi quell’ossessione velenosa che mi aveva portato fin lì. E intanto, a poco a poco, la poesia si solidificava intorno a me, diventando ossea, diventando il mio nuovo scheletro. Così come facevo da bambina, con forbici affilate dalla perfetta educazione, avevo ritagliato la figura della buona moglie come una bambola di carta, seguendo i precisi contorni di un’idea che non mi apparteneva davvero. Quella figurina stava svanendo, macerata dalle lacrime corrosive e acide del lutto.
Dall’umida poltiglia rimasta, Sylvia rinasceva. Portarla su di me di fronte agli altri era il primo passo perché lei potesse di nuovo imparare a camminare.
Al mi aspettava. Eravamo nel suo salotto e avevamo un bicchiere di brandy in mano nonostante fossero solo le due del pomeriggio.
Mi accorsi subito che c’era una sorta di reticenza nella sua gioia di vedermi: era amico di Ted e io ero la moglie tradita. L’isterica, pazza moglie tradita.
Non credo che lui mi considerasse così, …

Antonella Grandicelli è nata a Genova, dove si è laureata in lettere moderne. Nel 2016 esordisce con il romanzo noir Le ali dell’angelo (Robin Edizioni), mentre nel 2021 esce per Fratelli Frilli Editori Il respiro dell’alba. Un caso per Vassallo e Martines.
Ha scritto racconti per varie antologie tra cui “Genovesi per sempre” (Edizioni della Sera, 2019), “Tutti i sapori del noir” (Fratelli Frilli Editori, 2019), “I luoghi del noir” (Fratelli Frilli Editori, 2020), “Natale a Genova” (Neos Edizioni, 2019 e 2020), “La Liguria sorride” (Lo Studiolo, 2020). È co-founder insieme ad Arianna Destito del blog culturale TheMeltinPop.com.
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso