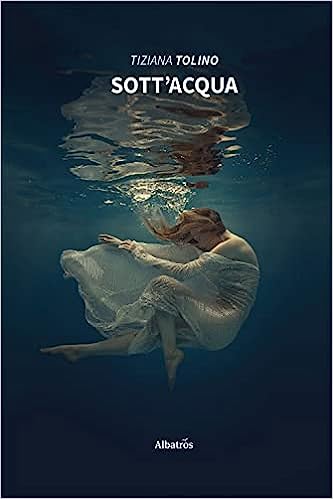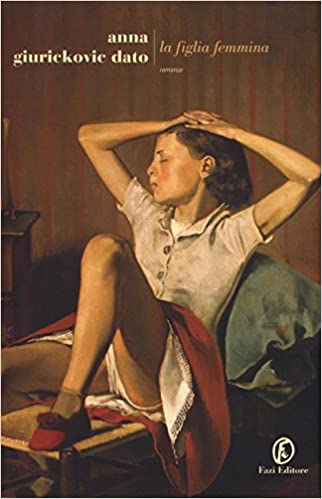edito da Rizzoli disponibile in tutte le librerie e sugli store on-line
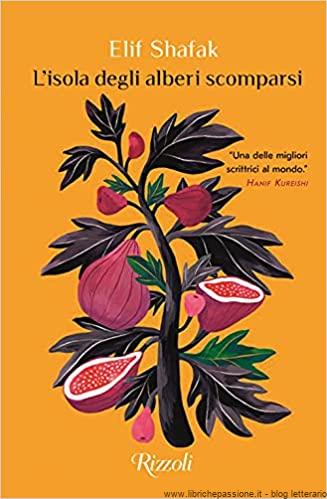

Dall’autrice di La bastarda di Istanbul, un racconto soffuso di magia che ci parla di amore, identità, senso di appartenenza, dei misteri della natura e del potere della rinascita.
Nata e cresciuta a Londra, Ada Kazantzakis, sedici anni, non sa niente del passato dei suoi genitori. Non sa che suo padre Kostas, greco e cristiano, e sua madre Defne, turca e musulmana, negli anni Settanta erano due adolescenti in quell’isola favolosa di acque turchine e profumo di gardenie chiamata Cipro. Non sa che i due si vedevano di nascosto in una taverna di Nicosia, dalle cui travi annerite pendevano ghirlande d’aglio e peperoncini. Non sa che al centro di quella taverna, testimone dei loro incontri amorosi, svettava un albero di fico. E non sa che l’albero, con le fronde che uscivano da un buco sul tetto, era lì anche quando l’eterno conflitto dell’isola, spaccata in due lungo la «linea verde», si era fatto più sanguinoso e i due ragazzini non erano più venuti. Ora quello stesso albero, nato da una talea trafugata anni prima a Londra, cresce nel giardino dietro la casa di Ada: unico, misterioso legame con una terra dilaniata e sconosciuta, con quelle radici inesplorate che, cercando di districare un tempo lunghissimo fatto di segreti, violente separazioni e ombrosità, lei ha bisogno di trovare e toccare. Pulsano, in questo libro spalancato sulla distruzione e gli esili provocati dalla guerra, colori luminosi e profumi d’erbe e olive nere; il battere delle ali di uccelli di ogni piumaggio; il canto ininterrotto delle fronde di un albero; il respiro sano di un amore e quello fiero della vita.

Agli immigrati e agli esuli in ogni dove,
agli sradicati, ai ri-radicati, ai senza radici
E agli alberi che ci siamo lasciati alle spalle,
radicati nei nostri ricordi…
Chi non conosce le foreste cilene non conosce questo pianeta.
Da quelle terre, da quel fango, da quel silenzio sono partito, per andare a cantare per il mondo.
Pablo Neruda, Confesso che ho vissuto
Vi sarà sangue, dicono: sangue vuol sangue; si è saputo di pietre che si sono mosse, e di alberi che hanno parlato…
William Shakespeare, Macbeth
L’isola
Tanti ricordi fa, al capo estremo del mar Mediterraneo, c’era un’isola talmente azzurra e bella che i molti viaggiatori, pellegrini, crociati e mercanti che se ne innamoravano non volevano più ripartire, oppure cercavano di rimorchiarla con funi di canapa fino al loro Paese.
Leggende, forse.
Ma le leggende stanno lì a raccontarci quel che la storia ha dimenticato.
Sono trascorsi molti anni da quando sono fuggita di là a bordo di un aeroplano, dentro una valigia di morbido cuoio nero, per non tornare più. Da allora ho adottato un altro Paese, l’Inghilterra, dove sono cresciuta e ho prosperato, ma non passa giorno senza che aneli di tornare. A casa. Nella madrepatria.
L’isola è certamente ancora là dove l’ho lasciata, sospinta su e giù dalle onde che s’infrangono schiumando sulle sue coste accidentate, crocevia fra tre continenti – Europa, Africa, Asia – e il Levante, quella vasta e impenetrabile regione del tutto scomparsa dalle carte geografiche odierne.
Una carta geografica è una rappresentazione bidimensionale fatta di simboli arbitrari e linee intagliate che stabiliscono chi dovrà esserci nemico e chi amico, chi merita il nostro affetto, chi il nostro odio, e chi la nostra totale indifferenza.
«Cartografia» è solo un altro modo di chiamare le storie raccontate dai vincitori.
Perché le storie raccontate da quelli che hanno perso non ce l’hanno, un nome.
Io me la ricordo così: spiagge dorate, acque turchine, cieli tersi. Le tartarughe venivano a riva ogni anno per deporre le uova nella sabbia finissima. Il vento del tardo pomeriggio si portava dietro un profumo di gardenie, ciclamini, lavanda, caprifoglio. Rami di glicine si arrampicavano come funi su muri imbiancati, con l’ambizione di toccare le nuvole e la speranza che solo i sognatori possiedono. Quando la notte ti baciava la pelle, e lo faceva sempre, le sentivi il gelsomino nell’alito. La luna, che qui è più vicina alla Terra, si accendeva leggera e luminosa sui tetti, gettando un bagliore intenso sui vicoli angusti e l’acciottolato delle vie. Eppure le ombre trovavano il modo d’insinuarsi nella luce; sussurri di diffidenza e congiura s’increspavano nel buio. Perché l’isola era spaccata in due parti: il Nord e il Sud. In ciascuna prevaleva una diversa lingua, una diversa scrittura e una diversa memoria, e quando pregavano, di rado gli isolani pregavano lo stesso dio.
La capitale era scissa da una divisione che la tagliava come un fendente al cuore. Lungo la linea di demarcazione – la frontiera – c’erano case fatiscenti crivellate di pallottole, cortili vuoti feriti da scoppi di granate, ruderi di negozi sbarrati, ornati cancelli che penzolavano storti dai cardini rotti, auto di lusso di un’altra epoca che si arrugginivano sotto strati di polvere… le strade erano bloccate da giri di filo spinato, pile di sacchi di sabbia, bidoni riempiti di cemento, trincee anticarro e torrette di guardia. Le vie terminavano di colpo, come pensieri incompiuti, emozioni irrisolte.
I soldati, quando non facevano la ronda, stavano di guardia con le mitragliatrici. Giovanotti solitari e annoiati che venivano dai quattro angoli del mondo e quasi nulla sapevano della complicata storia dell’isola, finché non si trovavano assegnati a quell’ambiente ignoto. Su tutti i muri, cartelli ufficiali a colori vistosi e caratteri di scatola:
È VIETATO L’INGRESSO
ALT, LIMITE INVALICABILE!
DIVIETO DI FOTO E RIPRESE
E poco più giù lungo la barricata, un’aggiunta abusiva in gesso, scarabocchiata su un bidone da un passante:
BENVENUTI NELLA TERRA DI NESSUNO
La demarcazione che squarcia Cipro da un’estremità all’altra è una zona cuscinetto pattugliata da truppe ONU. Lunga circa centottanta chilometri e larga fino a sei in alcuni punti, contro altri di appena qualche metro, attraversa molti e diversi territori – paesini abbandonati, entroterra costieri, zone umide, campi a maggese, boschi di conifere, pianure ubertose, miniere di rame e siti archeologici – serpeggiando per tutto il tragitto come il fantasma di un fiume preistorico. Ma è lì, dentro e intorno alla capitale, che si fa più visibile, tangibile e, per questo, tormentosa.
Nicosia, la sola capitale divisa rimasta al mondo.
Detta così, sembra quasi una cosa positiva: come se la città avesse qualcosa di speciale, di esclusivo addirittura, la dote di sfidare la gravità, come l’unico granello di sabbia che ascenda in una clessidra appena rovesciata. Di fatto, però, Nicosia non è un’eccezione ma solo l’ennesimo nome finito sull’elenco delle comunità separate e dei luoghi segregati, quelli già consegnati alla storia e quelli ancora da venire. In questo momento, però, rappresenta una singolarità: è l’ultima città divisa in Europa.
La mia città.
Ci sono molte cose che un confine – perfino uno netto e ben sorvegliato come questo – non può fermare. Il vento etesio, per esempio, il meltemi o meltem dal nome delicato ma dalla forza sorprendente. Le farfalle, le cavallette e le lucertole. Le chiocciole, anche, con tutta la loro mesta lentezza; e ogni tanto, un palloncino che sfugge alla presa di un bimbo, sale al cielo e devia verso l’altra parte… in territorio nemico.
Poi, gli uccelli. Aironi azzurri, zigoli testanera, falchi pecchiaioli, cutrettole, luì grossi, avèrle mascherate e i miei preferiti, i rigogoli. Percorso tutto l’emisfero boreale, migrando perlopiù la notte, l’oscurità che gli si raduna sulla punta delle ali e gli imprime cerchi rossi intorno agli occhi, fanno tappa qui a metà del loro lungo viaggio, prima di proseguire verso l’Africa. Per loro l’isola è un luogo di riposo, un omissis nel racconto, un’intermedietà.
A Nicosia c’è un colle dove vengono a procacciarsi il cibo e a consumarlo uccelli di qualsiasi piumaggio. È tutto invaso di roveti, ortiche e ciuffi d’erica. Nel folto di questa vegetazione c’è un vecchio pozzo, con una carrucola che cigola al minimo strappo e un secchio di metallo legato a una fune, sfilacciata per il disuso e ricoperta di alghe. Sul fondo è sempre buio pesto e freddo cane, anche quando ci batte il sole di mezzogiorno. Il pozzo è una bocca affamata che attende il prossimo pasto: divora ogni raggio di luce, ogni traccia di calore, trattiene ogni bruscolo nella sua lunga gola di pietra.
Se mai vi trovaste da quelle parti e, spinti dalla curiosità o dall’impulso, vi sporgeste dal bordo a guardarci dentro, una volta abituati gli occhi potreste scorgere un bagliore abissale, come lo sprazzo effimero delle squame di un pesce prima che scompaia di nuovo in acqua. Non lasciatevi ingannare, però: pesci, là sotto, non ce ne sono. Né serpi, né scorpioni, né ragni appesi a fili di seta. Il bagliore non viene da un essere vivente ma da un antico orologio da tasca, in oro a diciotto carati intarsiato di madreperla, con incisi i versi di una poesia:
La tua meta è approdare là.
Ma non far fretta al tuo viaggio.
E sul retro ci sono due lettere o, meglio, la stessa lettera ripetuta due volte:
Y & Y
Il pozzo è profondo dieci metri e largo poco più di uno. È fatto di pietre conce, appena ricurve, che in identici corsi orizzontali discendono fino alla superficie dell’acqua torbida e ferma. Intrappolati sul fondo ci sono due uomini, i proprietari di una taverna molto frequentata. Entrambi di corporatura snella e altezza media, con grandi orecchie a sventola sulle quali usavano scherzare; entrambi nati e cresciuti sull’isola, e sui quarant’anni d’età quando furono rapiti, picchiati e assassinati. Li hanno buttati là dentro dopo averli incatenati l’uno all’altro prima, e poi a una latta per olio d’oliva da tre litri riempita di cemento, per esser certi che non riemergessero mai più. L’orologio da tasca che uno dei due portava il giorno del sequestro si è fermato otto minuti esatti prima della mezzanotte.
Il tempo è un uccello canoro, e come ogni altro uccello canoro può essere catturato. Può essere tenuto prigioniero in una gabbia, e molto più a lungo di quanto si creda possibile. Ma non può essere tenuto sotto controllo in eterno.
Nessuna prigionia è per sempre.
Prima o poi l’acqua corroderà il metallo, le catene salteranno via e il cuore rigido del cemento si ammorbidirà, come spesso capita anche ai cuori più rigidi col passare degli anni. Solo allora i due cadaveri, finalmente liberi, partiranno a nuoto verso lo spiraglio di cielo che scintilla nei raggi rifratti del sole, saliranno verso quel serenissimo azzurro, dapprincipio lenti, poi più rapidi, ansanti come pescatori di perle in cerca d’aria.
PRIMA PARTE
Come seppellire un albero
La ragazza di nome isola
Inghilterra, fine anni 2010
Al liceo Brook Hill, Londra nord, era l’ultima lezione dell’anno. Aula di terza, ora di storia. Mancavano quindici minuti alla campanella e gli studenti cominciavano a farsi irrequieti, nell’ansia che iniziassero le vacanze di Natale. Tutti, a dire il vero, tranne una.
Ada Kazantzakis, sedici anni intensi e silenziosi, sedeva in fondo alla classe al solito posto vicino alla finestra. I capelli color mogano lucido erano legati in una coda bassa, l’espressione era tesa sul viso dai lineamenti delicati, e i grandi occhi castani tradivano forse l’insonnia della notte precedente. Ada non aveva la minima voglia di festività, né provava alcuna euforia all’idea di una nevicata. Ogni tanto lanciava uno sguardo furtivo fuori dalla finestra, ma senza cambiare espressione.
Verso mezzogiorno aveva grandinato, gelidi pallini lattiginosi che avevano ridotto a brandelli le ultime foglie e martellato il tetto della rimessa per le biciclette, rimbalzando a terra in un tip tap sfrenato. Adesso tutto era tornato tranquillo, ma si capiva bene che il tempo era molto peggiorato e che la bufera non era lontana. Quel mattino la radio aveva annunciato che entro quarantott’ore al massimo la Gran Bretagna sarebbe stata investita da un fronte polare, con temperature artiche, piogge ghiacciate e tormente di neve. Vaste aree di Inghilterra, Scozia e altre parti del Nord Europa rischiavano di essere paralizzate da interruzioni di acqua e corrente elettrica o da scoppi di condutture, e la gente aveva accumulato scorte – tonno e fagioli in scatola, pacchi di pasta, carta igienica – come per prepararsi a un assedio.
Per l’intera giornata i ragazzi avevano parlato solo della bufera, temendo per i rispettivi programmi di viaggio e vacanza. Tutti salvo Ada, che non aveva riunioni di famiglia né mete esotiche in vista: suo padre non intendeva andare da nessuna parte, perché doveva lavorare. Doveva sempre lavorare. Il padre di Ada era un malato di lavoro incurabile, chiunque lo conoscesse lo avrebbe confermato, ma da quando la madre di Ada era morta si era chiuso nelle proprie ricerche come gli animali si rintanano al caldo e al sicuro dei loro cunicoli.
A un certo punto della sua giovane vita lei lo aveva capito, di avere un padre molto diverso dagli altri, ma ancora faticava a prendere con filosofia la sua ossessione per le piante. I padri degli altri lavoravano in uffici, negozi o pubbliche amministrazioni e giravano in completo scuro, camicia bianca e lucide scarpe nere; il suo invece era sempre in giaccone impermeabile, calzoni di fustagno verde o marrone e scarponi robusti, e anziché la ventiquattrore si portava dietro una tracolla con dentro un misto di roba tipo lente d’ingrandimento, kit per dissezioni, pressa per fiori e foglie, bussola e taccuini. Gli altri padri cianciavano sempre e solo di finanza e piani pensionistici, mentre il suo aveva molto più a cuore gli effetti nocivi dei pesticidi sulla germinazione dei semi o l’impatto ambientale della deforestazione. Parlava dei danni da sfruttamento boschivo con la medesima passione che i suoi omologhi riservavano all’andamento dei rispettivi portafogli azionari; e non solo ne parlava, ma ne scriveva anche. Botanico ed ecologo evolutivo, aveva pubblicato dodici monografie. Una s’intitolava Il regno misterioso:
come i miceti cambiano il passato e plasmano il futuro. Un’altra era dedicata a piante antocerote, piante epatiche e muschi: in copertina, un ponte di pietra gettato su un ruscello che gorgogliava attorno a sassi foderati di velluto verde. Subito sopra la fiabesca immagine, il titolo a caratteri dorati Guida pratica alle briofite comuni europee; subito sotto il nome tutto in maiuscole, KOSTAS KAZANTZAKIS.
Ada non aveva idea di chi fossero i potenziali lettori del tipo di libri che scriveva suo padre, ma non aveva mai osato farne menzione a scuola; non ci teneva proprio a fornire ai compagni l’ennesimo motivo di pensare che lei – e la sua famiglia – erano strani.
Qualunque ora fosse, suo papà aveva l’aria di preferire la compagnia dei vegetali a quella degli esseri umani. Era sempre stato così: però la mamma, finché c’era, riusciva ad attenuarne le eccentricità, forse perché anche lei aveva le sue. Ma da quando era morta, Ada sentiva il padre allontanarsi, o forse era stata lei ad allontanarsi da lui…


Elif Shafakè una delle voci più importanti della narrativa contemporanea, tradotta in 54 lingue. Il suo romanzo I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo (Rizzoli 2019) è stato finalista al Booker Prize e al RSL Ondaatje Prize. Nel catalogo BUR e Rizzoli sono disponibili, tra gli altri, Le quaranta porte(2009), inserito da BBC tra i cento romanzi che hanno plasmato il nostro mondo, La casa dei quattro venti (2012), La città ai confini del cielo (2014), Tre figlie di Eva(2016) e Non abbiate paura (2020).
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso