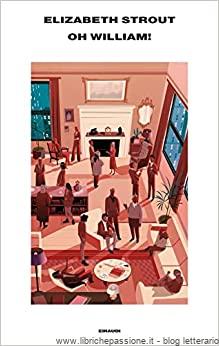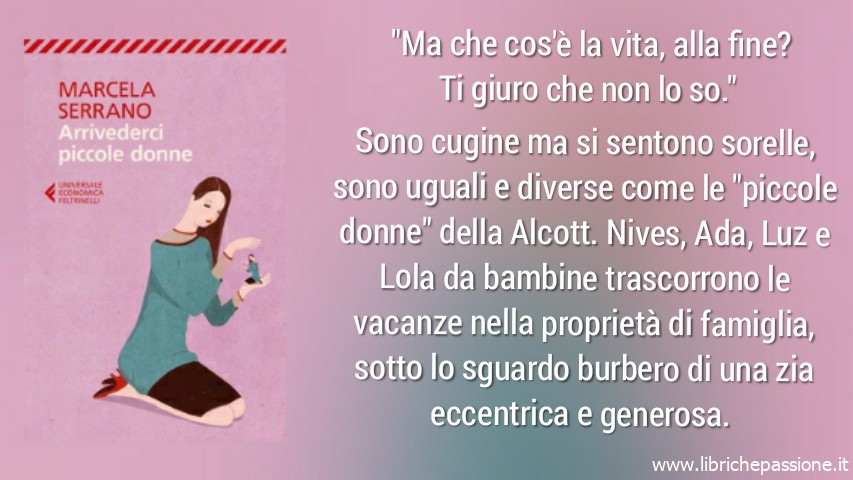Provò un desiderio improvviso, senza nome. Un improvviso e insensato bisogno di futuro, di tempo da spendere, di minuti. Stefano Sartor ha perso la memoria quando aveva diciannove anni, vittima di un incidente che ha distrutto la sua famiglia. Ha ricostruito la sua esistenza, grazie all’aiuto e alla dedizione del nonno. Ma la sua è una vita mutilata, senza infanzia, senza giovinezza. Trent’anni dopo Stefano vive a Parigi, insegna filosofia alla Sorbona, il suo ultimo saggio è diventato un bestseller internazionale, racconta la sua drammatica esperienza, la perdita, il mistero della memoria recisa. Nina ha sedici anni, si muove in un mondo che le appare da sempre estraneo. È una ragazza come tante. Si innamora, in una notte d’estate, davanti a un falò sulla spiaggia, durante una vacanza in Puglia con sua madre. Ma c’è qualcosa, nascosto nel buio. Stefano e Nina sono due anime rotte, erranti, vivono in tempi e luoghi diversi, ma un po’ si somigliano. Esiste un segreto, nelle loro vite, qualcosa che forse li farà incontrare, almeno per un istante. Questa storia è uno squarcio sugli anni luminosi della giovinezza, è un tuffo dove non si tocca, nel flusso dei misteri insondabili che compongono le esistenze. Come essere immersi in un’acqua immobile, e in movimento, che non è mai la stessa. Francesco Carofiglio non fa sconti e non cerca un conforto in queste pagine drammatiche, delicate, potenti. Eppure, incrociando i destini di queste vite spezzate, segna una direzione, per la salvezza, oppure la sogna. E salva magicamente un po’ anche noi.

Sono questi, dunque, i fiori che crescono
tra le erbacce dei campi,
morsi, quasi sfigurati, dal vento.
VIRGINIA WOOLF
Era di pomeriggio, le nuvole si affollavano all’orizzonte.
Gli sembrò di sentire un rumore metallico, di catene, correre nei muri. Tolse le cuffie.
Scostò la tenda e guardò fuori, l’auto di sua madre era parcheggiata sul viale, accanto a quella di suo padre, una Mercedes 190 metallizzata.
Posò la chitarra sul letto e uscì dalla camera. I suoi, in cucina, stavano scaricando le buste della spesa, e con loro c’era Emma, la tata.
«Ciao ma’.»
«Tesoro…»
«Non vi ho sentiti arrivare.»
«Stavi suonando. Mi aiuti a prendere le cassette di acqua minerale? Tra poco si mette a piovere.»
«Okay.»
Si girò per andare in garage e sentì di nuovo quel rumore. Arrivava da qualche parte, dietro di lui, dentro i muri.
Poi ci fu un silenzio, come una sospensione dei battiti.
Come quando il cuore si ferma.
E il mondo esplose.
L’onda d’urto lo scaraventò contro la porta d’ingresso.
La villa sulla Cassia si disintegrò.
Quella casa a due piani immersa nel verde sparì tra le fiamme, per sempre.
Come i suoi diciannove anni.
Il manifesto sulla parete era la riproduzione di un’opera di Rothko. Due rettangoli blu, uno sull’altro, su uno sfondo ancora più scuro. Quasi nero.
Gli venne in mente l’ultima volta che era stato a Londra, alla Tate Gallery. Era rimasto seduto a lungo, senza riuscire a staccarsi dai colori, dalla moltitudine silenziosa dei presagi. Ogni opera era impregnata di un dolore intenso, definitivo, che pulsava nella geometria elementare dei pigmenti. Rosso, ocra, blu. Quelle campiture di colore parevano le porte di un altro mondo, gli accessi al vuoto misterioso dell’anima.
Si voltò e guardò fuori.
Dietro la parete vetrata le persone camminavano, e sparivano dietro gli angoli. Il mondo pareva ammutolito.
Andò a sedersi su una delle poltrone. Sul tavolino, c’era un pacchetto di sigarette accartocciato. Il segno del rossetto incorniciava il bordo del bicchiere di plastica, gli parve quasi osceno, visto da lì.
Il vento fuori muoveva i riflessi sulle foglie, vibrando appena, e la luce disegnava forme irregolari sulle facciate. In lontananza, su un enorme pannello pubblicitario, un viso di donna, in un pallore esangue, sorrideva.
Accartocciò anche il bicchiere e gettò tutto nel cestino.
Poi bevve un sorso d’acqua, prese una fragola e la mise in bocca. Chiuse gli occhi, come gli aveva insegnato suo nonno, così avrebbe sentito meglio il sapore.
E li riaprì. Le ragazze che si affaccendavano nell’appartamento del palazzo di fronte all’albergo non c’erano più. Lontano, la donna sul manifesto sorrideva ancora.
Bussarono alla porta. Entrarono due uomini, uno dei due era il giornalista che lo avrebbe intervistato, l’ennesimo, dopo l’uscita del suo libro in Italia. Un po’ sovrappeso, gli andò incontro per stringergli la mano. L’altro, alto e secco, cominciò
ad armeggiare con la strumentazione. Poco dopo si accostò a Stefano per sistemare il radiomicrofono. Lasciò scorrere il cavo sotto la giacca e fissò la clip sul risvolto.
Si accomodarono, la luce del tramonto adesso si diffondeva nella stanza, i tigli sembravano galleggiare. Il giornalista tirò fuori dal taschino un pettine di plastica e sistemò i capelli, poi controllò il taccuino e si schiarì la voce. Stefano accavallò le gambe e puntò i gomiti sui braccioli. Fece rigirare l’anello d’argento che portava al pollice della mano sinistra. Il cameraman avviò anche la seconda telecamera. Il giornalista si aggiustò il cravattino e, dopo un cenno d’intesa, cominciarono.
«Buonasera ai nostri telespettatori, e benvenuto al professor Stefano Sartor, che ringraziamo per essere qui con noi.»
In quel momento avvertì un piccolo salto nel petto, un’aritmia minuta, un’assenza. Ancora una volta quel senso strabico del non esserci, dell’essere altrove. Come se un altro lui si muovesse nel mondo, mentre lui era lì, seduto, in una camera d’albergo. Tra qualche minuto non avrebbe ricordato più nulla, di quell’intervista.
«…questo libro è a metà strada tra un saggio e un’autobiografia, è una riflessione filosofica, intensa, a volte dolorosa, sul modo in cui la nostra mente costruisce e decostruisce le emozioni…»
«…»
«…e attraverso la memoria dà una forma al passato che, magari, è soltanto immaginaria. È corretto?»
«…credo di sì.»
«Ma chi legge ha anche la sensazione di partecipare a una esperienza di guarigione, assiste alla rinascita. Il ritorno alla vita. È questo il messaggio che consegna al lettore? Tutti possono rinascere dalle macerie della propria esistenza?»
Stefano fece ruotare ancora l’anello sul pollice, distogliendo lo sguardo, per qualche istante.
«Non lo so… sono sincero… non credo di avere messaggi da consegnare.»
«È anche la storia della sua vita, però.»
«È la storia immaginata della vita di un altro, che non esiste più.»
Il giornalista lo fissò per pochi istanti, sorrideva, come se avesse davvero capito. Oppure no, non aveva capito nulla. «Grazie professore.»
Restarono fermi, in silenzio, fino a quando il secco fece un cenno. Poi si alzarono.
Il tecnico sfilò i microfoni dalle giacche e cominciò a smontare l’attrezzatura, ripetendo al contrario gli stessi movimenti di prima. Una musica, da qualche parte, tracciò una curva invisibile e svanì. Poco dopo i due uscirono dalla stanza. Tutto finì molto rapidamente. Non li avrebbe mai più incontrati, probabilmente.
In fondo la sua vita era questo, incontri che svanivano nel nulla, persone che attraversavano il campo visivo per poi sparire. Era stato quasi sempre così, da quando ricordava.
Non sapeva se mai ne avesse avuto un altro, ma il suo senso del mondo era come imbavagliato, trasmetteva segnali muti, nell’apocalisse secca delle giornate uguali.
Qualche istante più tardi bussarono di nuovo alla porta.
Ed entrò una donna. Alta, snella. Si fece avanti. Gli occhi celesti si strinsero in una fessura, non appena intercettarono la luce obliqua del sole.
«Buonasera, sono Anna Castiglioni.»
«Buonasera…»
Restarono uno di fronte all’altra, immobili, per qualche istante. Lei sorrise, le labbra increspate da piccole screpolature.
«Il suo ufficio stampa mi ha detto che avrei potuto farle degli scatti…»
«Sì… giusto. Avevo dimenticato.»
«Mi hanno detto anche che non abbiamo molto tempo.»
Tolse il soprabito e lo appese su una gruccia, all’ingresso. Si muoveva con eleganza quasi maschile. Portava una T-shirt bianca e un paio di jeans, il viso appena segnato da rughe sottili. I muscoli delle braccia erano solcati da un rivolo di vene azzurrine, attraversavano i bicipiti, sfociando nell’avambraccio, fino ai polsi.
Tirò fuori dalla borsa la macchina fotografica. Mentre cominciava a montare l’obiettivo si accorse della lunga cicatrice sul volto di lui, e della zona di cuoio capelluto consumato accanto all’orecchio destro. Poi distolse lo sguardo.
«Devo confessarle che non ho ancora letto il suo libro.»
«Magari non si è persa granché.»
La donna lo guardò e sorrise, un po’ stupita.
Terminò di montare l’obiettivo, i gesti rapidi, essenziali. Stefano rimase in silenzio.
Gli piacevano i movimenti delle mani, come se ci fosse sempre un segreto, dentro i riti della preparazione. Poteva restare dei minuti a fissare un artigiano che intagliava il legno, in una bottega del Marais. Come un voyeur, dietro le vetrine.
«Le piace Romain Gary.»
«Prego?»
La donna si scostò un ciuffo dagli occhi.
«No, mi scusi… avevo notato quel libro accanto alla poltrona. La vie devant soi.»
«Ah… certo. Mi piace molto…»
Stefano esitò, poi riprese a parlare.
«Quel romanzo era stato pubblicato con uno pseudonimo. Lo sapeva?»
«No…»
«Émile Ajar. Il romanziere più promettente degli anni Settanta. Vinse il Goncourt con quel romanzo, e con quel nome inventato.»
«Perché ha usato uno pseudonimo?»
«Anche Romain Gary non era il suo vero nome. In realtà si chiamava Roman Kacew, era un ebreo lituano trapiantato a Parigi. Non deve essere stata una vita facile, la sua. Forse cambiare nome, identità, serviva a nascondersi da qualcos’altro.»
«Credo che succeda a tutti, almeno una volta. Voler essere qualcun altro.»
«Credo di sì. Si uccise… un anno dopo la morte di sua moglie.»
«Jean Seberg?»
«Sì…»
«Come era bella…»
«Prima di spararsi un colpo in testa indossò una vestaglia rossa, non voleva che il sangue si notasse troppo.»
La donna ebbe un piccolo fremito. Sfiorò ancora il viso con la mano, portava un anello al mignolo, nessun altro gioiello.
«Scusi, non volevo turbarla…»
«No, non si preoccupi…»
La guardò ancora, mentre puliva con un panno la lente dell’obiettivo. Aveva le unghie corte, senza smalto.
«Ha detto… il suo nome è Anna Castiglioni, giusto?»
«Sì…»
«Dove posso aver visto i suoi lavori?»
Lei lo fissò, sembrava quasi sollevata da quella domanda.
«Londra, Berlino… soprattutto New York, ma in Italia mai.»
«Non vive in Italia, quindi.»
«No, ma ho una casetta in Toscana, a Monteriggioni. Mi piacerebbe venirci, prima o poi.»
«Ho capito…»
«La prossima mostra si inaugura alla fine di maggio, a Parigi.»
«Dove?»
«Alla Maison Européenne de la Photographie, non so se la conosce.»
«Piuttosto bene.»
«Davvero?»
«Abito da quelle parti. A meno di dieci minuti da lì.»
«Ah…»
La donna esitò qualche istante, poi riprese a occuparsi del set. Fissò un faro a led su un piedistallo, lo accese e lo puntò sulla parete. Regolò l’intensità luminosa, quasi al minimo.
«Bene… io sono pronta.»
Chiese a Stefano di accostarsi alla parete, accanto alla finestra. E di guardare fuori. Controllò la luce, l’esposizione, la messa a fuoco. Il viso si moltiplicava nel riflesso dei vetri. Lo guardò e lui rispose allo sguardo. Non dissero nulla.
E cominciò a scattare. Nella piccola suite suonava soltanto il sibilo elettronico della reflex.
«Guardi più in basso, per cortesia, più a destra.»
Stefano guardò in basso.
«Adesso verso di me.»
Gli sembrò che ci fosse qualcosa di impudico, in quello sguardo. Un’intimità simulata, che sarebbe svanita, di lì a poco. La donna indugiò, mentre stringeva il fuoco sul viso, proprio sopra la cicatrice che tagliava la guancia in due parti. Poi riprese a scattare.
«Adesso… faccia come se io fossi… trasparente.»
«Temo di non aver capito.»
«Vede qualcosa dietro di me?»
«…un manifesto, il muro…»
«Ecco, provi ad annullare la mia presenza e guardi dritto quel muro. Si concentri sul manifesto. Faccia finta che io non esista.»
Si concentrò. I due rettangoli blu, sullo sfondo più scuro. Lei mise a fuoco, stringendo ancora l’inquadratura. Lo sguardo dell’uomo adesso era altrove, così come sperava, lontano.
«Bravo…»
Fece un’altra decina di scatti, poi si fermò e diede un’occhiata alle immagini sul display. Seguì un silenzio prolungato, in cui nessuno disse nulla.
«Okay, direi che abbiamo finito.»
«Finito?»
«Sì. Non voglio approfittare della sua disponibilità. Magari la prossima volta avremo più tempo.»
«…»
«Mi faccio dare un indirizzo dal suo ufficio stampa e le invio qualche foto, se ha voglia di vederle.»
«Grazie.»
«E magari le faccio avere un invito per il vernissage, se fosse a Parigi, in quei giorni. Questo è il mio biglietto. C’è anche l’indirizzo del sito, ci trova un po’ dei miei lavori.»
Sistemò la macchina nella custodia, e prese il soprabito. Poi si strinsero la mano.
Andò via, agilmente, così come era apparsa.


Francesco Carofiglio, scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre a L’estate del cane nero, Ritorno nella valle degli angeli e Radiopirata (tutti usciti per Marsilio), ha pubblicato per BUR il romanzo With or without you e per Rizzoli, in coppia con il fratello Gianrico, nel 2007 la graphic novel Cacciatori nelle tenebre e nel 2014 La casa nel bosco. Per Piemme, ha scritto Wok e Voglio vivere una volta sola, Una specie di felicità, Il Maestro, la saga di Jonas e il Mondo Nero (per i tipi del Battello a Vapore), L’estate dell’incanto (Premio Selezione Bancarella, in corso di pubblicazione in diversi Paesi europei) e la raccolta Poesie del tempo stretto, che ha anche interamente illustrato.
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso