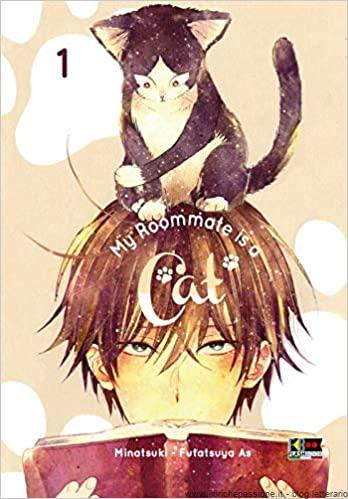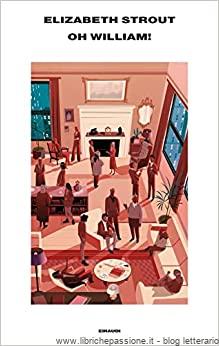

«Vorrei dire alcune cose sul mio primo marito, William», esordisce una Lucy Barton oggi sessantaquattrenne aprendo questo capitolo della sua storia, e nell’immediatezza del suo proposito s’intuisce il lavorio di riflessioni a lungo maturate. Sono passati decenni da quando Lucy, convalescente in un letto di ospedale, aspettava la visita delle sue bambine per mano al loro papà; decenni da che, con pochi vestiti in un sacco dell’immondizia, lasciava quel marito tante volte infedele e si trasferiva in una nuova identità. Oggi Lucy è un’autrice di successo, benché ancora si senta invisibile, con le figlie ormai adulte ha un rapporto vitale e premuroso, e da un anno piange la scomparsa del suo adorato secondo marito, David, un violoncellista della New York Philharmonic Orchestra, nato povero come lei. William di anni ne ha settantuno, è sposato con la sua terza moglie, Estelle, di ventidue anni più giovane, e la sua carriera di scienziato sembra agli sgoccioli. Tanta vita si è accumulata su quella che lui e Lucy avevano condiviso. Perché dunque William? Perché tornare a quell’uomo alto e soffuso d’autorità, con una faccia «sigillata in una simpatia impenetrabile» e un cognome tedesco ereditato dal padre prigioniero di guerra nel Maine? Corrente carsica che scorre silente per emergere in imprevedibili fiotti di senso e sentimento, questo matrimonio è ricostruito per ricordi apparentemente casuali – una vacanza di imbarazzi alle Cayman, una festa tra amici non riuscita, un viaggio di risate in macchina, un amaro caffè mattutino – ma capaci di illuminare i sentieri sicuri e i passi falsi di una vita coniugale, dove le piccole miserie e gli asti biliosi convivono con i segni di un’imperitura, ineludibile intimità. Così è William il primo che Lucy chiama quando viene a sapere della malattia di David; ed è a Lucy che William chiede di accompagnarlo in un viaggio nel Maine alla spaventosa scoperta delle proprie origini e di verità mai conosciute. «Oh William», torna a ripetere Lucy, e in quell’interiezione c’è un misto eloquente di esasperazione per le sue mancanze e tenerezza per le sue illusioni. Un sentimento caldo che si allarga in un abbraccio universale: «Ma quando penso Oh William!, non voglio dire anche Oh Lucy!? Non voglio dire Oh Tutti Quanti, Oh Ciascun Individuo di questo vasto mondo, visto che non ne conosciamo nessuno, a partire da noi stessi?»

Dedico questo libro a mio marito,
Jim Tierney
E a te – se può esserti utile
Vorrei dire alcune cose sul mio primo marito, William.
William ha avuto molte tristezze – è successo a tanti di noi, ma vorrei ricordarle lo stesso, lo sento quasi come un dovere; oggi William ha settantun anni.
Il mio secondo marito, David, è morto l’anno scorso, e il dolore per lui mi ha fatto provare dolore anche per William. Il dolore è cosí – oh, fa sentire talmente soli; è questo che lo rende terribile, secondo me. È come scivolare giú per la facciata di un lunghissimo palazzo di vetro mentre nessuno ti vede.
Ma è di William che voglio parlare adesso.
Si chiama William Gerhardt e quando ci sposammo presi il suo cognome anche se non era di moda in quel periodo. La mia compagna di stanza al college mi diceva: «Ma come, Lucy, prendi il suo cognome? Ti credevo una femminista». E io le rispondevo che non mi importava di essere o no una femminista; che non avevo piú voglia di essere me stessa. In quel periodo mi sembrava di non poterne piú di essere me, era una vita che non volevo essere me – la pensavo cosí allora –, perciò presi il suo cognome e diventai Lucy Gerhardt per undici anni, ma non mi ci sono mai sentita a posto, e quasi subito dopo la morte della madre di William andai alla motorizzazione a farmi cambiare il nome sulla patente, anche se si rivelò piú complicato del previsto; dovetti tornare portando dei documenti asseverati; ma lo feci comunque.
Ero di nuovo Lucy Barton.
Siamo stati sposati circa vent’anni prima che lo lasciassi e abbiamo due figlie e da un pezzo ormai siamo in buoni rapporti – non so bene come. Si sentono tante storie su divorzi tremendi, ma il nostro non è stato cosí, a parte il momento della separazione. Certe volte pensavo che sarei morta per quanto stavo male durante la separazione, e per il male fatto alle mie figlie, ma non sono morta, e sono qui, ed è qui anche William.
Dato che sono una scrittrice, devo raccontare queste cose come se fossero un romanzo, ma è tutto vero – per quanto mi è possibile. E voglio dire che… oh, è difficile sapere cosa dire! Ma quando riferisco qualcosa a proposito di William è perché o me l’ha raccontato lui o l’ho visto coi miei occhi.
Dunque, la storia comincia quando William aveva sessantanove anni, vale a dire meno di due anni fa.
Un’immagine:
Di recente l’assistente di laboratorio di William si era messa a chiamarlo «Einstein», e sembrava che a William piacesse tantissimo. A me non pare per niente che William somigli ad Einstein, ma capisco che cosa intendeva la ragazza. William ha baffi molto folti tra il bianco e il grigio, ma sono baffi azzimati, e i capelli sono folti e bianchi. Li tiene corti ma è vero che gli stanno un po’ dritti sulla testa. È alto di statura e si veste molto bene. Però non ce l’ha quell’aria vagamente folle che secondo me aveva Einstein. La faccia di William risulta spesso sigillata in una simpatia impenetrabile tranne quando butta indietro la testa e ride di cuore, ma capita molto di rado; è un mucchio di tempo che non glielo vedo fare. Ha gli occhi marroni, e sono rimasti grandi; non a tutti invecchiando gli occhi restano grandi, ma a William sí.
Allora…
Tutte le mattine William si sveglia nel suo appartamento spazioso su Riverside Drive. Riesci a vederlo? Scosta il piumone soffice insacchettato nella fodera di cotone blu, mentre la moglie continua a dormire nel letto matrimoniale, e va in bagno. È un po’ anchilosato la mattina, ma ha degli esercizi da fare e li fa, in soggiorno, sdraiandosi sul grande tappeto rosso e nero sotto il lampadario antico, e pedalando in aria come se fosse su una bicicletta, prima di allungare le gambe di qua e di là. Dopodiché si trasferisce sulla grossa poltrona color amaranto accanto alla finestra che affaccia sull’Hudson, e si legge le notizie sul portatile. A un certo punto Estelle emerge dalla camera da letto e gli fa un cenno assonnato con la mano, poi va a svegliare la figlia Bridget che ha dieci anni e dopo che William si è fatto la doccia, si siedono tutti e tre al tavolo rotondo in cucina, per colazione; a William piace questa routine, e sua figlia chiacchiera tanto; è come stare a sentire un uccellino, ha detto una volta, e anche sua madre chiacchiera tanto.
Dopo che è uscito di casa attraversa il parco e poi prende la metro downtown, scende alla Quattordicesima e da lí se la fa a piedi fino alla New York University; la passeggiata quotidiana lo fa stare bene anche se ha notato che non è veloce come i giovani che lo superano sgomitando con il sacchetto del pranzo, o il passeggino doppio, o con i leggings in elastan, auricolari e tappetino da yoga legato con un elastico sulle spalle. Si rincuora constatando che sorpassa parecchia gente anche lui – il vecchio con il deambulatore, o una donna con bastone, e perfino qualcuno della sua età che semplicemente si muove piú lento – e questo lo fa sentire sano ed energico e pressoché invulnerabile nel traffico incessante del mondo. Si vanta di superare i diecimila passi al giorno.
Insomma William si sente (quasi) invulnerabile, è questo che dico.
Certi giorni durante la camminata del mattino gli capita di dirsi, Oh mio Dio, potrei essere quel tizio, quello laggiú in sedia a rotelle seduto al sole in Central Park con la badante sulla panchina accanto a messaggiare al telefono mentre a lui crolla la testa sul petto, o magari quell’altro con il braccio storto da ictus, e il passo sbilenco… Poi però William pensa: E invece non lo sono.
E non lo è. Lui, come ho detto, è un uomo alto di statura che gli anni non hanno appesantito troppo (se si esclude un po’ di pancetta che con la giacca quasi non si vede), un uomo che ha conservato i suoi capelli, ora bianchi ma folti; William, in una parola. E che ha una moglie, la terza, di ventidue anni piú giovane. Il che non è poco.
Di notte, però, ha spesso attacchi di terrore.
Questo William me l’ha raccontato una mattina – meno di due anni fa –, ci eravamo incontrati per un caffè nell’Upper East Side. L’appuntamento era in un posto all’angolo tra la Novantunesima e Lexington Avenue; William ha un mucchio di soldi e un mucchio ne dà via e una delle istituzioni a cui li devolve è un ospedale pediatrico vicino a casa mia, e in passato ogni volta che aveva una riunione al mattino presto mi chiamava e ci prendevamo un caffè veloce all’angolo. Quella volta – era marzo, pochi mesi prima che William facesse settant’anni – ci siamo seduti a un tavolo d’angolo del locale; sulla vetrina erano dipinti dei trifogli di San Patrizio e io ho pensato esattamente questo: che William sembrava piú stanco del solito. Mi sono detta spesso che con gli anni William diventa piú bello. La chioma bianca gli dà un’aria distinta; la porta un tantino piú lunga di una volta e gli si gonfia sulla testa a contrastare i baffoni cascanti, e cosí gli si notano di piú gli zigomi, e gli occhi ancora scuri; e c’è una cosa strana, perché di solito lui ti guarda in modo diretto – cordiale – ma ogni tanto capita che il suo sguardo diventi per un attimo penetrante. E ti chiedi dove vorrà arrivare con quello sguardo penetrante. Non l’ho mai capito.
Quel giorno nel caffè, quando gli ho chiesto: «Allora, William, dimmi un po’, come stai?», mi aspettavo che rispondesse come fa sempre, cioè che dicesse in tono ironico: «Beh, sto benone, Lucy, ti ringrazio», ma quella mattina ha detto semplicemente: – Non c’è male –. Indossava un cappotto nero che si è tolto e ha ripiegato sulla sedia accanto prima di sedersi. L’abito era di sartoria, da quando aveva conosciuto Estelle aveva preso l’abitudine di farsi fare gli abiti su misura, perciò gli calzava alla perfezione sulle spalle; era grigio antracite su camicia celeste e cravatta rossa; aveva un aspetto solenne. Ha incrociato le braccia sul petto, come fa spesso. – Ti vedo bene, – ho detto, e lui ha detto: – Grazie –. (Credo che William non mi abbia mai detto che mi trova bella, o carina, o nemmeno in forma, in tutte le volte che ci siamo incontrati negli anni, e la verità è che ho sempre sperato che prima o poi lo facesse). Ha ordinato il caffè per tutti e due e si guardava attorno nervoso tiracchiandosi i baffi. Per un po’ ha parlato delle nostre figlie – aveva paura che Becka, la piccola, ce l’avesse con lui; gli era sembrata scostante al telefono un giorno che l’aveva chiamata per fare due chiacchiere, e io gli ho detto che doveva solo lasciarla un po’ tranquilla mentre si ambientava nella sua vita da sposata – abbiamo parlato cosí per un poco – e poi William mi ha guardata e ha detto: – Passerotta, voglio dirti una cosa –. Si è sporto in avanti per un attimo. – Da un po’ mi prendono dei tremendi attacchi di terrore nel cuore della notte.
Quando usa il mio vezzeggiativo di una volta significa che è presente in una misura in cui non gli capita spesso di essere, perciò mi emoziona sempre quando mi chiama cosí.
Gli ho detto: – Intendi degli incubi?
Ha piegato la testa come se ci volesse pensare su e ha detto: – No, sono sveglio. È nel buio che mi vengono –. E ha aggiunto: – Non mi era mai capitato prima. Ma sono terrificanti, Lucy. Mi spaventano a morte.
William si è sporto in avanti di nuovo e ha messo giú il caffè.
L’ho guardato e gli ho chiesto: – Per caso stai prendendo qualche farmaco diverso dal solito?
Ha aggrottato un po’ la fronte e ha detto di no.
Allora gli ho detto: – Beh, prova con un sonnifero.
E lui ha detto: – Non ho mai preso un sonnifero in vita mia, – il che non mi ha affatto stupita. Sua moglie invece li prendeva, ha detto; Estelle prendeva un mucchio di roba, e lui aveva rinunciato a capire cos’era la manciata di pasticche che trangugiava ogni sera. «Adesso prendo le mie medicine», diceva tutta allegra, e nel giro di una mezz’ora dormiva. Non gli dava fastidio, ha detto. Ma non faceva per lui, impasticcarsi. Purtroppo però, quattro ore dopo si ritrovava sveglio e spesso cominciavano gli attacchi di terrore.
– Raccontami, – ho detto.
Ed è partito, guardandomi in faccia solo ogni tanto, come se fosse ancora alle prese con i suoi attacchi.
Terrore numero uno: Non definibile, ma aveva a che fare con sua madre. Sua madre – Catherine, si chiamava – era morta moltissimi anni prima, ma durante gli attacchi notturni la sentiva presente, ma non come una presenza benevola e questo era strano perché l’aveva adorata. William era figlio unico e aveva sempre compreso l’amore (tacitamente) feroce che la madre nutriva per lui.
Per superare l’attacco mentre era sveglio nel letto accanto alla moglie addormentata – cosí mi ha raccontato quel giorno, e la cosa mi ha un po’ sconvolta – doveva pensare a me. Pensava che io ero viva da qualche parte, in quel preciso momento – che ero viva – e questo gli dava conforto. Perché sapeva che se avesse dovuto, ha detto sistemando il cucchiaino sul piatto della tazza da caffè – pur non avendo nessuna intenzione di farlo nel cuore della notte –, sapeva che se proprio avesse dovuto, io gli avrei risposto al telefono. Mi ha detto che era la mia presenza a procurargli il massimo del sollievo e a permettergli di rimettersi a dormire.
– Certo che puoi chiamarmi sempre, – ho detto io.
E William ha mandato gli occhi al cielo. – Lo so. Che cosa ho detto finora? – ha detto.
Altro terrore: Questo aveva a che fare con la Germania e con suo padre che era morto quando William aveva quattordici anni. Il padre era arrivato dalla Germania come prigioniero di guerra – la seconda guerra mondiale – ed era stato mandato a lavorare nei campi di patate del Maine, dove aveva conosciuto la madre di William; era la moglie del proprietario dei campi. Questo poteva essere per William il terrore piú brutto, perché suo padre aveva combattuto dalla parte dei nazisti, e questo ossessionava William la notte e gli procurava gli attacchi – rivedeva con chiarezza i campi di concentramento, li avevamo visitati insieme durante un viaggio in Germania, e rivedeva gli stanzoni in cui la gente veniva gassata – e allora doveva alzarsi e camminare in soggiorno e accendere la luce accanto al divano e guardare il fiume dalla finestra, e aveva un bel pensare a me o a quel che voleva, ma con questi attacchi non funzionava. Non gli capitavano con la stessa frequenza di quelli su sua madre, ma quando succedeva erano bruttissimi.
Ancora uno: Questo aveva a che fare con la morte. Con una sensazione di allontanamento, col sentirsi come se stesse quasi per lasciare il mondo e non credesse in nessun dopo, perciò anche questo certe notti lo riempiva di un tipo particolare di terrore. Ma di solito riusciva a rimanere a letto, anche se qualche volta si alzava e andava in soggiorno a sedersi sulla poltrona color amaranto accanto alla finestra e si metteva a leggere – gli piacevano le biografie – fino a quando non sentiva di poter tornare a letto.
– E questi da quanto ce li hai? – gli ho chiesto. Il locale in cui ci incontravamo era aperto da anni e a quell’ora del giorno era affollato; dopo averci portato un caffè ci avevano buttato quattro tovagliolini bianchi sul tavolo.
William ha guardato fuori dalla vetrina e pareva stesse osservando una vecchia che camminava con un deambulatore dotato di sedile; si muoveva piano, china in avanti, con il vento che le faceva svolazzare indietro il cappotto. – Qualche mese, – ha detto.
– Nel senso che si sono presentati dal nulla?
A quel punto mi ha guardata; le sopracciglia gli erano diventate ispide sugli occhi scuri, e ha detto: – Credo di sí –. E un attimo dopo, abbandonandosi allo schienale ha detto: – Deve essere che sto invecchiando.
– Può darsi, – ho detto. Ma non ero sicura che fosse per quello. William è sempre stato un mistero per me – e per le nostre figlie. Gli ho proposto senza convinzione: – Pensi di parlarne con qualcuno?
– Dio, no, – ha detto, e quella parte di lui non era un mistero per me. Sapevo che avrebbe reagito cosí. – Però è terribile, – ha aggiunto.
– Oh Grillo, – ho detto usando anch’io il vezzeggiativo dei vecchi tempi. – Mi dispiace tanto.
– Vorrei non avere mai fatto quel viaggio in Germania, – ha detto. Ha preso uno dei tovagliolini e ci si è asciugato il naso. Poi si è passato la mano sui baffi – con quel fare quasi meditabondo che ha spesso. – E soprattutto che non fossimo mai andati a Dachau. Continuo a rivedere quei… quei crematori –. Ha aggiunto, lanciandomi un’occhiata: – Hai fatto bene a non entrare.
Mi ha stupito che William ricordasse che non ero entrata nella camera a gas e nemmeno nei crematori, l’estate in cui eravamo andati in Germania. Non ci ero entrata perché già allora mi conoscevo abbastanza da sapere che non dovevo farlo; perciò non l’avevo fatto. La madre di William era morta l’anno prima, le bambine avevano nove e dieci anni ed erano insieme al campo estivo per due settimane, quindi avevamo preso l’aereo per la Germania – l’unica richiesta da parte mia era stata che i voli fossero due, avevo paura che potessimo morire entrambi in un incidente lasciando le bambine orfane, cosa che in seguito mi è sembrata un’idiozia, visto che avremmo potuto benissimo morire insieme in Autobahn con le macchine che ci sfrecciavano intorno – ed eravamo andati a cercare notizie del padre di William che, come ho detto, era morto quando William aveva quattordici anni; se n’era andato in un ospedale del Massachusetts, di peritonite; gli si era perforato l’intestino mentre gli rimuovevano un polipo e lui era morto. Eravamo andati quell’estate perché qualche anno prima William aveva messo le mani su un bel po’ di soldi; a quanto pare suo nonno si era arricchito in tempo di guerra e, al compimento dei trentacinque anni, William aveva avuto accesso al denaro versato su un fondo fiduciario, il che per William era un problema, perciò avevamo fatto quel viaggio per incontrare il vecchio, anzi vecchissimo, nonno, e due zie di William, che erano state garbate ma fredde, secondo me. Il vecchio, il nonno cioè, aveva due occhietti lustri e non mi era piaciuto per niente. Il viaggio ci aveva rattristati tutt’e due…


Elizabeth Strout è nata nel Maine ma vive a New York. Ha pubblicato i suoi racconti su «The New Yorker» e molte altre riviste. In Italia ha pubblicato, per Fazi editore, tre romanzi, Amy e Isabelle, Resta con me e I ragazzi Burgess, e la raccolta di racconti Olive Kitteridge, con cui ha vinto il Premio Pulitzer (2009), il Premio Bancarella (2010) e il Premio Mondello (2012). Dalla stessa raccolta di racconti è stata tratta una serie tv, prodotta dalla Hbo. Per Einaudi ha pubblicato Mi chiamo Lucy Barton (2016 e 2017), Tutto è possibile (2017 e 2018) e Olive, ancora lei (2020 e 2021)
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso