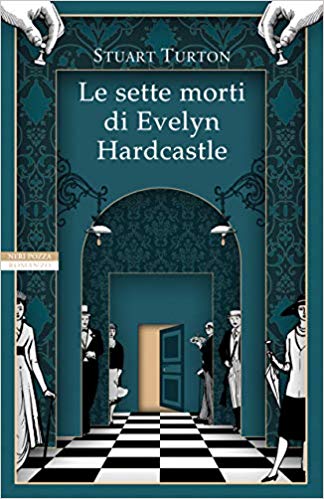Ogni punto di partenza ha bisogno di un ritorno. Per riconciliarsi con il mondo, dopo una storia d’amore finita, Adelaide torna nel paese in cui è nata, un pugno di case in pietra tra le montagne aspre della Val Germanasca: una terra resistente dove si parla una lingua antica e poetica. È lì per rifugiarsi nel respiro lungo della sua infanzia, negli odori familiari di bosco e legna che arde, dipanare le matasse dei giorni e ricucirsi alla sua terra: ‘fare la muta al cuore’, come scrive nelle lettere al figlio. Ad aspettarla – insieme a una bufera di neve – c’è Nanà, ultima custode di casa, novant’anni portati con tenacia. Levì, l’altro anziano che ancora vive lassù, è stato ricoverato in clinica dopo una brutta caduta. Isolate dal mondo per quattordici giorni, nel solo spazio di quel piccolo orizzonte, le due donne si prendono cura l’una dell’altra. Mentre Adelaide si adopera per essere utile a Nanà e riportare a casa Levì, l’anziana si confida senza riserva, permettendole di entrare nelle case vuote da tempo, e consegnandole la chiave di una stanza intima e segreta che trabocca di scatole, libri ricuciti, contenitori e valigie, in cui la donna ha stipato i ricordi di molte vite, tra uomini, fiori, alberi e animali, acqua e tempo. Una biblioteca di esistenze, di linguaggi, gesti e voci, dove ogni personaggio è sentimento, un modo di amare. Fotografie, lettere, oggetti che sanno raccontare e cantare il tempo: di guerra e povertà, amori coltivati in silenzio, regole e speranza, fatica e fantasia. Un testamento corale che illumina le ombre e le rimette in equilibrio. La bellezza intensa che respira oltre la vita e rimane in attesa di parole. Tuffarsi nella memoria significa avere il coraggio di inventare un altro finale e vivere oltre il tempo che ci è stato concesso, per ritrovare il luogo intimo di ognuno. La casa.

A moun filh
1
Mi ha raggiunta la bufera.
L’automobile ha arrancato nel tornante, dove un pino si è abbattuto per metà e ora penzola ad angolo acuto, appesantito dalla neve.
Dal parcheggio si vede appena il profilo delle prime case, il resto del paesaggio è nella cappa.
Due passi ed è tormenta fin sulle labbra.
La cucina di Nanà è illuminata, ma preferisco scendere a scaricare lo zaino prima che faccia buio. Sputa raffiche, questa bocca di brina gelata: attraversano i vestiti come farebbe un dardo e le ho sentite fin sulla pelle della schiena.
Il viottolo è quasi impraticabile. Devo aggrapparmi alle balaustre e agli angoli delle case per non scivolare sul ghiaccio che sta sotto la neve fresca. Mio padre si sarebbe messo a ridere nel vedermi così goffa. C’è un silenzio integrale, nemmeno il gocciolare di una grondaia, che qui son tutte malconce e perdono come rubinetti. Nulla, solo il vapore del fiato che mi precede di mezzo passo.
Sono la prima a scendere in fondo alla borgata da un bel po’ di tempo; nessuna orma, se non qualcuna di uccello sui davanzali. Di fianco alle stalle le pietre hanno scordato il profumo del letame.
Gli scarponi sprofondano. I muri calamitano la bufera, e così fanno i vetri e tutto, impastando i colori in un malinconico grigio.
Il sorbo flette: orecchini di ghiaccio appesi ai rami hanno incastonato le ultime bacche, come è il cielo, che caglia nella tinozza dell’inverno. Il piede del paese, tumefatto, è stretto negli strati di garza che la neve ha disposto, e la più disgraziata sembra la mia casa che, essendo un’unghia puntata nel vuoto della valle, non può nascondere le sue piaghe.
Dalle gambe, un sentimento di ghiaccio si è aggrappato alla colonna vertebrale e ha tramortito le mani salde alla pala, stremate dalla neve che è marmo fino alla porta di casa.
Sputo sulla chiave e quella gira nel nottolino. Mi travolge il puzzo di cipolla e stantio. Scendo in legnaia, carico due gerle e le porto all’asciutto. Nel giro di pochi minuti la stufa è accesa e sfiata, dalla trachea del camino, sbuffi sincopati e densi.
Sul piano del lavello un ragno e una mosca hanno fatto baco, la polvere li ha abbracciati stretti. Ho rassettato alla bell’e meglio disancorando le ragnatele, svuotato la dispensa dalle cipolle avvizzite e lavato i mobili ossidati di muffa e silenzio. Nella stanza da letto ho fatto capolino per raccattare una catalogna e un cuscino, gli scuri hanno riparato gli infissi, ma il gelo ha bussato sui vetri disegnando volute d’acanto.
Il bagno è freddo. Ho spazzato il pavimento, c’erano ovunque scheletri di foglie che il vento ha spinto oltre la soglia. Dalla volta penzolano nodi di calce e l’acqua dello sciacquone è un rivolo rotto.
Non c’è nulla qui che mi aspettasse, proprio nulla.
La legna umida non vuole addomesticarsi al fuoco e gli resiste da ogni carie ferrosa della piccola stufa, perciò, in un attimo, l’aria diventa irrespirabile.
Spalancata la porta per dileguare il fumo, non ho potuto fare a meno di rivederla, stuccata tra le piastrelle e senza dimensione: la morte di mio padre, in un giorno di neve a piombo che arrivava quasi ai tetti, e fuliggine sparsa sul pavimento come un destino.
La morte è un battito che manca. La vita, un battito inatteso.
Quando ha smesso di nevicare è salito il cielo. Le nuvole scansate d’improvviso fanno spazio a una costola di luna che rischiara la notte, e non vi è voce se non la nenia del torrente che mi ricorda dove sono. Seduta sulla panca guardo il collo delle montagne farsi netto oltre il pulviscolo e sento il peso di mio padre, alla destra, bilanciare l’asse di legno.
«Una valle valdese che porta il nome di un santo, non è singolare? San Martino… ah! Capisci, fillho, quanto la Storia è piena di contraddizioni? E se ti dicessi che la chiamavano ‘Valle Oscura’, ci crederesti vedendo i pianori nelle giornate limpide? Forse perché, salendo da basso, non ti aspetti che il cielo si apra e le montagne servano agli occhi tanta grazia, ma la vita è così: muove alla luce solo se hai coraggio di camminarci da basso. Non fanno paura nemmeno le contraddizioni, se le attraversi con la consapevolezza che sono lì apposta per cadenzare il passo, darti equilibrio nella storia. Nevicherà ancora e sarà sempre un bene».
Sono state le ultime parole che mi ha detto, cinque anni fa, nel tempo di una sigaretta. Tornano ora in diamanti d’aria e brillano sulla solitudine di ogni cosa che distinguo sotto la coltre.
Rientrata in cucina mi distrae il fischio del bollitore, l’acqua ha già debordato marcando di calcare i cerchi della stufa.
Ho messo a mollo del serpillo per una tisana, che si rivela piuttosto disgustosa: rimane ben poco del talento odoroso che muove le api verso le corolle e ora, dopo lungo tempo nel metallo della scatola, si è scordato d’esser stato fiore.
L’orologio da polso segna le ventitré, quello appeso al muro deve avere le pile arrugginite e si è fermato alle quattro e dieci di chissà quale giorno. Vorrei davvero saperlo.
Mi chiedo se stia facendo la cosa giusta a starmene qui il tempo necessario a disossare i ricordi e restituirli puliti con il resto dello scheletro. Poteva esserci altra meta?
Nella tasca dello zaino c’è l’agenda con le lettere per Edo, mai consegnate. Alcune stan lì da anni. Le ho portate perché possano farmi da traduttore se inciamperò nei vuoti e busseranno i sensi di colpa. Serviranno definizioni accurate del dolore che mi ha costretta a salire in macchina e imboccare la strada verso casa, nonostante l’inclemenza del cielo. È una bufera ancora più violenta, il disamore.
Ho quasi paura di trovarmi impacciata nello stagno della memoria, dove eserciti di girini con le spade sono pronti a trafiggere ciò che finora è rimasto mansueto, tutte quelle cose che ho volutamente nascosto alla vista.
È stata così improvvisa e urgente la mia decisione che non ho avuto il minimo tentennamento, almeno fino a questo momento, con l’avanzo della tisana in un dito d’acqua, e un orologio da parete a civettare un’ora improbabile per sbattermi in faccia che non ero qui quando quella lancetta si è fermata.
Immagino che, come me, tutti gli oggetti nella stanza provino la stessa sensazione di smarrimento. Non entrerà nessuno a vedere quanto sia incurvata la schiena su questi pensieri, quanto siano intorpidite le gambe sul pavimento di ghiaccio o quanto possa sembrare almeno mezza vita più vecchia, costretta a tornare indietro di colpo per poi tendere, con altrettanta violenza, l’elastico che mi lavora la pelle e la memoria.
Si vede tutto, è tutto terribilmente nudo: le ragnatele, la calce che sfarina, il fantasma di mio padre, il poco che qui si chiama essenziale, il conto di tante vite sulle spine dei giorni e la mia calligrafia appuntita come pineta.


Valeria Tron è nata in Val Germanasca, dove vive per buona parte dell’anno. Cantautrice, è stata finalista al Premio Tenco. È illustratrice, mediatrice culturale e artigiana del legno. Questo è il suo primo romanzo.
Per acquistare il libro cliccate cliccate in basso