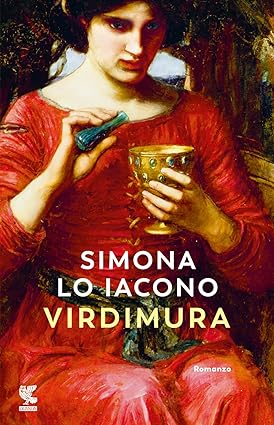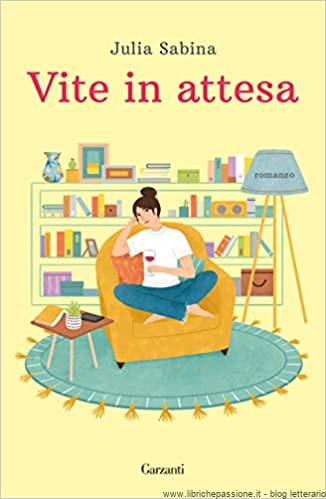Londra, 1840. Evangeline è un’ingenua ragazza che fa la governante presso una ricca famiglia di città. Sedotta dal rampollo di casa, rimane incinta. Per liberarsi del problema, la padrona la taccia di furto e la fa arrestare. Dopo mesi nella fetida, sovraffollata prigione di Newgate, Evangeline viene condannata a imbarcarsi per la Terra di Van Diemen, una colonia penale in Australia. Benché incerta di quello che la aspetta Evangeline sa una cosa: il bambino che sta aspettando nascerà prima del suo arrivo in quella terra lontana. Durante il viaggio su una nave di schiavi, la Medea, Evangeline stringe amicizia con Hazel, una ragazzina che è stata condannata a sette anni di esilio per aver rubato un cucchiaio d’argento. Hazel è molto più astuta di lei, ed essendo un’esperta ostetrica ed erborista, offre aiuto e rimedi casalinghi alle prigioniere e ai marinai in cambio di favori. Benché l’Australia sia stata la patria del popolo aborigeno per più di 50.000 anni, il Governo inglese considera la colonia un luogo non civilizzato e i nativi come un fastidioso inconveniente. Quando la Medea attracca, la loro terra è stata occupata dai bianchi e molti dei nativi sono stati forzatamente spostati altrove. Fra questi c’è Mathinna, la figlia orfana del capo della tribù Lowreenne, che è stata adottata dal nuovo governatore della Terra di Van Diemen.

Per Hayden, Will ed Eli, tutti avventurosi viandanti
Nessuno dica che il passato è morto.
Il passato è tutto intorno e dentro di noi.
OODGEROO NOONUCCAL, POETA ABORIGENO
PROLOGO
Flinders Island, Australia, 1840
Quando arrivarono le piogge, Mathinna si nascondeva nel bush ormai da quasi due giorni. Aveva otto anni, e la cosa più importante che avesse mai imparato era come scomparire. Da quando era abbastanza grande per camminare, aveva esplorato ogni angolo e ogni crepa di Wybalenna, il remoto punto di Flinders Island dove la sua gente era stata esiliata da prima che lei nascesse. Aveva corso lungo la cresta di granito che si stendeva sulle cime delle colline, scavato gallerie nelle dune bianche sulla spiaggia, giocato a nascondino tra la sterpaglia e gli arbusti. Conosceva tutti gli animali: gli opossum e i wallaby e i canguri, i pademelon che vivevano nella foresta e uscivano solo di notte, le foche che se ne stavano in panciolle sugli scogli e scivolavano in acqua per rinfrescarsi.
Tre giorni prima, il governatore John Franklin e sua moglie, Lady Jane, erano arrivati a Wybalenna in barca, a più di duecentocinquanta miglia dalla loro residenza sull’isola di Lutruwita, o Terra di Van Diemen, come la chiamavano i bianchi. Mathinna si era messa sulla cresta con gli altri bambini mentre il governatore e la moglie salivano dalla spiaggia, accompagnati da cinque o sei servitori. Lady Franklin aveva faticato a camminare con le sue scarpe di raso lucido, continuando a scivolare sui sassi. Si era aggrappata al braccio del marito mentre barcollava verso di loro, con un’espressione acida come se avesse morsicato un cardo. Le rughe sul suo collo avevano ricordato a Mathinna le vistose escrescenze rosa sulla gola del bargigliuto rosso.
La sera prima, gli anziani dei palawa si erano seduti intorno al fuoco da campo, discutendo della visita imminente. I missionari cristiani si preparavano da giorni. I bambini avevano dovuto imparare una danza. Mathinna si era accovacciata nell’oscurità ai margini del cerchio, come faceva spesso, ascoltando gli anziani che parlavano mentre spennavano berte codacorta e arrostivano mitili sulle braci ardenti. I Franklin, si diceva, erano persone impulsive e sciocche; circolavano molte storie sulle loro idee strane ed eccentriche. Lady Franklin aveva il terrore dei serpenti. Una volta aveva escogitato un piano che prevedeva di pagare uno scellino per ogni serpente morto che le fosse stato consegnato, cosa che naturalmente aveva generato un solido mercato di allevatori ed era costato una piccola fortuna a lei e a Sir John. Quando i due avevano visitato Flinders l’anno precedente, l’avevano fatto per procurarsi teschi aborigeni per la loro collezione, teschi ottenuti decapitando i cadaveri e facendo bollire le teste per rimuoverne la carne.
George Robinson, l’inglese con la faccia da cavallo a capo dell’insediamento di Flinders, viveva con sua moglie in una casa di mattoni in un semicerchio di otto case simili, che comprendeva stanze per i suoi uomini, un’infermeria e un dispensario. Dietro c’erano venti cottage per i palawa. La notte del loro arrivo, i Franklin avevano dormito dai Robinson. La mattina seguente, di buon’ora, avevano visitato l’insediamento mentre i loro servitori distribuivano perline, biglie e fazzoletti. Dopo pranzo avevano convocato i nativi. I Franklin si erano accomodati su due sedie di mogano nella radura sabbiosa davanti alle case di mattoni, e per circa un’ora i pochi maschi palawa in buona salute erano stati costretti a esibirsi in un finto combattimento e a sfidarsi in una gara di lancio del giavellotto. Poi era stato il turno dei bambini.
Mentre Mathinna danzava in cerchio con gli altri sulla sabbia bianca, Lady Franklin aveva continuato a guardarla con un sorriso enigmatico.
Figlia del capotribù dei lowreenne, Mathinna era abituata da tempo a essere oggetto di un’attenzione particolare. Diversi anni prima, suo padre Towterer, come molti palawa deportati a Flinders, era morto di tubercolosi. Lei era orgogliosa di essere la figlia del capotribù, ma in realtà non l’aveva conosciuto bene. A tre anni dal cottage dei suoi genitori era stata mandata a vivere in una casa di mattoni con il maestro bianco, che le aveva fatto indossare cuffiette e vestiti con i bottoni e le aveva insegnato a leggere e scrivere in inglese e a usare il coltello e il cucchiaio. Nonostante ciò, Mathinna passava tutte le ore che poteva con sua madre Wanganip e con gli altri membri della tribù, la maggior parte dei quali non parlava inglese e non seguiva le usanze britanniche.
Erano passati solo pochi mesi da quando Wanganip era morta. Aveva sempre odiato Flinders. Spesso saliva sulla collina spinosa vicino all’insediamento e guardava oltre il mare turchese verso la sua patria, a sessanta miglia di distanza. Questo posto terribile, diceva a Mathinna, quest’isola sterile dove il vento era così forte da sradicare le verdure dal terreno e da trasformare i piccoli incendi in roghi furiosi, dove gli alberi perdevano la corteccia come i serpenti perdono la pelle, non assomigliava affatto alla sua terra nativa. Era una maledizione scagliata contro la sua anima. Contro tutte le loro anime. La loro gente era malaticcia; la maggior parte dei bambini nati a Flinders moriva prima di compiere un anno. Ai palawa era stata promessa una terra di pace e abbondanza; se avessero obbedito agli ordini, avevano assicurato gli inglesi, avrebbero potuto mantenere il loro stile di vita. «Ma era tutta una menzogna. Come tante menzogne a cui siamo stati così stupidi da credere» aveva detto Wanganip in tono amaro. «Quale altra scelta avevamo? Gli inglesi si erano già presi tutto.»
Guardando il viso di sua madre, Mathinna aveva visto l’ira nei suoi occhi. La bambina, però, non odiava l’isola. Era l’unica casa che avesse mai conosciuto.
«Vieni qui, piccola» l’aveva chiamata la moglie del governatore alla fine della danza, facendole segno con l’indice. Quando Mathinna si era avvicinata, Lady Franklin l’aveva scrutata con attenzione prima di rivolgersi al marito. «Che occhi espressivi! E che visetto dolce, non trovi? Insolitamente graziosa per una nativa.»
Sir John aveva scrollato le spalle. «Difficile distinguerli, francamente.»
«Mi domando se sia possibile istruirla.»
«Vive con il maestro, che le sta insegnando l’inglese.» Robinson aveva fatto un passo avanti. «Ha già abbastanza dimestichezza con la nostra lingua.»
«Interessante. Dove sono i suoi genitori?»
«È orfana.»
«Capisco.» Lady Franklin si era voltata di nuovo verso Mathinna. «Di’ qualcosa.»
Lei aveva fatto un mezzo inchino. L’arrogante scortesia degli inglesi non la sorprendeva più. «Cosa devo dire, signora?»
Lady Franklin aveva sgranato gli occhi. «Santo cielo! Sono molto colpita, Mr. Robinson. State trasformando i selvaggi in cittadini rispettabili.»
«A Londra, ho sentito dire, vestono gli oranghi come signori e signore e insegnano loro a leggere» aveva osservato Sir John.
Mathinna non sapeva cosa fosse un orango, ma aveva sentito parlare dei selvaggi intorno al fuoco da campo degli anziani: balenieri e cacciatori di foche britannici che vivevano come animali e si facevano beffe delle regole del comune decoro. Lady Franklin doveva essere confusa.
Robinson era scoppiato in una breve risata. «Questa è una situazione po’ diversa. Gli aborigeni sono esseri umani, dopotutto. La nostra teoria è che cambiando l’aspetto esteriore si può cambiare la personalità. Stiamo insegnando loro a mangiare il nostro cibo e a parlare la nostra lingua. Nutriamo le loro anime con il cristianesimo. Si sono rassegnati a usare i vestiti, come potete vedere. Abbiamo tagliato i capelli agli uomini e inculcato la verecondia alle donne. Abbiamo dato loro nomi cristiani per facilitare il processo.»
«Il tasso di mortalità è piuttosto alto, mi sembra di capire» aveva detto Sir John. «Costituzioni delicate.»
«Una circostanza sfortunata ma inevitabile» aveva replicato Robinson. «Li abbiamo portati fuori dal bush, dove non conoscevano Dio e nemmeno chi avesse creato gli alberi.» Aveva sospirato. «Il fatto è che tutti dobbiamo morire, e dovremmo prima pregare Dio affinché salvi le nostre anime.»
«Giustissimo. State rendendo loro un grande servizio.»
«Come si chiama questa?» aveva chiesto Lady Franklin, riportando l’attenzione su Mathinna.
«Mary.»
«E come si chiamava in origine?»
«In origine? Il suo nome aborigeno era Mathinna. I missionari l’avevano battezzata Leda. Noi abbiamo optato per qualcosa di meno… fantasioso» aveva spiegato Robinson.
Mathinna non ricordava di essere stata chiamata Leda, ma sua madre odiava il nome Mary, così i palawa si erano rifiutati di usarlo. Solo i britannici la chiamavano Mary.
«Be’, la trovo incantevole» aveva continuato Lady Franklin. «Mi piacerebbe tenerla.»
Tenerla? Mathinna aveva cercato di catturare lo sguardo di Robinson, ma lui l’aveva ignorata.
Sir John era parso divertito. «Volete portarla a casa con noi? Dopo quello che è successo con l’ultimo?»
«Questa volta sarà diverso. Timeo era…» Lady Franklin aveva scosso la testa. «La bambina è orfana, avete detto?» aveva chiesto a Robinson.
«Sì. Suo padre era un capotribù. Sua madre si è risposata, ma è morta da poco.»
«Questo fa di lei una principessa?»
Robinson aveva accennato un sorriso. «In un certo senso, forse.»
«Che ne pensate, Sir John?»
Sir John aveva sorriso benevolmente. «Se desiderate divertirvi in questo modo, mia cara, suppongo che non ci sia nulla di male.»
«Penso che sarà piacevole.»
«E se non lo è, possiamo sempre rimandarla indietro.»
Mathinna non voleva lasciare l’isola con quella gente stupida. Non voleva dire addio al suo patrigno e agli altri anziani. Non voleva andare in un luogo nuovo ed estraneo dove nessuno la conosceva o le voleva bene. Tirando Robinson per la mano, aveva sussurrato: «Per favore, signore. Io non…».
Liberandosi, l’uomo si era girato verso i Franklin. «Prenderemo gli accordi necessari.»
«Molto bene.» Lady Franklin aveva inclinato il capo, studiando la bambina. «Mathinna. Preferisco chiamarla così. Lascerà gli altri ancora più a bocca aperta se apprenderà le maniere di una signora.»
In seguito, quando l’entourage del governatore era distratto, Mathinna era sgattaiolata dietro le case di mattoni, con ancora addosso il mantello cerimoniale di pelle di wallaby che suo padre le aveva regalato prima di morire e una collana di minuscole conchiglie verdi realizzata da sua madre. Facendosi strada tra l’erba, setosa contro i suoi stinchi, aveva ascoltato i latrati dei cani e i gorgheggi dei currawong, paffuti uccelli neri che sbattevano le ali quando stava per piovere. Aveva inalato il familiare profumo degli eucalipti. Mentre scivolava tra il bush sul bordo della radura, aveva alzato lo sguardo per vedere un nugolo di berte codacorta levarsi nel cielo.
EVANGELINE
Non sono mai venuto a conoscenza dell’esistenza di detenute che giudicherei di buon carattere. La loro viziosità palese e impudente ha da esser smascherata. Si stenterebbe a credere alla loro audacia feroce e indomabile. Sono la peste e la cancrena della società coloniale – un rimprovero alla natura umana – e inferiori ai bruti, una vergogna per tutte le forme di vita animali.
James Mudie, The Felonry of New South Wales:
Being a Faithful Picture of the Real Romance of Life
in Botany Bay, 1837
ST. JOHN’S WOOD, LONDRA, 1840
Dal profondo di un sogno inquieto, Evangeline sentì bussare. Aprì gli occhi. Il silenzio. Poi, più insistente: toc toc toc.
Una sottile striscia di luce proveniente dalla finestrella sopra il letto tagliava il pavimento. Evangeline provò un’ondata di panico: doveva aver dormito dopo la campana del mattino.
Non le era mai successo.
Alzandosi a sedere, si sentì intontita. Si appoggiò al cuscino. «Solo un minuto.» Inghiottì la saliva che le aveva riempito la bocca.
«I bambini stanno aspettando!» La voce della sguattera era carica di indignazione.
«Che ora è, Agnes?»
«Le nove e mezzo!»
Raddrizzandosi di nuovo, Evangeline spinse indietro le coperte. La bile le salì in gola, e questa volta non riuscì a tenerla giù; piegandosi, vomitò sul pavimento di pino.
La manopola ruotò e la porta si spalancò. Evangeline alzò lo sguardo impotente mentre Agnes storceva il naso e corrugava la fronte davanti agli schizzi gialli e viscosi ai suoi piedi. «Dammi un minuto. Per favore.» Evangeline si pulì la bocca sulla manica.
Agnes non si mosse. «Avete mangiato qualcosa di strano?»
«Non mi pare.»
«Avete la febbre?»
Evangeline si premette la mano sulla fronte. Fredda e umida. Scosse la testa.
«Stavate già male?»
«Non fino a questa mattina.»
Agnes arricciò le labbra.
«Sto bene, sono solo…» Evangeline sentì un bruciore allo stomaco. Deglutì a fatica.
«Chiaramente non è così. Informerò Mrs. Whitstone che oggi non ci saranno lezioni.» Con un cenno sbrigativo, Agnes si voltò per andarsene, poi si fermò, stringendo gli occhi in direzione del comò.
Evangeline seguì il suo sguardo. In cima, accanto a uno specchio ovale, un anello con rubino brillava sotto i raggi del sole, macchiando di un rosso intenso il fazzoletto bianco su cui era posato.
Provò una stretta al cuore. Aveva ammirato l’anello alla luce di una candela la sera prima, dimenticando stupidamente di metterlo via.
«Dove l’avete preso?» chiese Agnes.
«È… un regalo.»
«Di chi?»
«Di un membro della famiglia.»
«Della vostra famiglia?» Agnes sapeva bene che Evangeline non aveva nessuna famiglia. Aveva fatto domanda per diventare l’istitutrice solo perché non aveva un altro posto dove andare.
«È… un cimelio.»
«Non ve l’ho mai visto addosso.»
Evangeline posò i piedi sul pavimento. «Per l’amor del cielo. Non ho molte occasioni, vero?» Cercò di sembrare brusca. «Ora, vuoi lasciarmi in pace? Sto benissimo. Incontrerò i bambini in biblioteca tra un quarto d’ora.»
Agnes le lanciò un’occhiata decisa. Poi uscì chiudendo la porta.
In seguito, Evangeline avrebbe rivissuto quel momento nella sua testa in una dozzina di modi: cosa avrebbe potuto dire o fare per depistare Agnes. Probabilmente non avrebbe avuto importanza. La sguattera non aveva mai nutrito molta simpatia per lei. Solo di pochi anni più grande di Evangeline, lavorava per i Whitstone da quasi un decennio e ostentava la sua esperienza professionale rispetto a Evangeline con superba condiscendenza. La rimproverava sempre di non conoscere le regole o di non capire come funzionassero le cose. Quando Evangeline aveva confidato all’aiuto maggiordomo, suo unico alleato in quella casa, che non capiva il palpabile disprezzo di Agnes, lui aveva scrollato il capo. «Suvvia. Non siate ingenua. Fino al vostro arrivo era l’unica ragazza attraente qui dentro. Ora siete voi ad attirare tutta l’attenzione, compresa quelle del giovane padrone. Che era solito flirtare con Agnes, o almeno così credeva lei. E come se non bastasse, il vostro lavoro è leggero.»
«Niente affatto!»
«Non è come il suo, però, vero? Lavare la biancheria con la liscivia e svuotare vasi da notte dall’alba al tramonto. Voi siete pagata per il vostro cervello, non per la vostra schiena. Non mi sorprende che Agnes sia suscettibile.»
Evangeline si alzò dal letto e andò verso il comò, evitando cautamente la pozza. Prendendo l’anello, lo avvicinò alla finestra, notando con sgomento come catturava e rifrangeva la luce. Si guardò intorno. Dove poteva nasconderlo? Sotto il materasso? Nella federa del cuscino? Aprendo l’ultimo cassetto, lo mise nella tasca di un vecchio vestito infilato sotto altri più recenti.
Almeno Agnes non aveva notato il fazzoletto bianco sotto l’anello, con le iniziali in corsivo di Cecil: C.F.W. per Cecil Frederic Whitstone, e l’inconfondibile stemma di famiglia ricamato in un angolo. Lo mise nel cinturino della sottoveste e cominciò a pulire.
Mrs. Whitstone si materializzò in biblioteca mentre i bambini leggevano a turno da un abbecedario. Sollevarono lo sguardo, stupiti. Non era da lei presentarsi senza preavviso durante le lezioni.
«Miss Stokes» esordì in tono insolitamente altezzoso, «vi prego di concludere il più in fretta possibile e di raggiungermi in salotto. Ned, Beatrice, Mrs. Grimsby ha preparato un pudding speciale. Non appena avete finito, potete andare in cucina.»
I bambini si scambiarono un’occhiata incuriosita.
«Ma Miss Stokes ci porta sempre giù per il tè» obiettò Ned.
Sua madre accennò un sorriso. «Sono abbastanza sicura che riuscirete a trovare la strada da soli.»
«Siamo in castigo?» domandò Ned.
«Certo che no.»
«Lo è Miss Stokes?» chiese Beatrice.
«Che domanda ridicola!»
Evangeline sentì un fremito di paura.
«Mrs. Grimsby ha fatto il pan di Spagna?»
«Lo scoprirai presto.»
Mrs. Whitstone uscì. Evangeline fece un respiro profondo. «Concludiamo questo capitolo, d’accordo?» disse, ma non era là con la testa, e comunque i bambini erano distratti dal pensiero della torta. Quando Ned finì di leggere con voce cantilenante un capoverso sul canottaggio, Evangeline sorrise. «Va bene, bambini, basta così. Potete andare a far merenda.»
Eccolo: l’anello di rubino, scintillante nel bagliore delle lampade a olio di balena nel salotto tetro. Mrs. Whitstone lo tenne davanti a sé come l’oggetto trovato durante una caccia al tesoro. «Dove l’avete preso?»
Evangeline attorcigliò l’angolo del grembiule, una vecchia abitudine dell’infanzia. «Non l’ho rubato, se è questo che state insinuando.»
«Non sto insinuando nulla. Sto facendo una domanda.»
Udendo un rumore dietro di sé, Evangeline si voltò, sussultando alla vista di un poliziotto in piedi nell’ombra dietro una sedia. Aveva i baffi flosci e portava un panciotto nero attillato e un manganello in una fondina; teneva in mano un taccuino e una matita.
«Signore.» Evangeline fece un leggero inchino. Il cuore le batteva così forte che temette che l’uomo potesse sentirlo.
Lui inclinò la testa, annotando qualcosa nel taccuino.
«Questo anello è stato trovato in vostro possesso» spiegò Mrs. Whitstone.
«Voi… siete entrata nella mia camera.»
«Siete alle dipendenze di questa famiglia. Non è la vostra camera.»
Evangeline non sapeva cosa rispondere.
«Agnes l’ha visto sul comò quando è venuta a chiamarvi. Come sapete. E poi l’avete nascosto.» Sollevando di nuovo il gioiello, Mrs. Whitstone guardò oltre Evangeline, verso il poliziotto. «Questo anello è di proprietà di mio marito.»
«Non è vero. È di Cecil» si lasciò sfuggire Evangeline.
L’agente spostò lo sguardo tra le due donne. «Cecil?»
Mrs. Whitstone scoccò un’occhiataccia a Evangeline. «Il giovane Mr. Whitstone. Il mio figliastro.»
«Conferma che questo anello è del suo figliastro?» Quando parlò, i baffi si mossero sotto il suo naso bulboso.
Con un sorriso forzato, Mrs. Whitstone disse: «Apparteneva alla madre di mio marito. Occorre chiedersi, forse, se ora appartenga a mio marito o a suo figlio. Di sicuro non appartiene a Miss Stokes».
«È stato lui a darmelo» confessò Evangeline.
Solo pochi giorni prima, Cecil aveva tirato fuori dalla tasca una scatolina di velluto blu e gliel’aveva appoggiata sul ginocchio. «Aprila.»
Lei l’aveva guardato stupita. L’astuccio di un anello. Poteva essere? Impossibile, naturalmente, eppure… Si era concessa un piccolo barlume di speranza. Non le ripeteva forse sempre che era più bella, più affascinante, più intelligente di qualunque donna della sua cerchia? Che non gli importava un fico secco delle aspettative della sua famiglia o degli stupidi giudizi morali della società?
Appena aveva sollevato il coperchio, era rimasta senza fiato: un cerchietto d’oro, sapientemente lavorato a filigrana, si alzava in quattro punte curve che sostenevano una pietra rosso intenso.
«Il rubino di mia nonna» aveva continuato Cecil. «Me l’ha lasciato in eredità quando è morta.»
«È meraviglioso. Ma mi stai…»
«Oh, no, no! Non corriamo troppo.» Era scoppiato in una piccola risata. «Per ora mi basta vedertelo al dito.»
Quando aveva sfilato l’anello dalla fessura nel cuscinetto e glielo aveva messo al dito, il gesto era stato così intimo da essere emozionante e, allo stesso tempo, così strano da essere costrittivo. Evangeline non ne aveva mai indossato uno prima; suo padre, un parroco, non credeva negli ornamenti. Cecil aveva chinato dolcemente la testa, baciandole la mano. Poi aveva chiuso di scatto la scatolina, riponendola di nuovo nella tasca del panciotto e tirando fuori un fazzoletto bianco. «Infila l’anello qui dentro e nascondilo fino al mio ritorno dalle vacanze. Sarà il nostro segreto.»
Ora, nel salotto con l’agente di polizia, Mrs. Whitstone sbuffò. «È ridicolo. Perché mai Cecil dovrebbe regalarvi…» Si interruppe, fissando Evangeline.
Lei si rese conto di aver detto troppo. Sarà il nostro segreto. Ma Cecil non era là. Si sentiva disperata, in trappola.
E adesso, tentando di difendersi, aveva rivelato il vero segreto.
«Dov’è ora il giovane Mr. Whitstone?» chiese il poliziotto.
«All’estero» rispose Mrs. Whitstone, nello stesso momento in cui Evangeline diceva: «A Venezia».
«Si potrebbe provare a contattarlo» suggerì l’uomo. «Avete un indirizzo?»
Mrs. Whitstone scosse la testa. «Non sarà necessario.» Incrociando le braccia, aggiunse: «È ovvio che la ragazza sta mentendo».
Lui inarcò un sopracciglio. «È già successo in passato?»
«Non ne ho idea. Miss Stokes è con noi solo da qualche mese.»
«Cinque» precisò Evangeline. Facendo appello a tutta la sua forza, si voltò verso il poliziotto. «Ho fatto del mio meglio per istruire i figli di Mrs. Whitstone e contribuire a formare il loro carattere morale. Non sono mai stata accusata di nulla.»
Mrs. Whitstone proruppe in una piccola risata secca. «Così dice lei.»
«È abbastanza facile scoprirlo» osservò l’agente.

CHRISTINA BAKER KLINE Autrice bestseller del New York Times, ha scritto otto romanzi tra cui Le cose che non so di te e Un frammento di mondo, ed è pubblicata in quaranta paesi. Tra gli altri ha ricevuto il New England Prize for Fiction, il Maine Literary Award, e il Barnes & Noble Discover Award. I suoi articoli sono apparsi su New York Times e NYT Book Review, The Washington Post, The Boston Globe, The San Francisco Chronicle, LitHub, Psychology Today, e Slate.