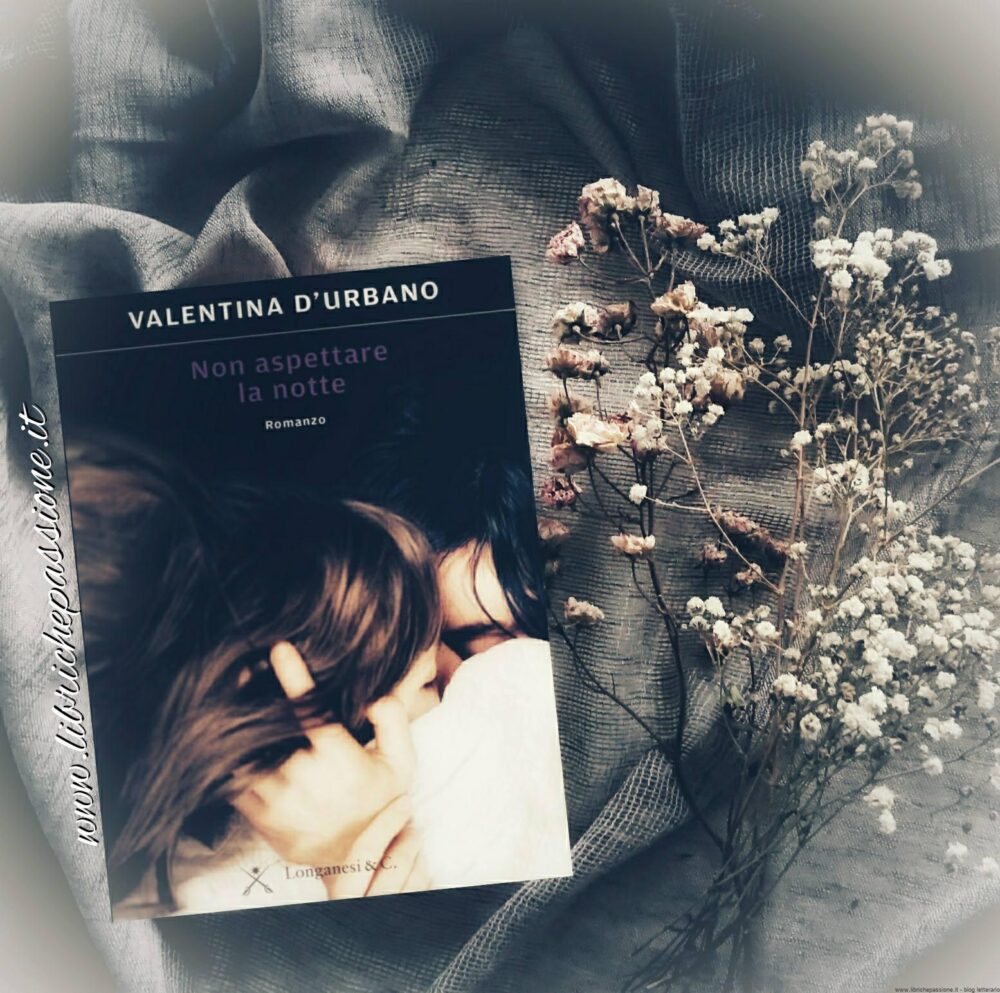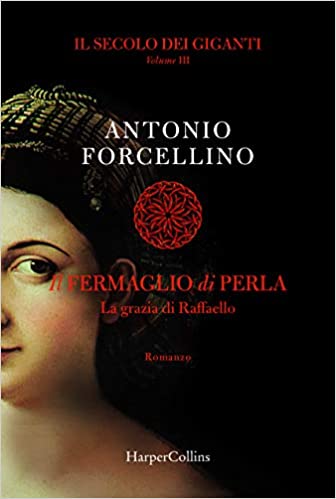Inghilterra, 1874. A 19 anni finalmente Agnes può lasciare l’orfanotrofio in cui è cresciuta e mettersi alla ricerca di sua madre. Da poco, infatti, ha scoperto che la donna che l’ha abbandonata ha lasciato accanto a lei un bottone decorato con un unicorno. E lei ricorda benissimo di aver visto un cappotto cui mancava proprio un bottone identico: l’aveva donato all’orfanotrofio una nobildonna, Genevieve Breckby…
Convinta che Genevieve sia sua madre, Agnes ne ripercorre le tracce fino a Londra e a Parigi, e poi, mossa da un’incrollabile determinazione, s’imbarca sulla Persephone, che la condurrà in una terra selvaggia e misteriosa: l’Australia.
Londra, oggi. È in Australia che Tori ha deciso di vivere. Ora però deve tornare a casa, in Inghilterra, per lasciarsi alle spalle un doloroso divorzio, ma soprattutto per aiutare la madre, brillante studiosa dell’epoca vittoriana, che soffre di Alzheimer. Mentre mette ordine nelle sue carte, Tori trova una lettera che risale alla fine dell’800. Una nobildonna scrive alla figlia, spiegandole i motivi per cui l’ha abbandonata, e le incredibili vicissitudini che l’hanno portata a quel terribile gesto. Ma la lettera è incompleta e Tori, prima incuriosita e poi sempre più coinvolta, decide di mettersi alla ricerca dei fogli mancanti…
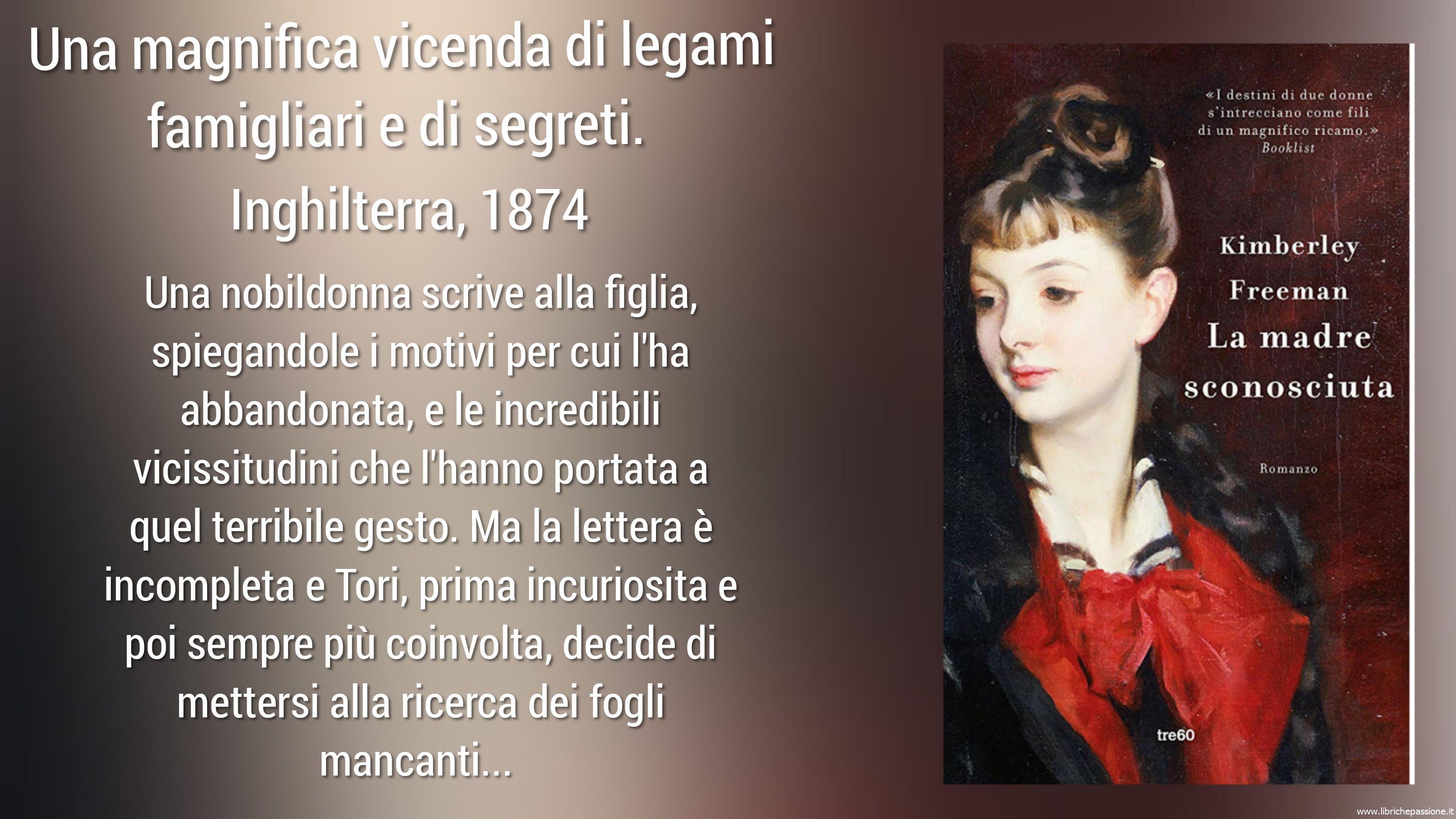
Presentazione
Inghilterra, 1874. A 19 anni finalmente Agnes può lasciare l’orfanotrofio in cui è cresciuta e mettersi alla ricerca di sua madre. Da poco, infatti, ha scoperto che la donna che l’ha abbandonata ha lasciato accanto a lei un bottone decorato con un unicorno. E lei ricorda benissimo di aver visto un cappotto cui mancava proprio un bottone identico: l’aveva donato all’orfanotrofio una nobildonna, Genevieve Breckby…
Convinta che Genevieve sia sua madre, Agnes ne ripercorre le tracce fino a Londra e a Parigi, e poi, mossa da un’incrollabile determinazione, s’imbarca sulla Persephone, che la condurrà in una terra selvaggia e misteriosa: l’Australia.
Londra, oggi. È in Australia che Tori ha deciso di vivere. Ora però deve tornare a casa, in Inghilterra, per lasciarsi alle spalle un doloroso divorzio, ma soprattutto per aiutare la madre, brillante studiosa dell’epoca vittoriana, che soffre di Alzheimer. Mentre mette ordine nelle sue carte, Tori trova una lettera che risale alla fine dell’800. Una nobildonna scrive alla figlia, spiegandole i motivi per cui l’ha abbandonata, e le incredibili vicissitudini che l’hanno portata a quel terribile gesto. Ma la lettera è incompleta e Tori, prima incuriosita e poi sempre più coinvolta, decide di mettersi alla ricerca dei fogli mancanti…
Il presente
«Mamma?»
«È confusa. Non si preoccupi se…»
«Mamma» dico con più fermezza, come avrei fatto da adolescente, con una traccia di esasperazione nonostante il tono affettuoso. Sto guardando il volto di mia madre; anche lei mi fissa di rimando, ma è come se un velo fosse calato tra noi. Da una parte io, l’infermiera e le pareti verde pastello della clinica. Dall’altra, mia madre, smarrita tra i flutti.
«Victoria?» dice infine, e il velo cade.
Sorrido. «Sono io. Sono qui.» È l’unica a chiamarmi con il nome intero. Per tutti gli altri sono Tori, un nome moderno, pratico. Lei mi ha dato il nome di una regina. Ma non sono una regina, io.
«Sono andata in mezzo alle macchine» dice, quasi a voler spiegare le abrasioni sul viso pallido con qualche ruga.
«L’ho saputo.»
«Sarebbe potuta andare peggio, forse. Almeno non mi sono rotta nulla.» Tira su con il naso. «Non sarai venuta dall’Australia per questo, vero?»
L’infermiera accarezza la gamba di mia madre sopra le coltri. «Vi lascio sole, signora Camber?»
«Professoressa Camber.» Io e mia madre correggiamo l’infermiera contemporaneamente, con voci cariche di rassegnata indignazione.
«Ah, le torna la memoria, vedo» dice l’infermiera uscendo, e il tono non è gentile. Pensavo che le infermiere fossero più umane, ma questa parla con mia madre come se fosse una vecchia rimbambita. La mamma ha solo settant’anni, e non ha nulla di una vecchia rimbambita.
Ora che sono sola con lei, la guardo di nuovo. Sembra spaventata. La paura contagia anche me, mi sento gelare. Perché ha paura? Dovrei averne anch’io? Mi impongo di sorridere per camuffarla. «Allora» esordisco.
Sorride anche lei. Per qualche motivo, il mio sorriso la rassicura. «Non sei certo venuta dall’Australia per questo» ripete, e non so se lo fa per ribadire il concetto o perché ha dimenticato di averlo già detto.
«L’incidente? No. È per via… dell’altro…»
Ma il suo sguardo scivola via. Mia madre era bellissima da giovane, e una bellezza come la sua non sfiorisce mai del tutto. Sì, ha i capelli color acciaio, le guance scavate, la pelle attorno alle labbra segnata dalle rughe, ma gli occhi sono ancora enormi e blu, quasi viola, e le ciglia lunghe e scure.
Un debole raggio di sole entra dalla finestra, e sento le grida soffocate dei gabbiani che si lasciano trasportare dalle correnti sopra il canale di Bristol. La mamma lavora a Bristol, ma ha sempre abitato qui, a Portishead. Casa sua dista cinque minuti a piedi dalla clinica. Dev’esserci passata davanti migliaia di volte durante le passeggiate pomeridiane; certo non avrà mai pensato che sarebbe finita qui, nella «casa per signore un po’ suonate», come diceva lei.
Ma per quanto tempo continuerà a lavorare a Bristol? La prospettiva del pensionamento forzato è stata la nota dolente, onnipresente nelle sue mail degli ultimi diciotto mesi.
«Non è grave come pensano» dichiara infine. «Dimentico alcune cose, ne ricordo altre…»
«Quando la tua dottoressa mi ha chiamata, ha detto che non è la prima volta che ti trovano a vagare senza meta.»
«Un giorno mi sono sbagliata a un incrocio, tornando a casa dal lavoro. Hanno cambiato il percorso dell’autobus, e mi sono confusa, tutto qui. Non dar retta alla dottoressa Chaudry, è giovane e pensa di sapere tutto.»
Non insisto. Quattro volte, ha detto la dottoressa. Quattro volte nel corso degli ultimi due anni la mamma è stata trovata in giro, confusa e smarrita. «Possiamo immaginare che sia successo altre volte in cui è riuscita a tornare a casa e non me l’ha detto» ha aggiunto. Erano stati condotti esami a mia insaputa, e la diagnosi non aveva sorpreso nessuno. La formidabile professoressa emerita di storia del Locksley College, Margaret Camber, ormai non c’era più con la testa.
Era proprio suonata.
E se si tratta di una diagnosi terribile per chiunque, lo è doppiamente per una donna che per tutta la vita è stata incredibilmente intelligente.
Triplamente, perché si tratta di mia madre.
Mi siedo e le prendo la mano nella stanza con le luci soffuse; non riesco a credere che stia accadendo davvero. Che mia madre non sia invincibile. Che la malattia e la morte possano averla vinta su di lei, proprio come su chiunque altro. La testa mi duole per via del jet lag. Non riesco ad afferrare pensieri completi, ma solo a sprazzi. Sono triste e voglio che mia madre mi consoli, ma stranamente sembra che sia io a dover consolare lei.
«Quanto tempo ti fermi?» chiede dopo un po’.
«Finché avrai bisogno di me.»
«Geoff si arrabbierà se ti trattengo troppo.»
«Geoff se la caverà.»
Cala di nuovo il silenzio. Poi: «Quanto tempo ti fermi?»
«Finché… Non lo so. Non ho prenotato il volo di ritorno.»
«Devi andare in ufficio per me.»
«In ufficio? A Locksley?»
Annuisce, e mi accorgo che sta ritrovando le energie. Si irrigidisce. «Getteranno via tutto, e non ho ancora finito di fare la cernita.»
«Le tue carte, i libri? Vuoi che porti via tutto?»
«Ci sono delle cose… Hanno ammucchiato tutto al centro della stanza. Delinquenti.»
«Ma certo, mamma. Certo. Dov’è la chiave?»
«Con le altre. La mia borsa è in quel cassetto.»
Indica un cassettone dall’altra parte del letto. Apro il cassetto più in basso, profondo, ed estraggo la borsa. Trovo all’interno un mazzo di chiavi.
«Ci vado direttamente, appena l’infermiera mi manda via» le prometto.
Si rilassa. «Pensavo di averlo visto, sai? Emile.»
«Chi è Emile?»
«Adesso capisco che non è possibile. Mi sono confusa. Ma l’ho visto e sono andata verso di lui, senza controllare se arrivavano macchine.»
«Chi è Emile?» ripeto.
Scuote il capo, avvilita. «Volevo solo chiedergli com’era andata a finire.» La frase finisce in un borbottio indistinto. Il velo cala di nuovo. Non sono neanche sicura che si accorga della mia presenza.
Le accarezzo la mano e non dico nulla. Arriva l’infermiera, annunciando allegra l’ora del tè. Non so se per colpa del jet lag o delle condizioni di mia madre, ma non mi sembra che sia l’ora del tè. Ho l’impressione che sia mezzanotte.
Il Locksley College si trova in fondo a un lungo viale alberato sul prolungamento del ponte sospeso di Clifton. Mia madre era ben felice di imbattersi ogni giorno, recandosi al lavoro, in uno dei simboli dell’architettura vittoriana, essendo una studiosa della storia del XIX secolo. Per essere precisi, la sua specialità sono i costumi e le tradizioni dell’Inghilterra del XIX secolo. Una volta presentò perfino una breve serie televisiva su BBC2, intitolata Victorian Women’s Lives. Era negli anni ’90, quando mi imbarazzavano i commenti dei colleghi, al lavoro, sul fascino che mia madre continuava a esercitare: lei aveva cinquant’anni, io diciannove, e sembravo definitivamente condannata a vivere nella sua ombra.
Procedo a passo d’uomo, in cerca di un posto dove parcheggiare l’auto presa a noleggio. Sono troppo stanca per guidare, ma sono sopravvissuta al tragitto di due ore sulla M4 da Heathrow, e restare in casa sapendo che la mamma desidera disperatamente che passi dal suo ufficio mi sembra un eccesso crudele di prudenza. Trovo un buco e pago il parchimetro, poi attraverso, raggiungo Beech House (costruita nel 1901, così vittoriana) e mi reco al terzo piano percorrendo scale di pietra dai gradini consumati, fino all’ufficio della mamma.
Mi sento… non colpevole; forse la parola che cerco è furtiva. Mi guardo attorno prima di infilare la chiave nella serratura. Tutto tace. Sono le sei passate. Sono andati tutti a casa a godersi la lunga serata inglese, oppure sono in vacanza. Mi chiudo la porta alle spalle e respiro gli odori che associo a mia madre: libri vecchi e olio di rosa. Mi concedo un attimo, faccio qualche respiro e guardo cosa mi aspetta.
Mi si stringe lo stomaco per la rabbia. La mamma ha ragione: qualche «delinquente» ha tolto tutte le sue carte dai cassetti e dagli scaffali, e le ha buttate senza criterio dentro scatoloni riuniti al centro della stanza; sono ammonticchiati ma non chiusi. C’è una gran confusione. I libri sono impilati sulla scrivania e sul pavimento, e gli scaffali imbarcati sono spogli, coperti solo di polvere.
«Oh, mamma, mi dispiace» mormoro, prendo un fascio di carte – vecchie pagine di un libro di ricette del 1881 – e mi faccio vento. Fa caldo, c’è odore di chiuso. Non so da che parte cominciare.
Mi riprometto di tornare l’indomani mattina, presto. Dopo una buona notte di sonno. Troverò il preside e gliene dirò quattro per avere voluto mandare in pensione mia madre prima che si sentisse pronta, e per avere permesso a qualche buffone di creare un tale disordine tra i suoi preziosi documenti.
Mi siedo stancamente alla scrivania della mamma. Fuori della finestra vedo foglie e rami che ondeggiano nel vento della sera, leggermente distorti dal vetro spesso. Tra due pile di libri c’è un quadratino di carta, fragile tra le dita quando lo estraggo. La scrittura è scolorita, lunghe lettere inclinate. Sottolineato, in cima alla pagina:
Alla mia bambina, che non ho potuto tenere.
È solo una pagina, e un’occhiata veloce mi dice che si interrompe a metà frase, rivelandomi che è stata separata dalle seguenti. Immagino gli uomini senza riguardo che hanno spostato le cose della mamma e l’hanno trovata uscendo, forse sotto una delle loro scarpe sporche, e l’hanno posata distrattamente sulla scrivania.
Alla mia bambina. Che non ho potuto tenere.
Adesso sto piangendo. Sono stanca. La mamma è malata, e non le ho detto che ne ho perso un altro. Un altro bambino. Undici settimane, stavolta. Ero stata vicina, pericolosamente vicina all’annuncio della buona notizia. E ora sono vicina ai quarant’anni, e non c’è un bambino nella mia vita. Probabilmente non ci sarà mai.
Tutti i miei bambini, che non ho potuto tenere.
Sbatto le palpebre per liberare gli occhi dalle lacrime, irritata dalla mia stessa autocommiserazione, e leggo la prima pagina.
Alla mia bambina, che non ho potuto tenere.
Per prima cosa, non dubitare mai del fatto che ti abbia amata. Ti amo ancora oggi.
Sei stata concepita con amore, sei nata con amore, e mi sei stata portata via per amore. Ti ho cercata per mesi, ma la mia famiglia – soprattutto mia sorella, che pensavo sarebbe stata più umana con me – ha rifiutato categoricamente di dirmi dove sei, assicurandomi solo che quelle persone si sarebbero prese cura di te come si conviene. Ormai avrai cominciato a sorridere, forse anche a dire le prime parole alla tua nuova mamma. Avrai imparato ad amare i ritmi e il timbro della sua voce, la sensazione delle sue braccia attorno a te, il lettino in cui dormi. È un dolore che mi ferisce come una lama, ma non riesco a immaginare di portarti via da un luogo dove sei felice e al sicuro. Se ti trovassi, se ti stringessi a me come desidero fare, ti porterei in un mondo di incertezza e povertà. Mio padre ha messo in chiaro il prezzo da pagare se rovinassi la reputazione della nostra famiglia. L’amore non ci salverebbe dall’indigenza.
Ma non ti ho dimenticata e non ti dimenticherò mai, bambina mia. Anche se forse non leggerai mai queste mie parole, sento il dovere di scrivere gli eventi che…
Si interrompe qui. Mi chiedo da quanto tempo mia madre sia stata in possesso di questa lettera, e se il resto sia qui, da qualche parte. Le giungevano documenti del genere da ogni angolo del mondo, trovati in fondo a vecchi libri o nei bauli ammuffiti di una bisnonna dopo il funerale. Aveva cercato di convincere Locksley a creare un archivio per quel materiale, ma secondo il preside, per tutto ciò che esulava da temi di guerra e politica – argomenti da uomini –, mancavano i fondi.
Lascio la pagina dove l’ho trovata. Mi sento la testa pesante e non riuscirò a restare sveglia a lungo.
Scrivo su un foglio NON TOCCARE, mi chiudo la porta alle spalle e torno a casa di mia madre.
L’odore, dimenticato ma familiare, della casa della mamma mi accoglie al mio arrivo. Accendo la luce nell’ingresso e appoggio la valigia. La porterò di sopra dopo; per ora vado in cerca di cibo e di un posto dove coricarmi.
Quando si accende la luce in cucina, sbatto le palpebre perplessa. All’inizio penso che abbia appeso delle bandierine gialle ovunque, invece poi capisco che ha coperto i mobili con dei foglietti gialli adesivi. Alcuni sono chiarissimi: Parrucchiere martedì ore 15. Altri lo sono meno: Altro libro o Ultimi cerchi o Chiedere a Beth o 1875. Ma sono tantissimi, e con gli occhi li percorro tutti, dicendo al cervello ciò che non vuole sentire. La mamma sa che sta perdendo la memoria; questi sono i suoi tentativi per preservarla.
Passo da un mobiletto all’altro, e faccio il giro dei biglietti per ritrovare le tracce dei percorsi mentali di mia madre. Non riesco a dare un senso a tutto ciò, ma immagino che la memoria sia proprio così: lampi che si allontanano e si avvicinano tra loro. Su un foglietto, appiccicato a mezza altezza sulla credenza dove tiene le tazze da tè, compare solo un nome scritto in caratteri maiuscoli: EMILE VENSON.
Il mio cervello, rallentato dal jet lag, ci impiega qualche istante a reagire. La mamma ha pronunciato quel nome, oggi. Emile. Pensavo di averlo visto, sai?
Ha detto qualcosa a proposito del fatto che voleva scoprire come erano andate a finire le cose. Mia madre è sola da un pezzo. Mio padre, che adesso è morto, se n’è andato di casa quando avevo solo due anni. Molti uomini si sono interessati a mia madre, ma lei non ha mai ricambiato il loro interesse. Non so perché. Emile è un amante? L’ha lasciata? Come mai non l’ho saputo? Perché non sapevo che mia madre scriveva le sue memorie sui Post-it? Come ho potuto permettere alla distanza tra l’Inghilterra e l’Australia di diventare una distanza tra il suo cuore e il mio?
Premo il bacino sul piano di lavoro e mi sporgo in avanti, puntellandomi sui gomiti. La cucina è immersa in un silenzio perfetto, e sento il sangue che mi ronza nelle orecchie. Poi il motore del frigorifero si avvia, facendomi sussultare.
Cibo. Letto.
Allora riuscirò a chiudere gli occhi e a pensare alla mamma, e all’oceano che si è aperto tra noi.
Capitolo 1
Agnes
1874
Agnes aveva contato i gradini tra il piano inferiore e superiore di Perdita Hall centinaia di volte. Diciassette. Larghi in basso, più stretti dopo la svolta nella scalinata, che portava a un pianerottolo di legno le cui assi scricchiolavano sotto i piedi quando percorreva la guida scolorita – ma perfettamente rispettabile – che conduceva all’ufficio del capitano Forest. Se invece svoltava a destra, giungeva alla porta di Mrs Watford, la più anziana degli insegnanti. Era un percorso che Agnes conosceva bene, essendovi stata trascinata a più riprese per diverse infrazioni. Il pensiero di non dover più vedere Mrs Watford era piacevole, e il sentimento era senz’altro reciproco. Le ultime parole che l’insegnante le aveva rivolto erano state: «Almeno quando te ne andrai non dovremo aprire il cancello: lo scavalcherai come hai sempre fatto, no?»
Agnes si avvicinò alla porta chiusa del capitano Forest ed esitò un momento, guardando fuori della finestra in fondo al corridoio. Vedeva la cappella, i giardini, i laboratori e i dormitori che erano stati la sua casa per diciannove anni. L’unica casa che avesse mai conosciuto. Si chiese se ne avrebbe sentito la mancanza, ma non le sembrava possibile; desiderava disperatamente che la sua vita cominciasse.
Agnes bussò in fretta, timidamente.
«Avanti» disse una voce maschile, e Agnes aprì la porta.
Il suo primo incontro con il direttore risaliva al suo arrivo, perché Forest, si diceva, accoglieva di persona tutti i bambini al momento dell’ammissione a Perdita Hall; siccome Agnes era giunta appena nata, però, lei non se lo ricordava. La volta successiva aveva circa dieci anni. Le aveva fatto l’impressione di un uomo gentile, ma distratto. A dieci anni, ogni bambino dell’ospizio dei trovatelli effettuava il suo primo apprendistato, sul posto o in una delle botteghe o presso le famiglie del paese, e Forest lo invitava a bere il tè nel suo ufficio, approfittando dell’occasione per spiegargli cosa significava essere un bambino o una bambina di Perdita. Le aveva offerto una fetta di torta, dolce e burrosa, che le si era sciolta in bocca.
Agnes si chiese per un attimo se ci sarebbe stata la torta anche quel giorno, ma decise di no. Aveva diciannove anni, ormai. Non era più una bambina. Sarebbe cambiato tutto.
Forest era seduto dietro un’immensa scrivania. Sul muro, alle sue spalle, era appeso un prezioso barometro. Una serie di dipinti decoravano le pareti: acque turchine trasparenti e navi che solcavano flutti schiumosi. Un sestante di ottone davanti a lui serviva da fermacarte.
Agnes, che indossava un abito di cotone grigio, si fermò davanti alla scrivania a braccia conserte.
La calda luce primaverile che entrava dalla finestra gli illuminava l’argento dei baffi e delle basette. «Miss Agnes Resolute, vero?»
«Buongiorno, signore.»
Le sorrise e le indicò una sedia. «Prego.»
Agnes obbedì, passando le dita sugli intarsi raffinati dei braccioli della poltroncina.
Forest inforcò un paio di occhiali e sfogliò i documenti che aveva di fronte. «Siete stata qui tutta la vostra vita, Agnes. Eravate una neonata quando vi abbiamo accolta.»
«Sì, signore.»
«Vedo che avete svolto l’apprendistato nella lavanderia di Perdita.»
«Ho cucito e rammendato, signore. Mi è piaciuto.» Agnes era una brava sarta soprattutto perché amava il silenzio della stanza da cucito sopra la lavanderia, che lasciava alla sua immaginazione il tempo e lo spazio di viaggiare.
«Eccellente nella lettura e nella scrittura, non particolarmente portata per l’infermeria e per il lavoro in cucina, una cameriera efficace per la famiglia Bennett a Hatby…» Continuò a sfogliare le pagine, dove era riportata la sua storia. «Oh, cielo. Siete stata rimproverata molte volte per il vostro comportamento, Miss Resolute. Mi deludete.»
Agnes non sapeva se quel commento richiedesse una risposta, ma gliene venne in mente una. Si può rimproverare un uccello in gabbia se sbatte le ali contro le sbarre?
Alla fine lui alzò gli occhi. «Agnes, in occasione del vostro diciannovesimo compleanno ho la grande gioia di congedarvi: non avrete più l’obbligo di risiedere a Perdita Hall.»
Il viso della giovane non riuscì a reprimere un sorriso. «Grazie, signore.»
«Partirete con i vostri documenti, le referenze e naturalmente una piccola somma di denaro che vi permetterà di recarvi in città e cercare lavoro.» Una delle regole di Forest era che i ragazzi e le ragazze di Perdita compissero il tragitto di dieci miglia fino a York per iniziare una nuova vita: per questo forniva loro il denaro necessario per pagarsi il viaggio e un mese di affitto. «Mio fratello ha una lavanderia vicino a Petergate, potrebbe offrirvi…»
«Dubito che mi fermerò a York» dichiarò lei, senza sapere il perché. Forse ne aveva abbastanza che il capitano Forest continuasse a esercitare un controllo su di lei.
Lui sollevò subito le sopracciglia folte. «No? Avete progetti più ambiziosi?»
Agnes guardò i suoi quadri, e si chiese come potesse farle una domanda del genere. «Sì, signore. Proprio così.» In realtà non sapeva cos’avrebbe fatto. Aveva scritto a una casa di accoglienza per donne, che l’avrebbe ospitata per qualche settimana e aiutata nella ricerca di un lavoro, ma sperava di restarvi solo un mese, mettere da parte qualcosa e poi andare ad abitare in un posto dove si vedesse il mare. Non l’aveva mai visto.
«Ammiro il vostro coraggio, ma datemi retta; trovatevi un buon lavoro onesto e non vivete al di sopra delle vostre possibilità, non aspirate a una posizione sociale che non è la vostra. Questo è il segreto per essere felici. Se non commetterete questi… errori, andrà tutto bene.»
Agnes era abituata a tenere a freno la lingua in occasioni come queste. «Grazie, signore. Ho intenzione di essere felice.»
Lui ripose i documenti nella cartellina e annodò i cordoncini con un gesto teatrale. Si alzò e gliela consegnò con solennità. Il suo passato era lì dentro. Il suo futuro si trovava fuori dell’alto cancello di ferro di Perdita Hall.
«Addio, Miss Resolute. Portate il nome di una bella nave a vele quadre, agile e solida. Spero che possiate emularla e che facciate onore al buon nome di questo istituto.»
«Grazie, signore» disse, stringendogli la mano stranamente molle. «Addio.»
Uscì e si sedette sulle scale, sciogliendo il nodo del nastro. La gonna le si aprì, e sentì il freddo della pietra attraverso gli strati di stoffa. Agnes era impaziente di vedere cos’aveva scritto Mrs Robbins della lavanderia nella sua lettera di raccomandazione. Non erano mai andate d’accordo, e aveva bisogno di ottime referenze se voleva trovare lavoro come sarta. Il primo documento che le capitò in mano, però, fu quello relativo alla sua ammissione a Perdita Hall, e si soffermò a leggerlo.
Era presentato in forma schematica. Nome: Agnes (cognome suggerito: Resolute). Ogni bambino di Perdita riceveva come cognome il nome di una nave famosa. L’HMS Resolute era una cannoniera della Marina britannica che era stata smantellata prima della sua nascita.
Padre: ignoto.
Madre: ignota.
Agnes passò oltre. Quei fatti li conosceva, ma avevano ancora il potere di farla soffrire, anche se il dolore con il tempo si era attenuato.
Affidato di persona: No. Sotto il portico di primo mattino.
Altre righe, altri dettagli. Il peso, l’altezza, la mancanza di segni particolari, la testa di forma regolare e le orecchie piuttosto piccole. Agnes si toccò le orecchie. Non le aveva mai considerate troppo piccole.
Gli occhi giunsero in fondo al documento, e lo vide.
Oggetto ricordo: bottone con unicorno.
Il lampo di un ricordo, come una farfalla contro un vetro. Quasi tutti i bambini ricevevano un oggetto dalla madre che li aveva lasciati: un fiocco, una ciocca di capelli o perfino un pezzetto di spago trovato per strada. Agnes aveva sempre pensato di non averne uno, visto che non era stata affidata all’istituto di persona, con l’intenzione di essere identificata o recuperata più tardi. Invece era stata lasciata con un bottone. Un bottone raffigurante un unicorno.
Le torna in mente un ricordo vivido. Le voci dei bambini e il rumore degli zoccoli. È molto piccola, avrà cinque o sei anni, e si trova in paese con i compagni e un insegnante. Vede dall’altra parte della strada una donna alta e bionda, con la schiena dritta, che discute con un uomo rosso in volto. L’uomo cerca di restare calmo, ma lei lo accusa con veemenza.
«Non cercare di controllarmi!» grida, attraversando la strada con passo deciso verso i bambini.
Agnes sta seguendo la scena con così tanta concentrazione che è rimasta indietro, e adesso nella fretta di raggiungere gli altri inciampa e cade. Protende le mani in avanti e il gomito le finisce in una pozzanghera piena di fango.
La donna bionda si materializza al suo fianco e la aiuta ad alzarsi.
«Ti sei sporcata il vestito» le dice con un sorriso, staccandole dall’abito una foglia bagnata. Agnes guarda incantata il viso arrossato e gli occhi lucidi della donna. Ha l’aria vittoriosa. Il suo miserabile avversario si ritira sconfitto dall’altra parte della strada.
Poi Miss Candlewick la prende per un braccio strattonandola, ringrazia la donna, e trascina Agnes verso il gruppo. «Vieni» le dice. «Bambina disobbediente e testarda.»
«Chi era quella bella signora?» chiede Agnes.
«Genevieve. La figlia di Lord Breckby» dice Miss Candlewick aggrottando la fronte. «La trovi bella?»
«Sì. Bella e forte.»
«Che sciocchezza» replica Miss Candlewick. Poi, con voce più bassa: «Del resto, siete fatte della stessa pasta».
«Sedete sulle scale come una discola, Miss Resolute?»
Agnes chiuse la cartellina e annodò il nastro, senza mostrare il tremito delle mani. «No, signora, ho fatto cadere le carte e le ho dovute raccogliere.» Guardò in faccia Mrs Archer, l’insegnante di economia domestica. Lei e Agnes non erano mai andate particolarmente d’accordo, e Mrs Archer aveva sempre pensato che la colpa fosse dell’inadeguatezza morale di Agnes.
A ben vedere, Agnes e una dubbia moralità erano considerati quasi sinonimi a Perdita Hall.
«Siete una ragazza di Perdita ancora per qualche giorno, Agnes» le fece notare Mrs Archer nel suo forte accento del Sud. «Fate attenzione al modo in cui vi presentate.»
Agnes la guardò allontanarsi. Le veniva da ridere. Quella era l’ultima ramanzina di Mrs Archer. Si alzò e si lisciò la gonna, poi si diresse al suo dormitorio. Ripensando a quell’episodio della sua
infanzia, aveva sempre pensato che il commento di Miss Candlewick, sul fatto che lei e l’irruente Genevieve fossero «fatte della stessa pasta», fosse una frase detta tanto per dire. Ora, invece, sospettava che nascondesse qualcosa di ben diverso.
Orfana di madre. Esisteva un’espressione più triste? Agnes ci aveva pensato spesso stando seduta su quel letto stretto, nel dormitorio affollato, nel corso degli ultimi diciannove anni.
Il sole pomeridiano cercava di farsi strada tra gli alti faggi che si ammassavano contro le finestre. Non aprì più la cartellina. Non voleva che le altre curiosassero e le facessero domande. Quando si sarebbe sentita pronta avrebbe raccontato qualcosa a Gracie Badger, la sua più cara amica d’infanzia. Ma per ora, mentre le altre ragazze chiacchieravano, piegavano i loro abiti e leggevano, ripensò al fatto di essere orfana di madre, di essersi creduta una ragazza che non apparteneva a nessuno, a nessun luogo, e si chiese se un bottone con un unicorno potesse davvero indicare le sue origini.
I trovatelli imparavano a sopportare il dolore. Imparare ad assuefarsi alla sofferenza era il grande dono che ricevevano a Perdita Hall. Ai bambini veniva insegnato fin da subito che, se nessuno li voleva, ciò non significava che fossero privi di valore nella società. Quando Agnes si comportava male, cosa che accadeva spesso, si pensava che lo facesse perché si sentiva abbandonata, priva di punti di riferimento. «Guarda il letto accanto al tuo, e saprai che non sei l’unica a sentirti così» le ripeteva Mrs Watford. Gliel’aveva detto quando era salita su un faggio e aveva scavalcato il muro per andare a funghi nel bosco. Quando era stata sorpresa a fare disegni osceni sul quaderno invece di copiare le parole assegnate. Quando aveva avuto un litigio furibondo con quell’ipocrita di Charlotte Pelican secondo la quale, siccome Dio aveva creato Eva per seconda, la donna sarebbe sempre stata seconda all’uomo.
Agnes doveva ammettere, però, che il personale era quasi sempre gentile, e anche gli educatori più severi avevano il merito di fortificare i più deboli e di ridimensionare chi si dava troppe arie. Perdita Hall si considerava un’istituzione valida per allevare trovatelli, e forse era così. Ma quell’ambiente altamente controllato era stato soffocante per Agnes. Per diciannove anni sveglia alle sei, preghiera alle sei e dieci, latrina alle sei e un quarto, adunata alle sei e quarantacinque per le lezioni o il lavoro; obbedire allo squillo del corno per recarsi a colazione, pranzo, cena… diciannove anni vissuti al ritmo inflessibile della tabella di marcia di Perdita.
E naturalmente, per quanto l’istituto fosse umano, a tutti mancava una mamma. Quasi tutti i bambini immaginavano le madri come persone dolci, affettuose, amorevoli. Agnes, invece, le vedeva come specchi che mostravano alle figlie le persone che avrebbero potuto diventare al di là del cancello.
Forse le madri possedevano giacche con bottoni raffiguranti unicorni, proprio come quello che Agnes aveva visto su quella giacca…
Ma no, non poteva giungere a una conclusione simile. Non ancora. Doveva vedere quell’oggetto con i suoi occhi per esserne certa. Gli oggetti ricordo si trovavano tutti nell’ufficio di Forest. Lo sapevano tutti. Ne teneva alcuni in una vetrina e li mostrava ai visitatori; Agnes li aveva visti a dieci anni, quando aveva mangiato la torta. Aveva anche pensato che fosse strano esporre una collezione del genere, e a maggior ragione andarne fiero: cordoncini annodati, spille, pezzetti di pizzo macchiato. Ad accomunare tutti quei reperti era il loro aspetto patetico.
Ma trent’anni e settecento bambini dopo, gli oggetti ricordo erano molto numerosi. Dopo essere stati registrati e descritti nei documenti di ammissione, secondo l’assistente di Forest, lei stessa una bambina di Perdita, erano riposti in un cassettone. Ciò significava che Agnes doveva entrare nell’ufficio di Forest quando non c’era nessuno.
Agnes sapeva mentire benissimo quando era necessario, anche se le veniva qualche scrupolo se doveva raccontare bugie per saltare la messa. In quel momento, però, il bisogno di sapere prevaleva su tutto. Pregò Dio di perdonarla quando l’infermiera Maggie, chiamata dalla sua vicina di letto Alexandra Orion, si sedette sulla sponda del suo letto e posò una mano sulla fronte di Agnes. Il dormitorio era freddo e silenzioso, le ragazze si stavano alzando lentamente alle prime luci del mattino. In lontananza, nel paese di Hatby, si sentivano le campane della chiesa. La cappella di Perdita ne era sprovvista, se si escludeva una vecchia campana da nave appesa nel vestibolo.
«Niente febbre» dichiarò l’infermiera Maggie nel suo pesante accento scozzese.
«Mal di stomaco.»
«Forte?»
Agnes fece una smorfia. «Terribile.»
Agnes sapeva che l’infermiera non avrebbe corso rischi. Sei anni prima un attacco di febbre tifoidea aveva colpito Perdita Hall, uccidendo quattro bambini. Forest non se lo era mai perdonato.
«Irritazioni della pelle?»
Agnes scosse il capo, ma Maggie le sollevò ugualmente la camicia da notte per controllarle le gambe e il tronco. Premette la mano sulla pancia sotto l’elastico delle mutande, un po’ troppo forte, secondo Agnes.
«Dovrai andare all’infermeria finché non arriverà il medico» dichiarò. «E ce ne metterà, di tempo, di domenica mattina.»
«Aspettare non è un problema per me.»
L’infermiera socchiuse gli occhi, sospettosa. Non era un’ingenua, e la reputazione di Agnes era nota a tutti. La ragazza si fece piccola nel letto spiegazzato.
«Avanti» disse Maggie. «In piedi. Ti accompagno.»
Agnes si lisciò la camicia da notte ingiallita, un capo di seconda mano con i fiocchi tutti sfilacciati, e si alzò tra mille precauzioni. Le ciabatte erano sotto il letto, le infilò e indossò la vestaglia lisa. Maggie, che era un donnone di quasi un metro e ottanta, aspettò con aria truce, poi prese Agnes per un gomito e la guidò tra i letti, lungo le scale e fuori attraverso il cortile. Il respiro di Agnes era una nuvoletta bianca nell’aria del mattino. Udì alcuni bambini che giocavano nell’erba dietro il muro che divideva i maschi dalle femmine, prima che la campana della nave suonasse. Il canto degli uccelli riempiva l’aria limpida del mattino, ma il sole non era ancora sorto da dietro gli edifici di pietra scura. Le piante dei piedi di Agnes si bagnarono di rugiada. Non aveva ricevuto ciabatte nuove all’inizio dell’inverno, per via della sua partenza imminente da Perdita Hall. L’infermiera la precedeva, ma Agnes non provò a raggiungerla. Se era in grado di camminare veloce quanto lei, stava abbastanza bene da andare a messa; il suo passo rapido era un modo per metterla alla prova, ne era certa.
L’infermeria si trovava sul retro dell’edificio principale di Perdita Hall, lo stesso che ospitava l’ufficio del capitano Forest. L’infermiera aspettò Agnes davanti alle grandi porte doppie, poi le chiuse alle sue spalle. Dietro la scala, giù nel seminterrato semibuio, poi in fondo al corridoio tinteggiato con acqua di calce fino all’infermeria, con il soffitto basso, scuro. Furono accolte da un odore freddo, di lievito.
C’era un altro bambino, un ragazzino di dodici anni circa con una tosse grassa.
Maggie accompagnò Agnes a un letto all’estremità opposta della corsia e le ordinò di non muoversi, avrebbero mandato a chiamare il medico appena fosse finita la messa.
«Adesso vado nella cappella» disse, passando dal bambino e rimboccandogli le coperte. «Sarò di ritorno tra un’ora.»
Agnes annuì, poi rimase immobile, in ascolto. Passarono dieci minuti. Venti. La tosse del bambino non cessava, ma in un momento di pausa, in cui trasse un respiro, riuscì vagamente a sentirla: la campana della nave nella cappella. Cominciava la messa.
E c’erano tutti, a parte il bambino malato e Agnes.
Spinse via la coperta ruvida.
Il bambino la guardò con gli occhi cerchiati di rosso. «Cosa fai?»
«Zitto. Se dici qualcosa, finirai nei guai.»
Ebbe un altro attacco di tosse, e Agnes si sentì in colpa. Era solo un bambino, malato per giunta, e lei era combattuta: da una parte sperava che l’infermiera tornasse presto per occuparsi di lui, dall’altra che stesse lontana abbastanza a lungo da permetterle di trovare ciò che cercava. Il fatto che concepisse idee del genere proprio di domenica, invece di pregare nella cappella, raddoppiò il senso di colpa. «Scusa, Dio» borbottò, e corse via dall’infermeria.
Si fermò ad ascoltare in cima alle scale. Il ticchettio dell’immenso orologio a pendolo nell’ingresso, ma nessun altro suono. Spuntò da dietro le scale e salì verso gli uffici. Un passo per volta, tutto il corpo in tensione, con il terrore di essere scoperta. Una volta giunta nel corridoio in penombra, si concesse un respiro. C’erano diversi nascondigli, da quelle parti, se qualcuno fosse tornato prima del previsto dalla cappella.
Agnes si avvicinò all’ufficio del capitano Forest per la seconda volta nel giro di una settimana. Stavolta aveva il batticuore. Se fosse stata sorpresa a curiosare in un posto dove non doveva essere, in camicia da notte e ciabatte, avrebbero potuto toglierle le referenze o rifiutare di darle il denaro per il viaggio. Aprì la porta e scivolò dentro, poi si chiuse silenziosamente l’uscio alle spalle. Era entrata. Un’ondata di eccitazione la sommerse. La stanza profumava di cera di limone e dell’olio di Macassar che il capitano si metteva sui capelli. Si guardò attorno: vetrine e armadietti, tutti lucidati alla perfezione. Aprì il più vicino, accanto alla scrivania, e trovò solo carte. Poi provò con i cassetti sotto la finestra. Quello superiore cigolò tanto forte al momento di aprirsi che Agnes era sicura che qualcuno avesse sentito. Si raddrizzò, con il cuore che batteva forte. Che scusa poteva trovare se fosse stata sorpresa a frugare tra cose non sue, in un luogo dove le era vietato entrare, dopo avere mentito dicendo di star male per non andare in chiesa? Come spiegare a qualcun altro lo strano, folle impulso che l’aveva spinta a comportarsi in quel modo? Dopotutto, se avesse trovato il bottone con l’unicorno, forse non sarebbe stato per niente simile a quello che ricordava…
Ma passò un minuto e non arrivò nessuno. Riportò l’attenzione sul cassetto. Vi erano state ricavate delle separazioni di legno, e ogni casella conteneva degli oggetti. C’erano tantissimi quadratini… Dove poteva essere il bottone con l’unicorno? Cominciò a spostarli con le dita, poi notò che ogni casella aveva un foglietto con un anno scritto sopra. 1874. 1873. 1872… Passò in rassegna i cartoncini, poi capì che doveva passare al cassetto inferiore.
1859, 1858… e infine eccolo. 1855. L’anno in cui era arrivata. Nella casella di legno c’era una decina di oggetti. Lo vide quasi subito.
Prese il bottone con l’unicorno con dita tremanti.
Era esattamente come lo ricordava.
Agnes aveva dieci anni, ed era il terzo giorno della sua prima settimana in lavanderia. Mrs Watford aveva dichiarato che dieci ore al giorno in mezzo al vapore l’avrebbero resa più obbediente, ma nel giro di una giornata Mrs Robbins aveva notato la qualità del suo lavoro con l’ago e l’aveva trasferita
nella stanza da cucito. Aveva dovuto ugualmente imparare a strofinare, sciacquare, strizzare, scuotere e appendere, ma per la maggior parte il suo lavoro era piacevole e avveniva all’asciutto.
Era stato allora che era arrivato il cesto. Consegnato da un uomo alto e curvo che aveva detto di essere al servizio di Breckby Manor, l’immenso castello sulla collina che dominava Hatby appartenente a Lord Caspian Breckby.
«Ho dei vestiti di seconda mano della figlia di sua signoria» aveva detto, posando il cesto sulla lunga panca dove si piegavano gli abiti. «Miss Genevieve chiede che vengano dati in beneficienza. Forse a qualcuna di queste ragazze possono andar bene.»
Ad Agnes era stato chiesto di fissare tutti i bottoni e i ganci, di riparare gli strappi e di rinforzare le cuciture che si erano allentate. Ricordava Genevieve dal loro incontro, ed era emozionata al pensiero di lavorare sui suoi indumenti, anche se erano abiti smessi. Le era capitata in mano per prima una giacca da cavallerizza. Agnes non era mai salita a cavallo, ma per lei quegli animali erano un simbolo di grande libertà. Lei e Gracie inventavano storie a letto, la sera, in cui branchi di cavalli selvaggi sfondavano i cancelli di Perdita Hall, e solo loro due riuscivano a domarli. La fantasia terminava sempre con loro che fuggivano per la brughiera in groppa a cavalli senza sella, sentendosi in comunione con la notte e le nubi che correvano davanti alla luna. Ma sulla giacca aveva visto qualcosa di ancora più incantevole dei cavalli: bottoni rossi tondi, con un unicorno dorato che si impennava. Un cavallo con una spada in fronte! Mentre fissava ogni bottone con il filo, Agnes si era messa a fantasticare: immaginava di indossare quella giacca dal vitino stretto sulla camicia da notte e di aprirsi un varco, seminando morte, per andarsene definitivamente da Perdita Hall.
Mancava un bottone con l’unicorno dal polsino, e Mrs Robbins le aveva detto di attaccarne uno diverso. Dopo quella volta, non aveva mai più visto la giacca. Nessuno di quegli abiti era andato alle ragazze di Perdita: avrebbero causato gelosie e litigi. Mrs Robbins li aveva venduti e il denaro se l’era intascato il capitano Forest, come tutto il denaro guadagnato dai trovatelli, per contribuire al loro mantenimento. Ma Agnes non aveva mai dimenticato i bottoni, perfettamente identici a quello che teneva ora in mano, e che avrebbe potuto svelare il segreto della sua origine. Quale altra conclusione doveva trarne? Doveva essere per forza la figlia illegittima della nobile, bella e ribelle Genevieve Breckby.
«Sei sicura che sia la cosa giusta da fare?»
Agnes lanciò un’occhiata a Gracie. Era lunedì sera, e avevano chiesto il permesso di fare una passeggiata fuori della proprietà, per andare a Hatby a informarsi sugli orari della diligenza in previsione della partenza di Agnes, due giorni dopo. Come se Agnes non li conoscesse già a memoria da tempo… Il vero obiettivo era imboccare il sentiero che attraversava il bosco di platani e il cimitero, e giungeva a Breckby Manor.
«Più che sicura» dichiarò Agnes, guidando Gracie perché evitasse una pozzanghera. La sua amica era cieca da un occhio, e inciampava sempre. Il bosco era buio e silenzioso, si udivano solo gli uccelli che saltavano sui rami e gli animaletti che si muovevano nella vegetazione bassa. «Miss Candlewick è morta due anni fa, quindi a lei non posso chiederlo. Dovrò rivolgermi direttamente alla fonte. Non lo faresti anche tu, Gracie?»
«Non lo so» rispose l’amica incerta, infilandosi un ricciolo rosso sotto la cuffia.
Le parole e le azioni di Gracie erano sempre dominate dall’insicurezza. Aveva un cuore tanto buono da riuscire sempre a vedere le cose dalla prospettiva degli altri, anche quando erano persone orribili. D’altra parte, non sapeva mai con certezza cosa pensava o provava lei, e non riusciva a decidere chi amare e chi odiare.
Agnes le prese la mano. «Cosa devo fare, se non andare a trovarla, guardarla in faccia e dirle che sono sua figlia?»
Gracie la fissò con l’occhio buono. L’altro guardava a sinistra. «Non ammetterà che sei sua figlia. Ti ha abbandonata, ricordi?»
Agnes bloccò l’ondata di dolore provocata da quella frase, e ripresero a camminare. «Mi ha lasciato il bottone, e ha mandato la giacca da cavallerizza a Perdita. Stava senz’altro cercando di dirmi chi era. Forse non voleva abbandonarmi. Forse non aveva scelta.»
«Una volta l’ho vista, in paese» disse Gracie. «Mi sembrava il tipo di donna capace di prendere decisioni.»
Gracie aveva ragione. «Anch’io l’ho vista, una volta» disse Agnes, e le parole le uscirono più nostalgiche di quanto avrebbe voluto.
«Era graziosa. Intendo dire… faceva colpo.»
Gracie aveva ragione: Genevieve Breckby aveva un modo di fare autoritario, era attraente e sembrava quasi una statua romana che avesse preso vita. Anche se Genevieve le aveva rivolto la parola solo quella volta, Agnes l’aveva vista in paese in altre due occasioni da bambina. La donna l’aveva colpita molto, anche per via delle voci che la dicevano cocciuta, mordace, e sempre desiderosa di sfuggire ai tentativi, da parte del padre e del marito, di controllarla. Erano state queste storie ad accendere l’immaginazione di Agnes. Non voleva una madre per baci e carezze, aveva accettato da tempo quella privazione. Nessuno poteva crescere a Perdita Hall senza avere un cuore un po’ diverso dagli altri, e l’amore era qualcosa che non si aspettava più e che non capiva. Neanche l’idea che fosse imparentata con una famiglia nobile, e quindi non destinata a una vita di stenti e povertà, aveva il potere di esaltarla quanto il pensiero che il desiderio di libertà, che aveva sempre avvertito dentro di sé, quasi alimentato da un motore potente, fosse un tratto ereditario. Che ci potesse essere un’altra donna al mondo il cui cuore conosceva il suo, le cui passioni riconoscevano le sue.
Che non fosse del tutto sola.
In realtà Agnes non sapeva neppure se Genevieve vivesse ancora a Breckby Manor. Aveva sentito parlare della fine scandalosa di un matrimonio, e non la vedeva da molti anni. Ma non poteva andarsene da Hatby senza avere almeno provato a scoprire la verità. Lasciò andare la mano di Gracie per aprire il cancello della chiesa e attraversarono il cimitero, sotto i rami bassi.
A quel punto, Gracie si fermò. «Da qui in poi dovrai andare da sola» disse, sedendosi sul bordo di pietra di un’aiuola, sistemandosi le falde della sottana grigia.
Agnes le si accovacciò di fronte, prendendole le mani. «Grazie, mia cara amica. Non ti farò aspettare troppo.»
«Prenditi tutto il tempo che ti serve» disse Gracie. «Starò bene qui, con il vento e i rami.» Sorrise. «Immagina, Agnes, se tra due anni, quando toccherà a me andarmene, trovo la stessa cosa scritta sui miei documenti. Bottone con l’unicorno. Potremmo essere sorelle.»
Agnes non le fece notare che non avrebbero mai potuto essere sorelle, essendo troppo diverse perché potesse esistere un qualsivoglia legame biologico tra loro; ma Gracie era una sorella in un altro senso. Aveva benvoluto e ascoltato Agnes anche quando tutti gli altri l’avevano presa in giro o punita; e Agnes adorava Gracie e la proteggeva.
Agnes si alzò, si lisciò l’abito e uscì decisa dal cimitero, imboccando il sentiero verso Breckby Manor.
L’imponente cancello d’ingresso era chiuso, e Agnes sperava di non doverlo scavalcare; non sarebbe stato il modo migliore per presentarsi alla famiglia che ritrovava dopo tanto tempo. Infilò la mano tra le sbarre, sollevò il chiavistello e si avvide che non era chiuso. Spinse il cancello che cigolò rumorosamente. Un istante dopo, due cani enormi le corsero incontro. Rimase immobile, pronta a precipitarsi fuori, ma i bestioni scodinzolavano e avevano la lingua penzoloni. Si chinò a coccolarli. Uno di loro si sdraiò pancia all’aria, e lei gli carezzò la pancia.
Mentre faceva le feste ai cani, sollevò gli occhi e si guardò attorno. Vide un ampio viale che passava davanti alla casa e poi biforcava dirigendosi alle scuderie. Il giardino circolare era pieno di fiori variopinti e alberi perfettamente curati. Agnes attraversò il giardino affiancata dai cani. Vide piccole croci accanto al laghetto, sotto un salice sottile. Recavano scritti i nomi di animali domestici venuti a mancare: Persimmon, Xerxes, Fluff, Calico. Sentì scricchiolare sotto i piedi la terra battuta della strada, poi salì i quattro scalini ampi di pietra fino al portico e, infine, suonò il campanello di ottone accanto alla porta. I cani, addestrati alla perfezione, non salirono le scale.
Agnes aspettò. Una nube oscurò il cielo.
La porta si aprì, e apparve un maggiordomo anziano e sorridente. «Posso aiutarvi, signorina?»
«Vorrei vedere Genevieve.» Si rese conto che avrebbe dovuto usare il più formale «Miss Breckby», ma ormai aveva il nome di sua madre in testa.
Il sorriso dell’uomo si trasformò immediatamente in una smorfia. «E voi chi sareste?»
«Mi chiamo Agnes Resolute. Vengo da Perdita Hall. E devo parlare con Genevieve, è importante.»
Si spostò per chiudersi la porta alle spalle, ma Agnes riuscì ugualmente a intravedere un ingresso enorme, con una domestica che spolverava una fila di ritratti imponenti. «La più giovane Miss Breckby non abita più qui, signorina.»
Agnes si sentì morire. Sapeva che c’era quella possibilità, ma la conferma le tolse le forze. «Dove vive, allora? Devo trovarla.»
«Non intendo certo dire a una trovatella dov’è o dove non è un membro della famiglia Breckby. I loro spostamenti non sono affari vostri. Buona giornata.»
Fece per tornare in casa, ma lei lo afferrò per una manica. «Vi prego» disse. «Devo trovarla.»
«Buona giornata, signorina. Se non ve ne andate subito, farò sapere al capitano Forest di queste… molestie.» Si liberò della sua presa, e lei fece un passo indietro e lo lasciò andare.
Maledizione.
Agnes si voltò e scese le scale, attraversò il giardino e oltrepassò il cancello. Era sconvolta e le tremavano le mani. Ma non avrebbe pianto. Le lacrime erano per i deboli. Lei aveva sopportato una vita di delusioni, non sarebbe certo stata quella ad abbatterla.
Gracie balzò in piedi quando Agnes entrò nel camposanto.
«Vedo dalla tua faccia che non è andata bene» disse.
«Già. Per niente bene.»
«Ma non preoccuparti. Ho riflettuto. Ricordi Cole Briar, no?»
Agnes fissò Gracie. Perché le parlava di Cole Briar? Il giorno in cui se n’era andato da Perdita Hall era stato uno dei più belli della sua vita. Aveva perso il conto delle volte in cui era andato a cercarla nei giardini dietro la chiesa per provare a baciarla o metterle le mani addosso. Ogni volta che Agnes si era lagnata con Mrs Watford, questa le aveva detto che, se fosse rimasta nel dormitorio invece di andarsene in giro per il giardino, non avrebbe avuto problemi del genere. «Sì, me lo ricordo, quel villanzone. Cosa c’entra lui?»
«Lavorava per i Breckby. Forse lui sa qualcosa.»
«Preferirei baciare un’anguilla anziché chiedere il suo aiuto.» Ma mentre lo diceva, Agnes aveva già cambiato idea. Cole non se n’era mai andato da Hatby. Lavorava per lo stivalaio, e se sapeva qualcosa Agnes non avrebbe avuto difficoltà a farselo dire.
«Agnes?» la chiamò Gracie, dopo che l’amica fu rimasta in silenzio per un po’.
«E va bene.» Agnes prese Gracie a braccetto. «Vieni con me. Da sola non ci vado.»
La via principale di Hatby era una strada dritta e triste, costeggiata da edifici di pietra grigia. A parte un carretto con il cavallo davanti all’ufficio postale, e una coppia anziana che guardava la vetrina di una modista, Agnes e Gracie erano le uniche persone in giro. Le ombre si allungavano davanti a loro mentre si dirigevano verso Tucker, lo stivalaio. La bottega era stretta, infilata tra il fabbricante di candele e un negozio vuoto che un tempo era stato una sala da tè. Agnes spinse la porta, con Gracie che la seguiva. Il negozio odorava di cuoio e polvere. Dietro il banco, in un angolo, era seduto Cole Briar. Strumenti e varie strisce di pelle pendevano dalle pareti tutt’attorno. Era chino su uno stivale, e stava ripiegando il cuoio con un arnese.
«Cole» disse Agnes.
Il ragazzo alzò lo sguardo. Aveva il naso aquilino e la pelle unta, e i capelli lunghi e lisci gli ricadevano ai due lati del viso. Quando vide Agnes, fece un sorriso. «Guarda un po’ chi si vede. Agnes Resolute.»
«E Gracie Badger» aggiunse Gracie.
Cole la ignorò, posò lo stivale e andò loro incontro. «E così siete in paese e cercate Cole Briar, eh? È forse il mio giorno fortunato?»
Agnes cercò di tenere a freno l’irritazione, e fece un sorriso dolce. «Sì, Cole. Può darsi.»
«Dimmi tutto.» Era alto una spanna più di lei, e le si avvicinò tanto da far sentire ad Agnes l’odore stantio dei suoi abiti.
«Tu hai lavorato per i Breckby, vero?»
«Sì. Durante gli ultimi tre anni a Perdita ho fatto il lacchè da loro. Quella casa è tanto grande che ci si perde.»
«Hai mai sentito parlare di Genevieve? Dov’è andata?»
La fissò per un istante con gli occhi attenti. Si capiva che stava pensando a come rispondere. «Perché lo vuoi sapere?»
«Non puoi dirmelo e basta?»
«No, che non posso. Devo sapere che cosa ci guadagno.»
Gracie si strinse ad Agnes.
«Sai davvero qualcosa o stai solo fingendo?» chiese Agnes con aria di sfida. «Perché ti avviso, Cole Briar, finisci male se non mi dici la verità.»
Lui spostò il peso da un piede all’altro, ma restò in silenzio. Infine parlò: «So qualcosa. Ero io che andavo a prendere la posta»
Agnes si sentì rinascere. «Davvero?»
«Sì. Quindi ora ti chiedo di nuovo: cosa ci guadagno?»
«Puoi avere un bacio.»
Lui si sporse ma lei fece un passo indietro, facendo quasi cadere Gracie. «Non ancora. Solo quando mi avrai detto qualcosa.»
«Facciamo così. Un bacio piccolo per farmi parlare, e uno più lungo quando ti avrò dato il suo indirizzo.» Sottolineò l’ultima parola sollevando le sopracciglia.
Il suo indirizzo? Per quello sarebbe stata disposta a baciare anche un’anguilla. Sollevò il viso, lui si protese e premette forte le labbra contro le sue. Agnes aspettò un secondo, due, poi si ritrasse. «Bene. Cosa sai?»
«Genevieve è andata a vivere a Londra con sua sorella Marianna. Me l’ha detto la governante. Prendevo le lettere di Marianna ogni giovedì all’ufficio postale. Belgrave Place, Londra. Adesso il bacio lungo. Ti dirò il numero della casa quando avremo finito.»
Agnes lanciò un’occhiata a Gracie, che sembrava perplessa e affascinata insieme.
«Avanti» disse Gracie. «Hai promesso.»
Agnes fece un passo avanti, permettendo a Cole di cingerle i fianchi. Poi il ragazzo chinò il capo e la baciò con forza, aprendole le labbra con la lingua ed esplorandole la bocca senza nessuno scrupolo. Lei strinse forte gli occhi e pensò ad altro. A Londra. A sua madre. Al bottone con l’unicorno. Le mani di Cole le scesero lungo i fianchi, e stava per toccarle il fondoschiena quando lei si divincolò e fece un balzo indietro.
«Basta. Non ti ho dato il permesso per quello.»
Lui rise. «Non puoi volermene se ci ho provato, Agnes Resolute. Sei sempre stata in cima alla mia lista.» Strizzò l’occhio a Gracie e questa gli fece un sorriso innocente.
«Già. Numero della casa?»
Cole le diede l’indirizzo completo e le chiese un altro bacio, che lei gli rifiutò risentita. Infine si liberò dell’odore della bottega, tornando fuori nella strada fredda.
«Londra» mormorò Gracie. «Peccato che sia tanto lontana.»
Agnes si fermò e si girò a guardare l’amica. «La distanza non è importante. Devo andare» dichiarò.
Gracie la fissò sbalordita. «Che assurdità, Agnes. Non puoi permettertelo. Non puoi… non devi…»
«Userò parte del denaro che mi daranno per mantenermi il primo mese.» Agnes lanciò un’occhiata verso il negozio dello stivalaio per assicurarsi che Cole non l’avesse seguita. «Gracie, Genevieve Breckby potrebbe essere mia madre.»
«Non posso fare nulla per fermarti?» chiese l’amica.
«Sai che non puoi fermarmi» rispose Agnes.
«Lo so» disse Gracie con un sorriso. «Nessuno è in grado di fermarti, quando ti viene in mente un’idea.»
Era un pomeriggio ventoso quando Agnes si trovò infine alla fermata della diligenza davanti all’ufficio postale di Hatby, pronta a iniziare la sua nuova vita. Gracie era con lei, e le stringeva la mano, mentre il baule di Agnes veniva caricato a bordo. Era patetico e minuscolo accanto ai bagagli enormi ed elaborati degli altri viaggiatori. Una donna non molto più vecchia di Agnes stava dando ordini con voce altera a uno dei domestici. Indossava un abito di seta color prugna con un grande fiocco sul sellino. Agnes guardò il proprio vestito. Ogni ragazza di Perdita, nei mesi precedenti la partenza, doveva confezionare l’abito con cui se ne sarebbe andata. Quel mattino, Agnes l’aveva finalmente indossato – era di un tessuto spesso grigio chiaro, abbellito da decorazioni di pizzo al collo e ai polsi fatte da Gracie – e aveva allacciato tutti i ganci e i bottoni, e stretto la fettuccia che regolava l’altezza del piccolo sellino. Si trovava molto elegante, ma sapeva che rispetto a quella donna tutta la sua eleganza scompariva. Al massimo, si poteva dire che aveva un’aria dignitosa.
Agnes guardò il postiglione parlare ai passeggeri, uno per uno. Lei era l’ultima della fila. Tese la mano per prendere il foglietto con scritta la tariffa.
«York?» le chiese con voce brusca.
«La stazione. Vado a Londra.»
Lui sollevò il sopracciglio a cespuglio. «Londra, eh? Posso vendervi io stesso il biglietto del treno a un prezzo più basso. Londra è lontana. Vi faranno pagare quindici scellini se lo comprate alla stazione.»
Quindici scellini? Ne aveva venti in tutto, abbastanza per la diligenza fino a York e di che vivere per un mese. «Quanto costa se lo compro da voi?»
«Ve lo lascio per dodici. E vi vendo il tragitto in diligenza per due scellini e sei pence; a metà prezzo.»
Agnes fece i suoi calcoli e si sentì, di colpo, molto meno entusiasta. Sapeva che il treno era meno costoso della diligenza, ma naturalmente c’erano duecento miglia tra York e Londra. Era stata una stupida a pensare di poterselo permettere.
Guardò Gracie che scuoteva il capo avvilita, con l’occhio malato puntato a sinistra. «Non avrai i soldi per tornare se le cose vanno male. Forse Londra dovrà aspettare.»
Aspettare? Aveva aspettato tutta la vita che succedesse qualcosa. Forse quel qualcosa era questo.
«Lo prendo» disse al postiglione. Una volta trovata sua madre, non avrebbe avuto bisogno di denaro.
«Agnes…»
«Andrà tutto bene, Gracie. Vedrai.» Slacciò il cordoncino della borsetta che teneva al polso ed estrasse il denaro che mise in mano al cocchiere. Infilò nella borsa il biglietto del treno e la richiuse di scatto. Ormai era quasi vuota: conteneva solo poche monete, e il foglio di carta ripiegato che spiegava chi era e perché era sprovvista di un certificato di nascita.
«In carrozza» annunciò il cocchiere, andando a sedersi al suo posto.
Gracie stava mettendo qualcosa in mano ad Agnes. «Prendi» disse.
«Cos’è?» Era morbido e piccolo, avvolto in un vecchio giornale.
«Un regalo. E… ti potrebbe più che mai servire. Vendilo, se devi.»
«Non avresti dovuto farmi un regalo.» Agnes strinse Gracie in un abbraccio. «Ti voglio bene, amica mia.»
«Scrivimi» disse. «Appena arrivi.»
«Lo farò.» Poi Agnes salì in carrozza con le altre donne. Gli uomini si erano sistemati fuori. Si infilò tra la giovane con l’abito color prugna e una donna anziana che sembrava indignata all’idea di dover far posto ad Agnes. Allargò i gomiti con fare da prepotente, e Agnes cercò di immaginare cos’avrebbe fatto Genevieve se la passeggera si fosse comportata in modo tanto scortese con lei. Raddrizzò la schiena e non cedette, e sollevò anche il mento, già che c’era. Aveva dimenticato i lineamenti di Genevieve, ma ricordava la sua espressione altera.
I cavalli partirono e la diligenza si avviò tra gli scossoni. Guardò fuori del finestrino, i faggi e le querce che scivolavano via, poi lanciò un’occhiata al cancello di Perdita Hall, dietro rami e case. Si appoggiò allo schienale e chiuse gli occhi. Aveva il cuore in gola.
Ormai aveva deciso.
Aprì gli occhi e li posò sul pacchetto. Sciolse lo spago e tolse il foglio di giornale. La donna anziana le lanciò uno sguardo di sufficienza. Agnes estrasse il dono di Gracie, uno scialle di pizzo.
Gracie era la più brava merlettaia di Perdita Hall. Tanto era goffa nel camminare, tanto il suo unico occhio buono era abile nei lavori di precisione, e le mani ferme. Di solito i suoi lavori venivano venduti. Come era riuscita a tenere da parte quello? Agnes sorrise, pensando a Gracie che aveva tanta paura di finire nei guai, e che aveva nascosto quello scialle alla responsabile delle merlettaie, temendo di farsi scoprire, l’aveva avvolto nella carta e portato fuori del cancello. Le venne una stretta al cuore, immaginando Gracie da sola a Perdita Hall, senza Agnes a proteggerla e a leggerle i libri.
Agnes si giurò che non l’avrebbe venduto. Neanche se le cose si fossero messe male.
Se lo drappeggiò sulle spalle, toccando con i gomiti le altre passeggere. La donna con l’abito color prugna fece una smorfia di disapprovazione, ma ad Agnes non importava. Era pronta a scommettere che quella donna non possedesse niente di prezioso quanto il dono di Gracie, perché era stato fatto con amore.
La diligenza continuò ad avanzare rumorosamente, allontanandola dalla vita vecchia e portandola verso la sua nuova esistenza.
Capitolo 2
Erano le quattro del pomeriggio quando Agnes scese infine alla fermata a cento metri dalla stazione ferroviaria. Aspettò che il lacchè scaricasse il suo baule, e le mostrasse con un gesto della mano quale direzione imboccare.
La stazione era un vasto edificio di pietra calcarea e mattoni in Tanner Row. Percorse la banchina rumorosa, sotto la tettoia di metallo. Una locomotiva nera sibilante si trovava sul binario, con dietro una lunga fila di vagoni di legno, ed emanava un odore di carbone e lubrificante. C’era un mucchio di gente, che si trascinava dietro i bagagli e si diceva addio; bambini che ridevano e giocavano, adulti che li rimproveravano, personale che si muoveva zigzagando tra i viaggiatori per svolgere commissioni. Ogni cosa, attorno a lei, era coperta di un sottile strato di fuliggine. Un facchino le passò accanto di corsa e Agnes gli chiese: «Scusate, è questo il treno per Londra?»
L’uomo scosse il capo. «Edimburgo. Andate a chiedere in biglietteria.»
«Ma ce l’ho già, il biglietto.»
Era già scomparso tra la folla e non la udì, ma le aveva mostrato dove andare. Agnes si avviò da quella parte e aspettò in fila finché un signore anziano con i favoriti candidi e un basco nero non le chiese se la poteva aiutare. Lei pescò il biglietto dalla borsa e glielo mostrò. «Quando è il prossimo treno per Londra?»
«Tra venti minuti. Ma questo biglietto è per il treno dell’una.» Glielo restituì.
«L’una? Allora l’ho perso?» Si sentì morire.L’impiegato scosse il capo. «L’una di notte, signorina. Potrete salire a bordo tra otto ore.»
Ecco perché era costato poco. Provò una stretta di rabbia allo stomaco. L’uomo stava già spostando l’attenzione sulla donna alle sue spalle, vestita molto meglio di lei, così Agnes si fece in là e tornò sulla banchina con il suo piccolo baule, trovò da sedersi e restò a guardarsi in giro per un po’. Le campane della cattedrale suonarono i vespri, poi il suono si spense con il vento. Il flusso di gente che saliva e scendeva dai treni la ipnotizzava. Quando un convoglio partiva in una nuvola sibilante di vapore, si lasciava alle spalle vuoto e silenzio. Poi, però, qualche minuto dopo cominciava a radunarsi altra gente; tornava la pace, si udiva il fischio e un altro treno giungeva sulla banchina. E così via.
Nessuno di essi andava a Londra. Guardò l’orologio sopra la banchina. Erano quasi le sette, e le brontolava lo stomaco. Colse un movimento con la coda dell’occhio. Vide avvicinarsi il bigliettaio con due tazzina di porcellana. Curiosa, stette a guardarlo. Le porse una delle due tazze.
«Caffè?» chiese.
Agnes avrebbe preferito dell’arrosto, ma era pur sempre qualcosa con cui riempirsi lo stomaco. Prese la tazza e ringraziò.
«Allora, aspetterete fino all’arrivo del treno?»
«Non ho nessun altro posto dove andare.»
«Tra dieci minuti chiudo l’ufficio e vado a casa. Il guardiano notturno non arriverà prima di mezzanotte, quindi resterete da sola sulla banchina.»
Agnes rabbrividì.
«Attenta ai ladruncoli» la mise in guardia.
«Lo farò.» Si portò la tazza alle labbra, bevve un sorso, poi urtò con il gomito lo schienale del sedile e si rovesciò il caffè sul vestito. «Diamine!» esclamò, tappandosi subito la bocca con la mano. «Scusate, signore. Non dovrei ripagare la vostra generosità con questo linguaggio.»
Il bigliettaio ridacchiò e le tolse la tazza dalle mani. «Ne volete dell’altro?»
«No, grazie.» Il caffè era troppo forte, a stomaco vuoto.
«Vi lascio accesi i lampioni» disse l’uomo, e se ne andò. Poco dopo, udì una porta che si chiudeva e dei passi che si allontanavano.
Agnes si mise ad aspettare. Passò un’ora. Un’altra. Non riusciva più a star seduta dritta. Si coricò sulla panchina, posando la testa sulla borsa come fosse un cuscino. Aveva imparato a Perdita a dormire su ciò che aveva di più prezioso per non farselo rubare. Il legno duro le premeva contro i fianchi, ed era impossibile trovare una posizione comoda. Aspettò. Un vento freddo soffiava lungo le rotaie, sollevando mulinelli di fuliggine.
Aveva appena cominciato ad assopirsi quando udì dei passi. Si riscosse subito e si rizzò a sedere. In fondo alla banchina vide un uomo, che si stagliava contro la luce dei lampioni a gas. Agnes si chiese se fosse la guardia notturna, ma non portava l’uniforme. Cominciò a camminare lungo la banchina, dieci metri, venti, ma cambiò senso di marcia prima di avvicinarsi troppo. Vide che aveva con sé una piccola borsa da viaggio ricavata da un tappeto, e immaginò che aspettasse il suo stesso treno. Indossava un cilindro, un cappotto di buon taglio, e guanti di pelle marrone. Al giro successivo lungo la banchina le sorrise.
Agnes non poté evitare di sorridergli di rimando. Aveva un viso bello, un’espressione buona. Non si avvicinò, e Agnes si rilassò. Con un uomo nei paraggi, non avrebbe dovuto preoccuparsi dei malintenzionati contro i quali l’aveva messa in guardia il bigliettaio.
Ricominciò ad appisolarsi, e siccome l’uomo era tornato al capo opposto della banchina, apparentemente ben deciso a non darle fastidio, posò di nuovo la testa e chiuse gli occhi. Il tempo avanzò lento. Si addormentò. Era di nuovo a Perdita Hall. Udiva Gracie dall’altro capo del muro di cinta e sapeva di doverla raggiungere. Cominciò ad arrampicarsi, ma diventava sempre più alto, fino a diventare una costruzione altissima e vacillante. Vi si aggrappò con le dita, ma erano fredde, soffiava il vento, e si sentì precipitare…