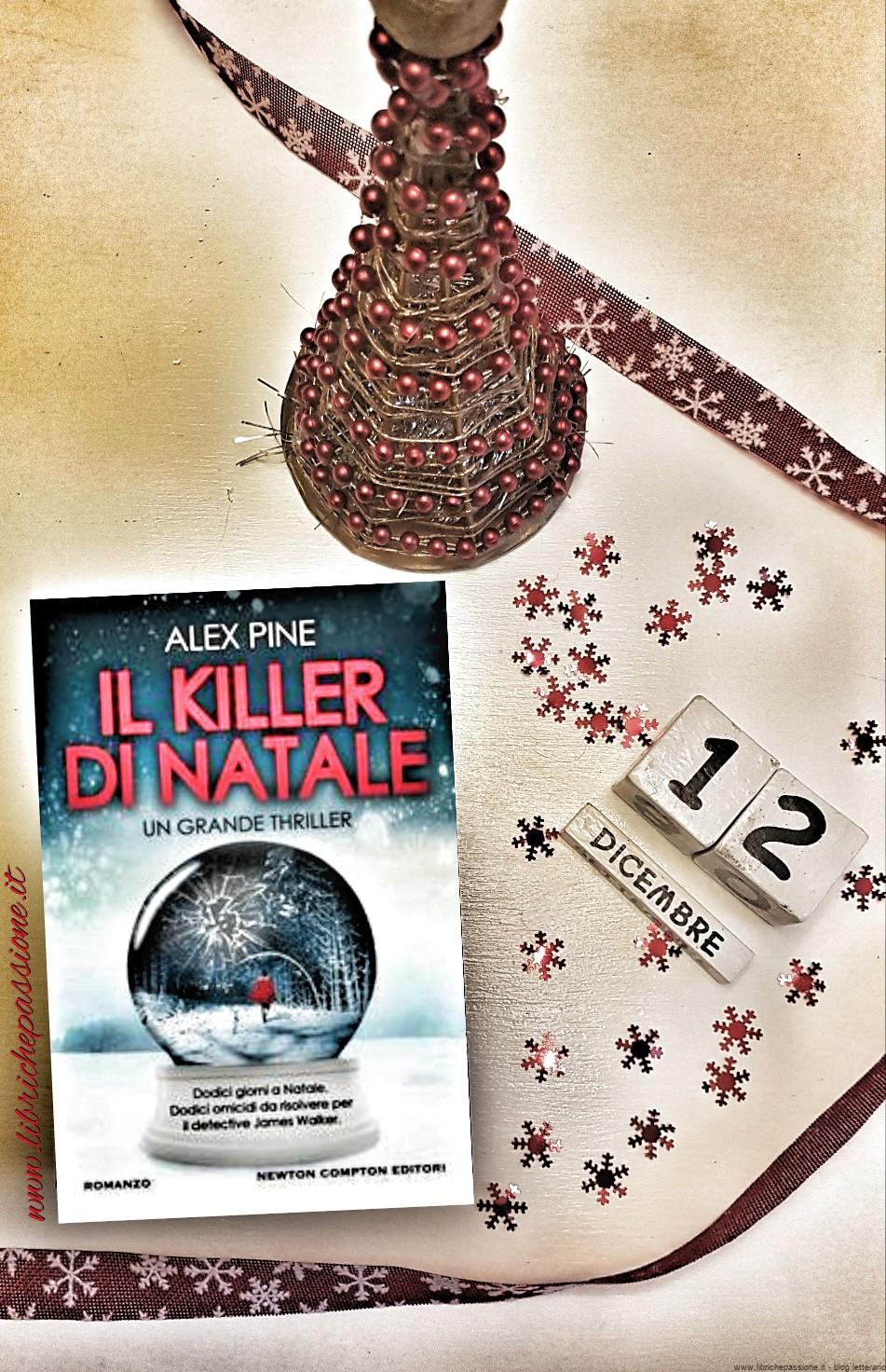Trama
Il nuovo geniale romanzo del maestro italiano del thriller.
Gli estranei sono il pericolo. Fidati soltanto di mamma e papà.
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l’ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l’addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall’altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un’adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è un’illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un’adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto . Forse l’assassina è proprio lei.
Estratto
Ad Antonio.
Mio figlio, la mia memoria, la mia identità.
23 febbraio
Una carezza nel sonno.
Nel nebbioso confine con la veglia, un attimo prima di precipitare nell’abisso dell’oblio, il tocco leggero di dita gelide e sottili sulla fronte, accompagnato da un triste e dolcissimo sussurro.
Il suo nome.
Sentendosi chiamare, la bambina sbarrò gli occhi. Ed ebbe subito paura. Qualcuno era venuto a farle visita mentre si addormentava. Poteva essere uno dei vecchi abitanti della casa, a volte chiacchierava con loro o li sentiva muoversi come i topi, rasentando i muri.
Ma gli spettri parlavano dentro, non fuori di lei.
Anche Ado – il povero Ado, il malinconico Ado – veniva a trovarla. Però, a differenza di tutti gli altri spiriti, Ado non parlava mai. Perciò a turbarla adesso era un pensiero più concreto.
A parte mamma e papà, nessuno conosceva il suo nome nel mondo dei viventi.
Era la «regola numero tre».
L’idea di aver violato una delle cinque raccomandazioni dei suoi genitori l’atterriva. Si erano sempre fidati di lei, non voleva deluderli. Non proprio ora che papà le aveva promesso di insegnarle a cacciare con l’arco e che anche la mamma si era convinta. Ma poi rifletté: come poteva essere stata colpa sua?
Regola numero tre: non dire mai il tuo nome agli estranei.
Non aveva detto il suo nuovo nome agli estranei, né era possibile che qualcuno di loro l’avesse appreso per sbaglio. Anche perché erano almeno un paio di mesi che non vedevano qualcuno aggirarsi nei paraggi del casale. Erano isolati in mezzo al nulla della campagna, la città più vicina distava due giorni di cammino.
Erano al sicuro. Solo loro tre.
Regola numero quattro: non avvicinarti mai agli estranei e non lasciarti avvicinare da loro.
Allora com’era stato possibile? Era stata la casa a chiamarla, non c’era altra spiegazione. A volte, le travi producevano sinistri scricchiolii o gemiti musicali. Papà diceva che il casale si assestava sulle fondamenta come una signora attempata seduta in poltrona che ogni tanto sente il bisogno di mettersi più comoda. Nel dormiveglia, uno di quei rumori le era sembrato il suono del suo nome. Tutto qui.
La sua anima inquieta si placò. Richiuse gli occhi. Il sonno, col suo silenzioso richiamo, la invitava a seguirla nel posticino caldo dove tutto si dissolve.
Stava per abbandonarsi, quando qualcuno la chiamò di nuovo.
Stavolta la bambina si tirò su dal cuscino e, senza scendere dal letto, scandagliò il buio nella stanza. La stufa in corridoio era spenta da ore. Oltre le coperte, il freddo assediava il suo giaciglio. Adesso era perfettamente vigile.
Chiunque fosse stato a invocarla non era in casa, era là fuori, nella notte buia dell’inverno.
Aveva parlato con il verso degli spifferi che si insinuano sotto le porte o fra le persiane chiuse. Ma il silenzio era troppo profondo e lei non riusciva a scorgere altro suono, con il cuore che le sbatacchiava nelle orecchie come un pesce dentro un secchio.
«Chi sei?» avrebbe voluto domandare alla tenebra. Ma temeva la risposta. O forse la conosceva già.
Regola numero cinque: se un estraneo ti chiama per nome, scappa.
Si alzò dal letto. Ma, prima di muoversi, cercò a tentoni la bambola di pezza con un occhio solo che dormiva insieme a lei e l’afferrò per portarla con sé. Senza accendere il lume sul comodino, si avventurò cieca nella stanza. I suoi piccoli passi scalzi risuonarono sul pavimento di legno.
Doveva avvertire mamma e papà.
Uscì in corridoio. Dalla scala che conduceva al piano di sotto risaliva l’odore del fuoco che si consumava lentamente nel camino. Immaginò il tavolo di ulivo in cucina, ancora imbandito coi resti della festicciola della sera prima. La torta di pane e zucchero preparata dalla mamma nel forno a legna e a cui mancavano tre fette esatte. Le dieci candeline che aveva spento con un unico soffio, seduta sulle ginocchia di papà.
Mentre si avvicinava alla camera dei genitori, i pensieri felici evaporarono lasciando il posto a cupi presagi.
Regola numero due: gli estranei sono il pericolo.
L’aveva visto coi suoi occhi: gli estranei prendevano le persone, le portavano via dai loro cari. Nessuno sapeva dove andavano a finire, né cosa ne fosse di loro. O forse era ancora troppo piccola, non era ancora pronta, così nessuno gliel’aveva mai voluto raccontare. L’unica certezza che aveva era che quelle persone non tornavano più indietro.
Mai più.
«Papà, mamma… C’è qualcuno fuori dalla casa» bisbigliò, ma con la sicurezza di chi non vuole essere più considerata soltanto una bambina.
Papà si svegliò per primo, un attimo dopo anche la mamma. E la bambina ebbe subito tutta la loro attenzione.
«Cos’hai sentito?» domandò la mamma, mentre papà impugnava la torcia elettrica che teneva sempre pronta accanto al letto.
«Il mio nome» rispose la bambina, titubante, temendo un rimprovero perché era stata violata una delle cinque regole.
Ma nessuno le disse niente. Papà accese la torcia, schermando il fascio con la mano in modo che rischiarasse appena il buio nella stanza, così gli intrusi non avrebbero capito che erano svegli.
I genitori non le chiesero altro. Si stavano domandando se crederle oppure no. Ma non perché sospettassero che avesse detto una bugia, sapevano che non avrebbe mai mentito su una cosa del genere. Dovevano soltanto stabilire se ciò che aveva raccontato era reale oppure no. La bambina avrebbe tanto voluto che si trattasse solo della sua fantasia.
Mamma e papà erano all’erta. Però non si mossero. Rimasero in silenzio, con il capo leggermente sollevato, ad auscultare l’oscurità – come i radiotelescopi del suo libro di astronomia, che scrutano l’ignoto che si nasconde nel cielo, sperando ma anche temendo di cogliere un segnale. Perché, come le aveva spiegato suo padre, scoprire di non essere soli nell’universo non sarebbe stata per forza una buona notizia: «Gli alieni potrebbero anche non essere amichevoli».
Scorrevano interminabili secondi di quiete assoluta. Gli unici rumori erano il vento che agitava le chiome degli alberi secchi, il pianto lamentoso della banderuola di ferro arrugginito sul comignolo e i brontolii del vecchio fienile – come una balena che dorme in fondo all’oceano.
Un suono metallico.
Un secchio che cade per terra. Il secchio del vecchio pozzo, per l’esattezza. Papà l’aveva legato fra due cipressi. Era una delle trappole sonore che sistemava tutte le sere intorno alla casa.
Il secchio era collocato vicino al pollaio.
Lei stava per dire qualcosa ma, prima che potesse farlo, la mamma le posò una mano sulla bocca. Avrebbe voluto suggerire che forse si trattava di un animale notturno – una faina o una volpe – non per forza di un estraneo.
«I cani» sussurrò il padre.
Le venne in mente soltanto ora. Papà aveva ragione. Se fosse stata una volpe o una faina, dopo il rumore del secchio caduto i loro cani da guardia ne avrebbero certamente segnalato la presenza, mettendosi ad abbaiare. Se non l’avevano fatto, c’era solo una spiegazione.
Qualcuno li aveva messi a tacere.
Al pensiero che potesse essere accaduto qualcosa di brutto ai suoi amici pelosi, lacrime calde le ribollirono negli occhi. Si sforzò di non mettersi a piangere, il dispiacere si mischiò a un’improvvisa ondata di terrore.
Ai suoi genitori fu sufficiente scambiarsi uno sguardo. Sapevano esattamente cosa fare.
Papà scese per primo dal letto. Si rivestì in fretta, ma senza mettersi le scarpe. Mamma lo imitò, ma fece anche qualcosa che lasciò per un attimo interdetta la bambina: le parve che aspettasse il momento in cui papà non poteva notarla, poi la vide infilare una mano sotto il materasso, prendere un piccolo oggetto e metterselo rapidamente in tasca. La bambina non fece in tempo a capire cosa fosse.
Le sembrò strano. Mamma e papà non avevano segreti.
Prima che lei potesse domandarle qualcosa, la mamma le affidò una seconda torcia e le si inginocchiò davanti mettendole una coperta sulle spalle.
«Ricordi cosa dobbiamo fare adesso?» domandò, fissandola bene negli occhi.
La bambina annuì. Lo sguardo deciso della mamma le diede coraggio. Da quando si erano trasferiti nel casale abbandonato, all’incirca un anno prima, avevano provato decine di volte la procedura: così la chiamava papà. Fino ad allora, non c’era mai stato bisogno di metterla in atto.
«Tieni stretta la tua bambola» le raccomandò la madre, poi prese la sua piccola mano nella propria, calda e forte, e la portò via.
Mentre scendevano le scale, la bambina si voltò un attimo e vide che il padre aveva preso una delle taniche dal ripostiglio e adesso ne stava spargendo il contenuto lungo i muri del piano superiore. Il liquido colava attraverso le assi del pavimento e aveva un odore pungente.
Arrivati al piano inferiore, mamma la trascinò con sé verso le stanze sul retro. I piedi scalzi raccoglievano schegge di legno, la bambina teneva le labbra serrate cercando di trattenere i gemiti di dolore. Ma era comunque inutile, non avevano più bisogno di nascondere la loro presenza. Là fuori, gli estranei avevano capito tutto.
Li sentiva muoversi intorno alla casa, volevano entrare.
Era già accaduto in passato che qualcosa o qualcuno venisse a minacciarli nel posto in cui credevano di essere al sicuro. Alla fine, erano sempre riusciti a sventare il pericolo.
Lei e la mamma passarono accanto al tavolo di ulivo, alla torta di compleanno con le dieci candeline spente. Alla tazza smaltata del latte con cui l’indomani avrebbe dovuto fare colazione, ai giocattoli di legno che suo padre aveva costruito per lei, al barattolo coi biscotti, ai ripiani con i libri che leggevano insieme ogni sera dopo cena. Tutte cose a cui avrebbe dovuto dire addio, ancora una volta.
La mamma si avvicinò al camino di pietra. Infilò un braccio nella canna fumaria, andando in cerca di qualcosa. Finalmente trovò l’estremità di una catena di ferro annerita di fuliggine. Iniziò a tirarla a sé con tutta la forza, facendola scorrere intorno a una carrucola nascosta nel comignolo. Una delle lastre di arenaria sotto la brace iniziò a spostarsi. Ma era troppo pesante, c’era bisogno anche di papà. Era stato lui a inventare quel marchingegno. Perché ci metteva così tanto a raggiungerle? Quell’imprevisto le mise ancora più paura.
«Aiutami» le ordinò la mamma.
Afferrò la catena e tirarono insieme. Nella foga, la madre urtò con un gomito un vaso di creta sulla mensola del camino. Lo videro schiantarsi al suolo, impotenti. Un suono sordo corse fra le stanze del casale. Un istante dopo, qualcuno iniziò a bussare forte sulla porta d’ingresso. Quei colpi risuonarono fino a loro come un ammonimento.
Sappiamo che ci siete. Sappiamo dove siete. E stiamo venendo a prendervi.
Madre e figlia ricominciarono a tirare la catena con maggior energia. La pietra sotto la brace si mosse quel tanto che bastava. La madre puntò la torcia su una scaletta di legno che scendeva nelle fondamenta.
I colpi alla porta proseguivano, accelerando.
Lei e la mamma si voltarono verso il corridoio e finalmente videro papà che sopraggiungeva con due bottiglie fra le mani: al posto del tappo avevano uno straccio bagnato. Tempo prima, nel bosco, la bambina aveva visto il padre dare fuoco a una di quelle bottiglie e poi lanciarla contro un albero secco che si era incendiato in un istante.
Gli estranei battevano alla porta d’ingresso: con loro grande stupore, le cerniere che la fissavano si stavano schiodando dal muro e i quattro chiavistelli che la sbarravano sembravano più fragili a ogni urto.
In un attimo, compresero che quell’ultima barriera non sarebbe bastata a trattenere ancora a lungo gli invasori.
Papà guardò loro e poi la porta, e poi di nuovo loro. Non c’era più tempo per la procedura. Quindi, senza pensarci troppo, annuì nella loro direzione e, contemporaneamente, posò a terra una delle bottiglie, ma solo per prendere dalla tasca un accendino.
La porta cedette di schianto.
Mentre ombre urlanti varcavano la soglia, l’ultimo sguardo di papà fu per lei e per mamma – insieme, come un abbraccio. In quei pochi istanti, negli occhi di suo padre si condensarono così tanto amore e compassione e rimpianto da rendere per sempre dolcissimo il dolore di quell’addio.
Mentre accendeva la fiamma, il papà sembrò abbozzare un leggero sorriso, solo per loro due. Quindi lanciò la bottiglia e sparì insieme alle ombre in una vampata. La bambina non riuscì a vedere altro perché la mamma la spinse nell’apertura sotto il camino, poi la seguì stringendo in mano l’estremità della catena.
Scesero a perdifiato i pioli di legno, rischiando più volte d’inciampare. Da sopra arrivò il boato soffocato di una nuova esplosione. Urla incomprensibili, concitazione.
Giunte alla base della scala, nell’umido sotterraneo, la madre lasciò andare la catena di ferro in modo che il meccanismo richiudesse la lastra di pietra sopra di loro. Ma qualcosa s’inceppò e rimase aperta un’ampia fessura. La mamma provò a sbloccare il congegno, tirando e strattonando. Inutilmente.
Secondo la procedura, in caso di attacco, la famiglia avrebbe dovuto trovare rifugio là sotto mentre sopra le loro teste la casa bruciava. Forse gli estranei si sarebbero spaventati e sarebbero corsi via, o forse li avrebbero creduti morti nell’incendio. Il piano prevedeva che, quando di sopra fosse tornata la quiete, lei, mamma e papà avrebbero riaperto la botola di pietra e sarebbero tornati in superficie.
Ma qualcosa era andato storto. Tutto era andato storto. Per prima cosa papà non era con loro, e poi la maledetta lastra non si era richiusa totalmente. Intanto, di sopra ogni cosa aveva cominciato ad avvampare. Il fumo stava già strisciando attraverso la fessura per venire a stanarle. E in quell’angusto sotterraneo non c’era via d’uscita.
La mamma la trascinò verso l’angolo più estremo di quella catacomba. A pochi metri da loro, nella fredda terra sotto un cipresso, era sepolto Ado. Il povero Ado, il malinconico Ado. Avrebbero dovuto toglierlo da lì per portarlo via.
Ma ormai neanche loro potevano scappare.
La madre le sfilò la coperta dalle spalle. «Stai bene?» domandò.
La bambina stringeva al petto la bambola di pezza con un occhio solo e tremava, ma fece lo stesso cenno di sì.
«Allora ascoltami» proseguì. «Adesso dovrai essere molto coraggiosa.»
«Mamma, ho paura, non riesco a respirare» disse lei, cominciando a tossire. «Usciamo di qui, ti prego.»
«Se usciamo gli estranei ci porteranno via, lo sai. È questo che vuoi?» affermò, con tono di rimprovero. «Abbiamo fatto tanti sacrifici perché non accadesse, e ora dovremmo arrenderci?»
La bambina sollevò gli occhi al soffitto del sotterraneo. Li poteva già sentire, a pochi metri da loro: gli estranei provavano a vincere le fiamme per andare a catturarle.
«Ho rispettato tutte le regole» si difese, singhiozzando.
«Lo so, amore mio» la tranquillizzò la madre, accarezzandole le guance.
Sopra di loro la casa delle voci gemeva nell’incendio, come un gigante ferito. Era straziante. Dalla fessura della lastra di arenaria ora dilagava un fumo più denso e nero.
«Non ci rimane molto tempo» affermò la mamma. «Abbiamo ancora un modo per andarcene…»
Quindi si cacciò una mano in tasca e prese qualcosa. L’oggetto segreto che aveva nascosto anche a papà era una boccetta di vetro.
«Un sorso a testa.»
Estrasse il tappo di sughero e gliela porse.
La bambina esitò. «Che cos’è?»
«Non domandare, bevi.»
«E che succederà dopo?» chiese, spaventata.
La mamma le sorrise. «Questa è l’acqua della dimenticanza… Ci addormenteremo e, quando ci risveglieremo, sarà tutto finito.»
Ma lei non le credeva. Perché l’acqua della dimenticanza non era nella procedura? Perché papà non ne sapeva nulla?
La madre l’afferrò per le braccia, scuotendola. «Qual è la regola numero cinque?»
La bambina non capiva che bisogno ci fosse di elencarle in quel momento.
«Regola numero cinque, forza» ribadì la mamma.
«’Se un estraneo ti chiama per nome, scappa’» ripeté lei, piano.
«La numero quattro?»
«’Non avvicinarti mai agli estranei e non lasciarti avvicinare da loro’» rispose stavolta con la voce che iniziava a essere rotta dal pianto. «La terza è ’non dire mai il tuo nome agli estranei’, ma io non l’ho fatto, giuro» si giustificò subito, ripensando a come tutto era iniziato quella notte.
Il tono della mamma si addolcì nuovamente. «La seconda regola, avanti…»
Dopo un istante: «’Gli estranei sono il pericolo’».
«Gli estranei sono il pericolo» ricordò con lei la madre, seria. Poi si portò la boccetta alle labbra e bevve un piccolo sorso. Gliela porse di nuovo. «Ti voglio bene, amore mio.»
«Anch’io ti voglio bene, mamma.»
La bambina guardò sua madre che la guardava. Poi fissò la boccetta nella sua mano. La prese e, senza più esitare, ingoiò ciò che rimaneva del contenuto.
Regola numero uno: fidati soltanto di mamma e papà.
1
Per un bambino la famiglia è il posto più sicuro della terra. Oppure, il più pericoloso.
Pietro Gerber cercava di non dimenticarlo mai.
«Va bene, Emilian: ti va di raccontarmi dello scantinato?»
Il bambino di sei anni dalla pelle diafana, quasi trasparente, tanto da sembrare uno spettro, rimase in silenzio. Non sollevò neppure lo sguardo dal fortino di mattoncini colorati che avevano costruito insieme fino a quel momento. Gerber continuò pazientemente ad aggiungere tasselli alle mura, senza mettergli fretta. L’esperienza gli diceva che Emilian avrebbe dovuto trovare da solo il momento giusto per parlare.
Ogni bambino ha il proprio tempo, ripeteva sempre.
Gerber era accovacciato accanto a Emilian da almeno quaranta minuti, sulla moquette coi colori dell’arcobaleno di quella stanza senza finestre, al secondo piano di un palazzo del Trecento in via della Scala, in pieno centro storico a Firenze.
Fin dalle origini, l’edificio era stato adibito da istituzioni caritatevoli fiorentine «a dare rifugio ai fanciulli smarriti», cioè i bambini abbandonati dalle famiglie troppo povere per mantenerli, i figli illegittimi, gli orfani e i minori che erano vittime di situazioni sociali illecite.
Dalla seconda metà dell’Ottocento, il palazzo era la sede del tribunale per i minorenni.
L’immobile era pressoché anonimo nel fulgore degli edifici che lo circondavano, assurdamente concentrati in pochi chilometri quadrati, e che facevano di Firenze una delle città più belle al mondo. Ma anche quello non poteva considerarsi un luogo come un altro. Per via della sua origine: in precedenza era una chiesa. Per via dei resti di un affresco del Botticelli, raffigurante l’Annunciazione alla Vergine.
E per via della stanza dei giochi.
Oltre ai mattoncini con cui era impegnato Emilian, c’erano una casa delle bambole, un trenino, macchinine assortite, ruspe e camion, un cavallo a dondolo, una piccola cucina per preparare prelibatezze immaginarie nonché svariati peluche. C’era anche un tavolo basso con quattro sedioline e l’occorrente per disegnare.
Ma era una finzione, perché tutto in quella ventina di metri quadri serviva a occultare la vera natura di quel posto.
La stanza dei giochi era a tutti gli effetti un’aula di giustizia.
Una delle pareti era occupata da un grande specchio dietro cui si celavano il giudice, la pubblica accusa, ma anche gli imputati e i loro difensori.
Quello spazio era stato ideato per salvaguardare l’incolumità psichica delle piccole vittime alle quali veniva chiesto di rendere testimonianza in una condizione protetta. Per favorire la verbalizzazione, ogni oggetto presente nella stanza era stato scelto e pensato dagli psicologi infantili per avere un ruolo preciso nella narrazione o nell’interpretazione dei fatti.
Spesso i bambini si servivano dei peluche o delle bambole, sostituendosi nella recita ai loro carnefici e sottoponendo i pupazzi allo stesso trattamento ricevuto. Alcuni preferivano disegnare piuttosto che parlare, altri inventavano delle favole e le disseminavano di riferimenti a ciò che avevano subito.
Ma, a volte, certe rivelazioni avvenivano inconsciamente.
Proprio per questo, dai poster alle pareti, allegri personaggi di fantasia vegliavano sui giochi dei piccoli ospiti insieme a invisibili microcamere. Ogni parola, gesto o comportamento veniva registrato per diventare una prova utile ai fini del verdetto. Ma c’erano sfumature che gli occhi elettronici non erano in grado di carpire. Dettagli che, a soli trentatré anni, Pietro Gerber aveva già imparato a individuare con precisione.
Mentre continuava a costruire il fortino di mattoncini colorati insieme a Emilian, lo studiava attentamente, sperando di cogliere anche il più piccolo segno di apertura.
La temperatura interna era di ventitré gradi, le lampade sul soffitto irradiavano un leggero bagliore azzurro e, in sottofondo, un metronomo batteva un ritmo di quaranta battiti per minuto.
L’atmosfera più adatta a favorire un completo rilassamento.
Se qualcuno chiedeva a Gerber in cosa consistesse il suo lavoro, lui non rispondeva mai «psicologo infantile specializzato in ipnosi». Usava un’espressione coniata da chi gli aveva insegnato tutto e che riassumeva meglio il senso della sua missione.
Addormentatore di bambini.
Gerber era consapevole del fatto che molti reputassero l’ipnosi una specie di pratica alchemica per controllare la mente altrui. Oppure credevano che l’ipnotizzato perdesse il controllo di se stesso e della propria coscienza e finisse in balia dell’ipnotizzatore che poteva spingerlo a dire o fare qualsiasi cosa.
In realtà, era semplicemente una tecnica per aiutare persone che si erano smarrite a entrare in contatto con se stesse.
Non si perdeva mai il controllo, né la coscienza – la riprova era che il piccolo Emilian stava giocando come sempre. Grazie all’ipnosi il livello di veglia si abbassava affinché cessasse il disturbo del mondo esterno: escludendo ogni interferenza, aumentava la percezione di sé.
Ma il lavoro di Pietro Gerber era ancora più particolare: consisteva nell’insegnare ai bambini a mettere ordine nella loro fragile memoria – sospesa fra gioco e realtà – e a distinguere ciò che era vero da ciò che non lo era.
Tuttavia, il tempo a disposizione con Emilian stava scadendo e l’esperto poteva immaginare l’espressione contrariata della Baldi, il giudice minorile, nascosta dietro lo specchio insieme agli altri. Era stata lei a nominarlo consulente per quel caso, ed era stata sempre lei a istruirlo su ciò che avrebbe dovuto chiedere al bambino. A Gerber toccava il compito di individuare la strategia migliore per indurre Emilian a fornirgli quelle informazioni. Se non avesse ottenuto qualcosa nei successivi dieci minuti, avrebbero dovuto rimandare l’udienza a un’altra data. Lo psicologo, però, non voleva arrendersi: era già la quarta volta che si incontravano, c’erano stati piccoli passi avanti ma mai veri progressi.
Emilian – il bambino spettro – avrebbe dovuto ripetere in sede giudiziale il racconto che aveva fatto un giorno, inaspettatamente, alla maestra di scuola. Il problema era che, da allora, non aveva più accennato alla «storia dello scantinato».
Niente racconto, niente prova.
Prima di dichiarare fallito anche quel tentativo, l’ipnotista si concesse un ultimo approccio.
«Se non vuoi parlare dello scantinato, non fa niente» disse. Quindi, senza attendere la reazione del minore, smise di erigere il fortino. Invece, prese alcuni mattoncini colorati e iniziò una seconda costruzione proprio accanto.
Emilian se ne accorse e si fermò a fissarlo, interdetto.
«Stavo disegnando nella mia cameretta quando ho sentito la filastrocca…» disse dopo un po’, con un filo di voce e senza guardarlo in faccia.
Gerber non mostrò alcuna reazione, lo lasciò parlare.
«Quella del bambino curioso. La conosci?» Emilian si mise a ripetere, cantilenando: «C’è un curioso bambino – gioca in un angolino – nel buio che tace – lui sente una voce – c’è uno spettro burlone – che lo chiama per nome – al curioso bambino – vuole dare un bacino».
«Sì, la conosco» ammise lo psicologo, continuando a giocare come se quella fosse una normale conversazione.
«Così sono andato a vedere da dove veniva…»
«E l’hai scoperto?»
«Veniva dallo scantinato.»
Per la prima volta, Gerber era riuscito a portare la mente di Emilian fuori dalla stanza dei giochi: adesso erano a casa del bambino. Doveva tenerlo lì il più a lungo possibile.
«Sei andato a vedere cosa c’era nello scantinato?» domandò.
«Sì, sono sceso.»
L’ammissione di Emilian era importante. Come ricompensa, lo psicologo gli porse un mattoncino colorato, permettendogli di partecipare alla costruzione del nuovo fortino.
«Immagino fosse buio. Non avevi paura ad andare là sotto da solo?» affermò per testare una prima volta l’attendibilità del piccolo testimone.
«No» replicò il bambino, senza alcun tentennamento. «C’era una luce accesa.»
«E cos’hai trovato laggiù?»
Ancora un’indecisione. Gerber smise di passargli mattoncini.
«La porta non era chiusa a chiave come le altre volte» riprese il bambino. «Mamma dice che non la devo aprire mai, che è pericoloso. Ma quella volta la porta era un po’ aperta. Si poteva vedere dentro…»
«E tu hai sbirciato?»
Il piccolo annuì.
«Non sai che sbirciare è sbagliato?»
La domanda poteva produrre effetti imprevedibili. Sentendosi rimproverato, Emilian poteva rintanarsi in se stesso e non raccontare più nulla. Ma se voleva rendere inoppugnabile la deposizione, Gerber doveva correre il rischio. Un bambino che non era in grado di comprendere il valore negativo delle proprie azioni non poteva essere considerato un testimone attendibile di quelle altrui.
«Lo so, ma me lo sono scordato che sbirciare è sbagliato» si giustificò il piccolo.
«E cosa hai visto nello scantinato?»
«C’erano delle persone…» disse soltanto.
«Erano bambini?»
Emilian scosse il capo.
«Allora erano adulti.»
Il bambino annuì.
«E cosa facevano?» lo incalzò lo psicologo.
«Non avevano i vestiti.»
«Come quando vai in piscina o al mare, o come quando fai la doccia?»
«Come quando fai la doccia.»
L’informazione rappresentava un prezioso progresso nella deposizione: per i bambini la nudità degli adulti era un tabù. Ma Emilian aveva superato l’ostacolo dell’imbarazzo.
«E avevano delle maschere» aggiunse, senza che Gerber glielo avesse domandato.
«Maschere?» si finse stupito lo psicologo, che conosceva la storia riportata dalla maestra di Emilian. «Che tipo di maschere?»
«Di plastica, con l’elastico dietro, quelle che coprono soltanto la faccia» disse il piccolo. «Animali.»
«Animali?» ripeté lo psicologo.
Il bambino iniziò a elencare: «Un gatto, una pecora, un maiale, un gufo… e un lupo, sì, era un lupo» ribadì.
«Perché indossavano quelle maschere, secondo te?»
«Giocavano.»
«Che gioco era? Lo conoscevi già?»
Il bambino ci pensò su un momento. «Facevano le cose di internet.»
«’Le cose di internet’?» Gerber voleva che Emilian fosse più esplicito.
«Leo, il mio compagno di scuola, ha un fratello più grande che ha dodici anni. Una volta il fratello di Leo ci ha fatto vedere un video su internet, erano tutti nudi e si abbracciavano in modo strano e si davano strani baci.»
«E ti è piaciuto quel video?»
Emilian fece una smorfia. «E poi il fratello di Leo ci ha detto che dovevamo mantenere il segreto perché quello era un gioco da grandi.»
«Capisco» affermò lo psicologo, senza far trasparire alcun giudizio dal tono di voce. «Sei molto coraggioso, Emilian, io mi sarei spaventato a morte.»
«Non avevo paura perché li conoscevo.»
Lo psicologo si arrestò: il momento era delicato. «Sapevi chi erano le persone con le maschere?»
Il bambino spettro dimenticò per un attimo il fortino e sollevò lo sguardo sulla parete con lo specchio. Dietro quel vetro, cinque individui erano in silenziosa attesa delle sue parole.
Un gatto, una pecora, un maiale, un gufo. E un lupo.
In quel momento, Gerber sapeva di non poter aiutare Emilian. Sperò che il piccolo si servisse dell’esperienza dei suoi appena sei anni di vita per trovare da solo il coraggio di pronunciare i veri nomi dei protagonisti di quell’incubo.
«Papà, mamma, nonno, nonna. E padre Luca.»
Per un bambino la famiglia è il posto più sicuro della terra. Oppure, il più pericoloso – ripeté Pietro Gerber dentro di sé.
«Va bene, Emilian: ora conteremo insieme all’indietro. Dieci…»
Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive a Roma. Dopo aver studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. È regista oltre che sceneggiatore di serie televisive e per il cinema. È una firma del Corriere della Sera ed è l’autore dei romanzi bestseller internazionali (tutti pubblicati da Longanesi) Il suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L’ipotesi del male, Il cacciatore del buio, La ragazza nella nebbia – dal quale ha tratto il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente –, Il maestro delle ombre,L’uomo del labirinto – da cui ha tratto il film omonimo – e Il gioco del suggeritore.