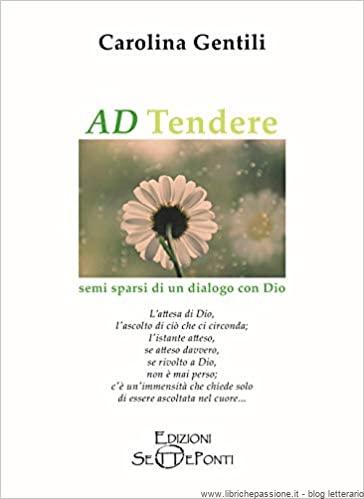Eleanor è una donna giovane e indipendente, fa l’illustratrice di libri per bambini e vive da sola in una bellissima casa di campagna nel New Hampshire. Quando conosce Cam, a fine anni Settanta, è subito amore e sesso e famiglia, e in poco tempo nascono Alison, Ursula e Toby. Cam è un bravo padre ma non sa trovarsi un lavoro; e un giorno perde di vista il piccolo Toby, che ha un incidente dalle conseguenze irreparabili. Eleanor non riesce a perdonare il marito, e innalza un muro di rancori che diventa insuperabile quando scopre un tradimento. Così decide di andarsene, lasciando a Cam e ai figli la casa e la normalità in cui hanno sempre vissuto. Il suo silenzio avrà conseguenze sul rapporto con i ragazzi, che entrano in conflitto con lei e lentamente la abbandonano. Ma grazie alla sua tenacia, Eleanor saprà ricostruire se stessa e riavvicinare le persone che ama. “L’albero della nostra vita” è la storia di una donna e di una coppia, sullo sfondo di una Storia che si riflette implacabile nella vita di ciascuno: le lotte sociali, l’avvento della tecnologia, la tragedia del Challenger, un filo rosso che lega tutti in un’unica, grande esperienza umana. Con saggezza e compassione, Joyce Maynard ci mostra il potere liberatorio del perdono, l’unica forza al mondo che può rivelarci il significato più puro e creativo dell’amore.

Questo libro è per chi non vede l’ora di partire per un epico viaggio alla ricerca della casa dei sogni, per chi ancora conosce a memoria la coreografia del video di Thriller, per chi da piccolo riponeva ogni speranza negli astronauti che conquistavano lo spazio, e per chi immagina la propria vita come una barchetta di legno in balìa della corrente, che sussulta e sobbalza fino a raggiungere il mare aperto.
sapendo che non sei stata abbandonata,
che la felicità ha tenuto da parte la sua forma più estrema
per te sola.
Jane Kenyon, Happiness
Come ti amo? Lasciamene contare i modi.
Elizabeth Barrett Browning, Sonetto 43
PROLOGO
Toby era ancora un neonato – Alison aveva quattro anni, Ursula meno di tre – la prima volta in cui calarono in acqua gli omini di sughero. Da allora diventò la loro tradizione annuale.
Eleanor aveva sempre amato il rumore del torrente in fondo alla strada in primavera, quando la neve si scioglieva e l’acqua scorreva così veloce che la si sentiva anche dalla casa, e scrosciava contro le rocce della cascata. Si poteva rimanere lì anche un’ora intera – e un tempo, prima che nascessero i bambini, lei lo aveva fatto – a fissare l’acqua, a osservare le figure che formava quando il torrente si restringeva e poi si allargava di nuovo, a guardarla sommergere le pietre più piccole e spruzzare quelle grandi. Volendo, si poteva seguire la rotta di un singolo rametto o di una foglia, avanzo dell’estate precedente, che si dirigeva a valle, trascinata dalla corrente.
Una volta Eleanor e i bambini avevano avvistato la scarpa di un bimbo, catturata dalle acque. Un’altra volta Alison aveva buttato una pigna nel torrente, e tutti e quattro – Eleanor, Alison, Ursula e il piccolo Toby – l’avevano guardata affondare e riemergere, scomparire in un canalone per poi riaffiorare, miracolosamente, sull’altra sponda. Avevano seguito la pigna camminando lungo la riva finché non era sparita oltre una curva.
«Se solo avessimo una barca» aveva detto Alison, fissando l’acqua «potremmo navigare lungo il ruscello». Stava pensando alla canzone che Eleanor cantava sempre in macchina, Row, row, row your boat.
«Merrily, merrily, merrily, merrily» aveva cantato Alison, con la sua voce acuta e dolce.
Life is but a dream.
Tornati a casa, Alison ne stava ancora parlando, perciò Cam aveva proposto di fabbricare una barca in miniatura e calarla in acqua proprio sotto le cascate. Con piccoli passeggeri a bordo.
«Potremmo farli con gli stecchi dei ghiaccioli» aveva detto. «O con i tappi di sughero».
Meglio il sughero, perché galleggiava. Omini di sughero.
Da allora ogni anno, di solito nel primo fine settimana tiepido di marzo, Eleanor piazzava i materiali sul tavolo della cucina – scovolini, pistola a caldo, spago, puntine da disegno, pennarelli e i tappi delle bottiglie
di vino bevute in un anno, che a quei tempi non erano poi così tante.
Fabbricavano le barche con il legno di balsa e le vele con avanzi di stoffa di pigiami e vestiti dei bambini diventati troppo piccoli. Alison, la futura ingegnera, si concentrava sulle barche, più che sui passeggeri. Ursula invece dedicava la massima cura a disegnare le facce sui tappi, e a incollarvi capelli e copricapi. Perfino Toby, piccolo com’era, partecipava. Ogni omino di sughero aveva un nome.
Una donnina si chiamava Crystal, su proposta di Ursula. Aveva desiderato una sorella con quel nome, ma dato che non l’aveva avuta lo aveva assegnato a una donnina di sughero. Un altro si chiamava Rufus – non era un omino, in realtà, ma un cane di sughero. Un altro ancora era Walt, come il vicino di casa, e a una donnina avevano dato il nome della figlia di un giocatore della squadra di softball del padre, che si era ammalata di cancro ed era morta proprio quell’anno, più o meno quando la neve aveva iniziato a sciogliersi.
Quando avevano finito di preparare gli omini di sughero e le barche per accoglierli, Eleanor e i bambini li portavano in un punto in cui le rocce erano abbastanza piatte da permettere a tutti e quattro di stare in piedi, e ciascuno a turno calava le sue barche con il loro carico di passeggeri nelle acque che scorrevano veloci.
Arrivederci, Crystal. Ciao, Rufus. Ci vediamo dopo, Walt.
Ormai erano abbandonati a se stessi, e nessuno poteva più fare niente per aiutarli nel pericoloso viaggio che li aspettava.
Era come diventare genitori, pensava Eleanor, guardando la piccola flotta di barchette oscillanti che si allontanava trasportata dalla corrente. Fabbricavi preziosi omini e donnine. Li sorvegliavi da vicino, animata da un unico scopo impossibile: tenerli fuori dai guai. Ma presto o tardi dovevi lasciare che gli omini di sughero salpassero senza di te, e a quel punto non ti restava altro che rimanere ferma a riva o correre lungo la sponda gridando parole di incoraggiamento, e pregare che ce la facessero.
Le barche si allontanavano, oscillando e ondeggiando. Eleanor e i bambini correvano lungo la riva coperta di muschio per seguirne il percorso. Si affrettavano per tenersi al passo, ed Eleanor stringeva forte la mano di Toby. Toby, quello capace di sfuggirle e di finire nei guai più veloce di tutti gli altri.
Per gli omini di sughero il viaggio non era facile. Alcune barche si incagliavano lungo la rotta, tra l’erba alta sulla riva del torrente. Altre scomparivano senza lasciare traccia. Se una delle barche fatte da lei si capovolgeva, Ursula (quella dal temperamento drammatico) spesso cacciava uno strillo lacerante.
«Oh, Jimmy!» gridava. «Oh, Crystal!». «Evelyn, dove sei?». «Walt! Stai attento!».
Alcuni omini di sughero non ce la facevano a superare il canalone. Altri cadevano giù dalla barca mentre percorrevano un tratto di violente rapide poco più avanti. Una volta un’imbarcazione si capovolse appena prima di raggiungere lo specchio d’acqua lenta e tranquilla dove in genere i bambini recuperavano gli omini.
Un giorno, fermi sulla riva a tener d’occhio le barche che ondeggiando discendevano il torrente, avevano avvistato un omino di sughero dell’anno precedente che fluttuava senza cappello, senza barca, nudo, ma in qualche modo ancora a galla.
Toby, che a quell’epoca aveva quattro anni, si era sporto nell’acqua bassa (stringendo la mano di Eleanor, anche se controvoglia) per recuperare i resti di quell’omino malridotto, e lo aveva guardato bene in faccia.
«È Bob» aveva detto. Lo avevano battezzato così prendendo spunto da un compagno della squadra di softball di Cam, gli Yellow Jackets.
Ursula aveva dichiarato che si trattava di un miracolo, anche se per Toby non c’era nulla di sorprendente nel ritorno inaspettato di un vecchio e ben noto personaggio.
Gli omini di sughero partivano, gli omini di sughero tornavano. Oppure no.
«A volte la gente muore» aveva fatto notare Toby a Ursula (che aveva due anni più di lui ma era meno disposta ad affrontare il lato oscuro). Non solo quelli di cui ascoltavi le canzoni alla radio o di cui sentivi parlare nei notiziari, o una principessa di cui avevi visto il matrimonio in tv, o un intero space shuttle pieno di astronauti, o un cantante rock capellone di cui ballavi le canzoni in cucina, ma anche gente che conoscevi di persona. Un vicino che abitava in fondo alla strada e che una volta ti aveva fatto vedere il bozzolo di una falena, e un tizio che era venuto alla festa dei tuoi genitori per il Labor Day e aveva fatto l’imitazione di un gallo, e una cara amica che un giorno ti aveva portato a un parco acquatico. E anche i cani morivano, e anche i nonni, e perfino una bambina a cui una volta, durante una partita a softball di tuo padre, avevi offerto il tuo ultimo bastoncino di mozzarella impanata. E anche quando queste cose non succedevano, ne capitavano altre, comunque terribili. Bisognava farci l’abitudine.
Eppure, ecco una storia su cui si poteva contare, una storia che non cambiava mai. Primavera, estate, autunno, inverno, l’acqua scorreva sempre. Quelle rocce sarebbero rimaste lì per sempre – rocce, una delle cose che Toby amava di più al mondo; e nonostante avesse riflettuto sulle perdite intorno a lui, il pensiero che lui e i suoi cari avrebbero smesso di esistere era al di là della sua immaginazione.
Nella mente di Toby, i membri della sua famiglia sarebbero rimasti insieme per sempre, continuando ad amarsi, e cos’altro c’era di più importante? Quello era il mondo che conoscevano. Era il mondo come appariva loro a quell’epoca, e forse un tempo perfino Eleanor ci aveva creduto.
PARTE PRIMA
1
UNA STRADA FAMILIARE
Il rumore li raggiunse propagandosi fino in fondo al campo, dov’erano allineate le sedie – tanto potente che se Eleanor non avesse stretto così forte Louise, forse l’avrebbe lasciata cadere. Qualcuno urlò, qualcun altro gridò: «Oh, merda!». Eleanor sentì la voce di uno degli invitati che cominciava a pregare in spagnolo. Nel vedere la scena, Louise scoppiò in lacrime e chiamò la mamma.
Il rumore non assomigliava a niente che Eleanor avesse mai sentito in passato. Uno schianto, seguito da un gemito basso, orribile. Poi silenzio.
«Oddio» strillò qualcuno. «Dios mio». La voce di qualcun altro.
«Adesso troviamo la tua mamma» disse Eleanor a Louise, scrutando la folla degli invitati in cerca di sua figlia, Ursula, la madre della bambina. Da parte sua, Eleanor accolse l’evento – di qualunque cosa si trattasse – con una certa, inaspettata calma. Qualunque cosa stesse capitando in quel momento, ne erano già successe di peggiori, lo sapeva. E anche se per lei il pezzo di terra su cui posava i piedi un tempo aveva rappresentato il luogo in cui avrebbe vissuto per tutta la vita fino alla morte, ormai non era più casa sua, già da quasi vent’anni.
All’inizio era impossibile capire da dove provenisse il rumore, o quale ne fosse la causa. Un terremoto? Un aereo precipitato? Un attentato? La mente di Eleanor tornò – illogicamente – a un film che aveva visto, su uno tsunami e una donna la cui intera famiglia era stata spazzata via da un’unica, enorme, spaventosa ondata.
Ma la famiglia di Eleanor era sana e salva. Adesso li vedeva, tutti riuniti intorno a lei – storditi, confusi, ma illesi. La sola cosa che davvero doveva fare era assicurarsi che Louise stesse bene. La sua unica, preziosa nipotina di tre anni.
Nel momento dello schianto Louise stava osservando il ciondolo di Eleanor, un piccolissimo uccellino d’oro appeso a una catenina. «Va tutto bene» le sussurrò Eleanor all’orecchio, quando udirono il grande botto. Intorno a loro gli invitati in abito da cerimonia correvano qua e là senza sapere bene dove andare, gridando parole che nessuno riusciva a sentire.
«Stanno tutti bene» disse Eleanor. «Andiamo dalla mamma».
Eleanor era arrivata da Boston la sera prima. La fattoria di Cam – ormai si era abituata a chiamarla così – si trovava a poco più di un’ora di macchina verso nord dal palazzo dove abitava, a Brookline. Aveva intrapreso quel viaggio, per la prima volta dopo ben oltre un decennio, per partecipare al matrimonio del figlio primogenito, il fratello maggiore di Ursula, nella casa dove Eleanor aveva vissuto un tempo.
Dopo tutti quegli anni, conosceva ancora così bene quel luogo che avrebbe potuto percorrere il lungo viale d’ingresso al buio e a fari spenti. Ricordava ogni nodo nelle assi del pavimento, il davanzale dove un tempo Toby metteva in fila gli esemplari preferiti della sua collezione di rocce, le crepe in cui i lustrini dei biglietti per San Valentino che preparavano insieme si erano incastrati, il bancone dalla superficie irregolare dove stendeva la pasta dei biscotti e impacchettava i pranzi al sacco per la scuola, oppure (nei giorni in cui nevicava) preparava i popcorn e la cioccolata calda per i suoi tre figli quando tornavano a casa dopo essere andati in slitta. Conosceva l’aspetto delle pareti dello sgabuzzino in cui, in un’epoca anteriore all’arrivo dei cellulari, si rinchiudeva con in mano un telefono a cui aveva attaccato un cavo molto lungo, quando aveva bisogno di fare una telefonata di lavoro senza le voci dei bambini a distrarla.
E inoltre: il bagno dove un tempo suo figlio suonava il violino in miniatura. La dispensa, gli scaffali colmi di barattoli di marmellata e salsa di pomodoro che lei preparava tutte le estati. Il giradischi che suonava mentre loro, tutti e cinque, ballavano le canzoni dei Beatles, o di Chuck Berry, oppure Free to be… you and me. La mensola del camino dove appendevano le calze e il tappetino davanti al focolare su cui lei spargeva cenere per simulare le impronte di un visitatore che si era calato di notte giù per il camino.
Eleanor sapeva dove crescevano i mirtilli selvatici e le scarpette di Venere, e qual era la roccia da cui ogni anno a marzo – quando la neve si scioglieva e il torrente scorreva veloce sotto il ponte di pietra – calavano in acqua gli omini di sughero. Il pero che lei e Cam avevano piantato prima della nascita del primo figlio. La parte del campo in cui a fine giugno spuntavano i fiordalisi. Che proprio in quel periodo stavano cominciando a sbocciare. Una tonalità di azzurro come nessun’altra.
Ed eccola lì, a partecipare al matrimonio di quello stesso figlio. In un’altra vita, avevano chiamato la neonata Alison. Adesso lo chiamavano Al.


Joyce Maynard è una scrittrice e sceneggiatrice americana, giornalista per il New York Times, Vogue, O, The Oprah Magazine, e The New York Times Magazine. Ha pubblicato diciassette libri, tra cui At Home in the World, che racconta la sua relazione da giovanissima con J.D. Salinger. Il suo romanzo To Die For è diventato il celebre film Da morire, così come Labor Day, di prossima pubblicazione per NNE, è stato portato sul grande schermo da Jason Reitman.
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso