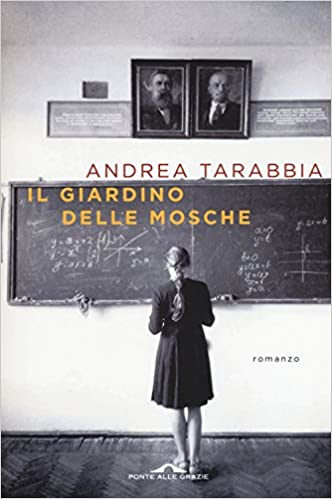Autrice : Susan Meissener
Casa editrice: tre60
data di pubblicazione: 27 Giugno 2019
Genere: Romanzo
Trama
Oxford, oggi. Kendra Van Zant è una studentessa americana che si trova in Inghilterra per scrivere la tesi sulla seconda guerra mondiale. È così che conosce Isabel McFarland, un’anziana pittrice sopravvissuta ai bombardamenti di Londra. Ma quella che sembra una semplice intervista diventerà un racconto pieno di sorprese: Isabel ha infatti diversi segreti da rivelare, a cominciare dalla sua vera identità… Londra, 1940. Mentre la città è ridotta in macerie dalle bombe della Luftwaffe, centinaia di bambini vengono evacuati nelle campagne, in cerca di un rifugio sicuro. È il destino delle sorelle Emmy e Julia Downtree, che si ritrovano in un cottage sulle colline dei Cotswolds, mentre Anna, la loro madre, rimane a lavorare a Londra. Emmy ha solo quindici anni, ma è cresciuta in fretta e si prende cura della sorellina e della casa con quieta determinazione… almeno finché la signora Crofton, proprietaria del Primrose Bridal, non le offre l’opportunità di diventare la sua apprendista. Per Emmy, quel negozio è un autentico paradiso, anche perché disegnare abiti da sposa è da sempre il suo sogno. Ma lavorare lì significa tornare a Londra, di nascosto dalla madre, mettere Emmy in pericolo e rischiare la vita. La guerra non perdona: costrette a separarsi, le due sorelle andranno incontro a destini diversi. E l’unico scopo di Emmy sarà ritrovare Julia…
Estratto
Presentazione
Oxford, oggi. Kendra è una studentessa americana che si trova in Inghilterra per scrivere la tesi sulla seconda guerra mondiale. È così che conosce Isabel MacFarland, un’anziana pittrice sopravvissuta ai bombardamenti di Londra. Ma quella che sembra una semplice intervista diventerà un racconto pieno di sorprese: Isabel ha infatti diversi segreti da rivelare, a cominciare dalla sua vera identità…
Londra, 1940. Mentre la città è ridotta in macerie dalle bombe della Luftwaffe, centinaia di bambini vengono evacuati nelle campagne. È il destino delle sorelle Emmy e Julia Downtree, che si ritrovano in un cottage sulle colline dei Cotswolds, mentre Annie, la loro madre, rimane a lavorare a Londra. Emmy ha solo quindici anni, ma è cresciuta in fretta e si prende cura della sorellina e della casa con quieta determinazione… almeno finché la signora Crofton, proprietaria del Primrose Bridal, non le offre l’opportunità di diventare la sua apprendista. Per Emmy, quel negozio è un autentico paradiso, anche perché disegnare abiti da sposa è da sempre il suo sogno. Ma lavorare lì significa tornare a Londra, di nascosto dalla madre, mettere Emmy in pericolo e rischiare la vita. La guerra non perdona: costrette a separarsi, le due sorelle andranno incontro a destini diversi. E l’unico scopo di Emmy sarà ritrovare Julia…
Alle mie «ragazze con l’ombrello»:
Stephanie, Bree e Chelsey.
La nostra vita è il risultato dei nostri pensieri.
MARCO AURELIO, Meditazioni
PARTE PRIMA
Kendra
Cotswolds, Inghilterra
Il cottage di pietra dorata circondato da una siepe di rovi è senza tempo, come in una fiaba, a eccezione dei palloncini gonfiati con l’elio che ballonzolano legati al cancelletto. L’edera si arrampica su tutti i muri, fino agli abbaini del secondo piano, e soltanto attorno alle finestre è addomesticata dalla potatura. Sotto i davanzali le malvarose si innalzano in file maestose. Mentre mi avvicino in macchina, lo scricchiolio delle gomme sulla ghiaia del vialetto sembra quasi un applauso, doveroso, considerato che la donna che sono venuta a intervistare compie novantatré anni proprio oggi. Tiro il freno a mano e prendo la borsa dal sedile del passeggero. Appena scendo mi ritrovo immersa nell’atmosfera da cartolina dei Cotswolds in aprile. Non mi aspetto un invito a rimanere per la festa di compleanno, eppure ci spero. Adoro l’abitudine inglese di festeggiare le ricorrenze al pomeriggio.
Sebbene mi abbiano ripetuto che non posso non aver visto i suoi acquerelli, in vendita nei negozi di Oxford, per me Isabel MacFarland è una sconosciuta. Non so nemmeno che voce abbia. Ha acconsentito a farsi intervistare sulla sua esperienza di sopravvissuta al grande bombardamento di Londra tramite uno dei miei professori, e soltanto perché la persona con cui avevo organizzato di parlare è morta nel sonno in una residenza per anziani di Banbury. La data di oggi era quella che faceva più comodo a entrambe, e oltretutto mi avrebbe permesso di rispettare le scadenze, fare gli esami finali e salutare Oxford e i miei studi all’estero per tornare a malincuore in California.
Quando scendo dalla macchina mi congratulo con me stessa per essere arrivata sana e salva nel paesino di Stow-on-the-Wold, senza rovinare la giornata a nessun altro nel tentativo. Nei quattro mesi in cui ho frequentato il Keble College di Oxford come visiting student, ho preso a prestito questa macchina tre volte: una per verificare se avrei avuto il coraggio di rifarlo, un’altra per prepararmi alla terza volta e poi per portare i miei genitori e mia sorella al castello di Warwick e a Stratford-upon-Avon, quando sono venuti a trovarmi a metà semestre. Da un punto di vista statistico, essere arrivata a destinazione tutta intera non è un risultato eccezionale perché, a quanto pare, le prime esperienze di guida dalla parte sbagliata della strada sono quelle in cui si verificano meno incidenti. È dopo essersi messi al volante una decina di volte che si diventa pericolosi. Si abbassa la guardia. Ci si dimentica di dove ci si trova e si compie una svolta fatale in contromano; l’abitudine ritarda i riflessi.
Il mio viaggio in macchina di oggi, il quarto in Inghilterra, è ben al di sotto della soglia di pericolo ed è improbabile che io guidi ancora prima della fine del semestre. Non sarebbe stato strettamente necessario nemmeno oggi, perché c’è una stazione ferroviaria nella vicina Moreton-in-Marsh, ma i due paesi distano sette chilometri, da percorrere su strette stradine di campagna, e gli autobus sono sporadici. Penelope, la mia compagna di stanza originaria di Manchester che ha avuto il coraggio di prestarmi la macchina più volte, ha insistito perché la prendessi.
Mi fermo un istante a respirare il profumo di erba, di cielo e di rugiada, rinvigorente dopo settimane di smog cittadino. Tutto intorno a me ci sono campi di velluto, punteggiati da gruppetti di alberi e da abitazioni sparse talmente pittoresche che sembrano uscite da un libro di fiabe. Alcune case hanno il tetto di paglia, altre no, ma tutte sono costruite con una pietra dorata che mi fa pensare al sapore delle caramelle mou. Sotto l’arco della porta d’ingresso circondata di rose rampicanti compare una donna. Sta asciugandosi le mani con uno strofinaccio e mi sorride. Ha i capelli quasi grigi e un elegante taglio asimmetrico. Immagino che sia Beryl Avery, la badante e domestica di Isabel, nonché la persona che mi ha dato le istruzioni per arrivare qui.
«Allora ci hai trovato!» mi grida.
Chiudo la portiera dell’attempata Austin-Morris di Penelope. «Le istruzioni erano precisissime. Va bene se parcheggio qui?»
«Certo, vieni dentro.»
Quando apro il cancelletto i palloncini ballonzolano. Uno vorrebbe attaccarsi alla cinghia della mia borsa. Lo allontano con delicatezza.
Beryl mi tiene aperta la porta, dipinta di rosso ciliegia con uno smalto lucido. «Mi fa piacere che tu sia venuta. Sono Beryl Avery.» Mi porge la mano mentre oltrepasso la soglia.
«Kendra Van Zant. Grazie dell’ospitalità, soprattutto in una giornata così impegnativa. Le sono davvero riconoscente.»
Beryl chiude la porta alle nostre spalle. Ipotizzo che abbia quasi settant’anni. Profuma di torta, di panna e di altre dolcezze. Ha una spruzzata di farina sul mento.
«Non c’è problema» mi dice, con allegria. «Sono contenta che tu sia qui. La zia non parla molto della guerra e invece noi tutti vorremmo che lo facesse. Liquida le nostre domande come se non credesse che si possa essere interessati a cose successe tanto tempo fa. Ma considerato quello che ha passato, noi saremmo più che interessati. È stata proprio una bella sorpresa che ti abbia detto di sì.»
Non so cosa risponderle, perché è stata una sorpresa anche per me, che l’anziana signora abbia detto di sì. Il professor Briswell mi ha raccontato che la signora MacFarland, nota artista locale e amica della sua defunta mamma, aveva perso la casa durante il Blitz, ma che non ne parla mai.
«Le avrei chiesto perché ha accettato di parlarti, ma avevo paura di farle cambiare idea e rovinarti tutto», continua Beryl.
Sto per domandarle come mai la signora MacFarland sia così restia a parlare della guerra, per sapere quali domande sarebbe meglio evitare, ma Beryl riempie il breve silenzio prima di me.
«Ti devo dire, però, che oggi mi sembra un pochino persa nei suoi pensieri. Può essere che tu debba lasciarle del tempo per rispondere alle tue domande. Dev’essere stata la confusione della festa.»
«È sicura che non sia meglio rimandare a un altro giorno?»
Beryl inclina la testa. «Ma no. È che la zia non è molto comunicativa, ma secondo me è contenta che tu sia qui. Credo che la preoccupi di più la festa di oggi pomeriggio. Non voleva fare le cose in grande e purtroppo per lei è proprio quello che succederà. Nessuno ha voluto ascoltarmi, quando ho detto che non era dell’idea.»
Lasciamo l’ingresso angusto per entrare in un salotto intimo e invitante come una tana degli hobbit di Tolkien. Al centro della stanza ci sono un sofà verde felce e un divanetto coordinato, separati da un tavolino di vetro carico di libri e giunchiglie in vaso. Il pavimento di legno è coperto di tappeti persiani. In un angolo c’è un carrello per il tè, in un altro una vetrinetta e nel terzo una libreria a L. Alle pareti sono appesi deliziosi acquerelli di ragazze con ombrelli a pois.
«Li ha dipinti la signora MacFarland?»
«Sì, ne abbiamo ovunque, in casa. È un’artista raffinata, ma di certo lo sapevi già. Le ragazze con l’ombrello sono il suo marchio. Ormai la sua artrite si è aggravata troppo per dipingere. Ha dovuto smettere un po’ di tempo fa.» Beryl sospira. «Quella sì che è stata una giornataccia. La zia ha avuto troppe giornate difficili, davvero troppe.» Beryl scuote la testa, come se volesse scacciare il peso dell’angoscia di cui è stata testimone. «Accomodati intanto che vado a prenderla.»
Esce e io mi siedo sul divanetto, spostando qualche cuscino troppo imbottito. Adesso sento voci in altre stanze della casa e risate nel giardino posteriore. Un bambino strilla. Un altro urla che è il suo turno. Una voce adulta, più calma, con un tono da nonna, intima a un certo Timmy di lasciare l’aquilone a un certo Garth, altrimenti lo rimanderà in casa.
Tiro fuori della borsa il registratore e lo sistemo sul tavolino davanti a me, sperando che a Isabel non dispiaccia se registro la nostra conversazione. Riguardo le domande sul mio quaderno e decido che mi lascerò guidare dalle sue risposte. Non voglio compromettere l’intervista chiedendole troppo e troppo presto. Mentre sto tirando fuori una matita, sento un rumore di passi strascicati.
«Me la cavo da sola, Beryl» dice una voce, roca e mielosa per l’età. «Il tè è pronto?»
«Certo, è tutto sul vassoio» risponde Beryl dal corridoio, dove non posso vederla.
«Benissimo. Puoi portarlo subito.»
«E la medicina?»
«Soltanto il tè, grazie.»
«Ma non l’hai presa nemmeno ieri.»
«Non fare tante storie proprio adesso, Beryl.»
Isabel MacFarland entra in salotto. È un mucchietto di pelle sottile come carta velina, capelli bianchi impalpabili e ossa fragili. Però è vestita in modo impeccabile: ha una gonna color lavanda al ginocchio e una camicetta bianco latte con i bottoni ricoperti di raso. Ai piedi sottili porta un paio di ballerine nere. Una collana d’oro le circonda il collo. Ha le unghie laccate di un rosa pallido luccicante e i capelli cotonosi sono fermati sulla nuca con un pettine di madreperla. Ha in mano un oggetto rettangolare, a forma di libro, avvolto in un pezzo di stoffa legata con un nastro.
Mi alzo per capire se ha bisogno del mio aiuto.
«Signorina Van Zant, molto piacere.» Il suo accento inglese è diverso da quello di Beryl. Sembra quasi forzato.
«Posso aiutarla?» dico, facendo qualche passo verso di lei.
«Grazie, ma non serve. Si accomodi, prego.»
Torno al divanetto e lei si siede piano piano sul sofà, di fronte a me. «Grazie per aver accettato di incontrarmi» le dico. «E nel giorno del suo compleanno, per giunta.»
Sminuisce la mia riconoscenza con un gesto. «È un giorno come un altro.»
Sulla soglia compare Beryl, sta portando il vassoio con il tè. «Compiere novantatré anni non è mica da tutti, zia.»
Isabel MacFarland sorride come se le fosse appena venuta in mente una cosa buffa. Beryl appoggia il vassoio e passa alla zia la tazza, dove ha già messo latte e zucchero. Poi ne porge una anche a me; ci metto un cucchiaino di zucchero. Il tintinnio di un cucchiaino d’argento in una tazza di porcellana inglese è uno dei rumori che mi mancheranno di più quando sarà il momento di tornare negli Stati Uniti.
«Grazie, Beryl» dice la signora MacFarland. «Puoi lasciarci il vassoio. E, per favore, chiudi la porta, così non disturbiamo nessuno.»
Beryl guarda prima me e poi la signora MacFarland con un’espressione evidentemente delusa. «Certo» dice, fingendosi allegra. Si dirige alla porta e si volta un istante a farci un sorriso di cortesia che senza dubbio le costa fatica. Chiude la porta con delicatezza.
«Secondo me sperava di rimanere con noi» butto lì.
«Beryl mi fa tanta compagnia e non potrei vivere qui da sola, senza di lei, ma preferisco avere la libertà di dire quello che voglio, se non le dispiace.»
Tanta franchezza mi coglie impreparata. «Certo, ci mancherebbe.»
«Quando si arriva alla mia età, la fragilità fisica fa pensare che il resto sia altrettanto fragile, compresa la capacità di prendere decisioni in autonomia. Incontrarla oggi è stata una mia decisione. E sarò io a decidere cosa raccontarle di quanto è successo durante la guerra. Non ho bisogno che la cara Beryl mi tenga la mano o mi suggerisca che non sto rispondendo in modo appropriato alle sue domande, né lo desidero. Posso darle del tu?»
«Sì. Sì, certo.»
La signora MacFarland sorseggia il suo tè e si appoggia allo schienale del divano. «Allora chiamami pure Isabel. Dimmi, Kendra, ti piace studiare a Oxford?»
Questo interesse per la mia vita ha un effetto straordinariamente calmante. «Alla fine del mese prossimo dovranno costringermi ad andarmene. Ho adorato ogni minuto passato qui. C’è tanta di quella Storia, compattata in un posto solo, che mi dà alla testa.» Proprio quello che ci si aspetterebbe di sentir dire a una studentessa di Storia.
«Perché, nel posto da cui vieni non c’è Storia?»
«Sì c’è, ma è diverso. Non è altrettanto antica. L’edificio più vecchio non ha nemmeno duecento anni. Ed è una semplice casa.»
Mi sorride. «Ho imparato ad apprezzare le semplici case.»
Arrossisco un pochino. «Non volevo dire che casa sua non è affascinante, signora MacFarland. Casa sua è bellissima. È proprietà della sua famiglia da molto tempo?»
«Chiamami Isabel. E, sì, si può dire che la mia famiglia la possiede da moltissimo. Allora ti laurei in Storia?»
Annuisco e bevo un sorso di tè.
«Cosa ti interessa tanto, della Storia?»
Non ho ancora capito perché mi chiedono sempre come mai mi interessi la Storia, quasi che non possa esercitare alcuna attrattiva per chi non la sceglie come corso di laurea. Durante tutto l’ultimo anno di liceo, quando gli adulti curiosi e perfino i miei compagni mi chiedevano che facoltà avrei scelto, alla mia risposta domandavano subito: perché? E me lo sento chiedere ancora tre anni dopo.
«Come si fa a non essere interessati alla Storia?» Lo dico con un sorriso, in modo che non si offenda. Ma seriamente: come fa una sopravvissuta al bombardamento di Londra a non capire l’importanza di comprendere la Storia? Lo scrittore Michael Crichton ha detto: «Se non conosci la Storia, non sai nulla. Sei una foglia che non sa di far parte di un albero».
Isabel trova la mia domanda divertente. «Ma cos’è la Storia? È un resoconto obiettivo di quanto è accaduto o piuttosto la nostra interpretazione?»
«Entrambe le cose, secondo me. Dev’essere così. A che serve ricordare un avvenimento, se non ti ricordi quali sensazioni ti ha suscitato, che impatto ha avuto sugli altri, quali sensazioni ha suscitato anche in loro? Non impareresti nulla, nessuno imparerebbe nulla.»
La bocca di Isabel si tende in una riga sottile e dura. Mi domando se l’ho offesa e se ho appena sprecato la mia ultima chance di intervistarla.
Ma lei sospira e capisco che non ce l’ha con me. «Hai proprio ragione, mia cara, hai proprio ragione.» Beve un altro sorso di tè e le sue labbra indugiano sul bordo della tazza. Per un istante mi sembra lontanissima, persa nei ricordi, in un antico luogo di memorie dolorose. Poi riappoggia la tazza sul piattino con un lieve sfregamento. «Che cosa farai, quando sarai tornata negli Stati Uniti?»
«Ho ancora un altro anno di università e poi spero di passare direttamente alla specializzazione» mi affretto a rispondere, impaziente di mettere da parte i convenevoli e arrivare al motivo per cui sono qui. «Vorrei fare un dottorato in Storia e insegnare a livello universitario.»
«Una ragazza con le idee chiare. Quanti anni hai, cara?»
Mio malgrado, mi viene la pelle d’oca. Quando qualcuno ti chiede quanti anni hai, è perché pensa che la risposta sia rilevante, mentre di solito non lo è.
«Non sei costretta a dirmelo, se non vuoi. Ero curiosa» aggiunge.
«Ventuno.»
«E ti infastidisce che te l’abbia chiesto.»
«No, davvero. Ma mi sorprende che me lo chiedano. Non capisco perché dovrebbe essere importante.»
«È proprio questo il motivo per cui sei infastidita. Una volta capitava anche a me. Le persone ti trattano in modo diverso, se pensano che tu sia troppo giovane per sapere che cosa vuoi.»
La pelle d’oca pian piano lascia il posto a un senso di affinità. «È vero.»
«Ti capisco benissimo. Sei la più grande, in famiglia?»
«Ho una sorella minore di quattro anni.»
«Una sorella. E basta?»
Annuisco.
Sembra che si stia prendendo un momento per assimilare l’informazione. «Avevo immaginato che fossi la maggiore. Noi primogenite siamo decise. Per forza. Non c’è nessuno che ci precede sul sentiero, lasciandoci le briciole da seguire. Tracciamo noi la strada. E i più piccoli ci prendono ad esempio. Ci osservano per ispirarsi a noi, che ci piaccia o no.» Vuota la tazza e la riappoggia con delicatezza sul vassoio.
Non so dove voglia arrivare. «Forse. Può essere. Ma non sono sicura che mia sorella sarebbe d’accordo. È una che ha le sue idee. Secondo me risponderebbe che lei lascia le sue, di briciole.»
Isabel scoppia in una risata, leggera e spensierata. È il genere di risata che sgorga spontanea quando si riaffaccia alla mente un ricordo, magari il ricordo di qualcosa che non era affatto divertente quando è successo.
«Come si chiama tua sorella?» mi chiede, quando la risata scema.
«Chloe.»
Chiude gli occhi come se stesse assaporando il nome. «Che bel nome.» Riapre gli occhi. «Hai una sua foto?»
Tiro fuori della borsa il cellulare e trovo una foto di me e Chloe scattata davanti al Christ Church l’ultimo giorno prima che lei e i nostri genitori ripartissero. Mia sorella è castana come me, ha i capelli
lunghi fino alle spalle come me, e i miei stessi occhi grigio-azzurri. Lei però mette il ketchup su tutto, gioca a lacrosse, suona il violino e vuole diventare ingegnere civile. Ci vogliamo bene, io e Chloe, ma non abbiamo nessun interesse in comune. Nemmeno il ketchup.
Passo il telefono a Isabel, che studia i nostri visi sorridenti.
«Ti somiglia» dice.
«Somigliamo entrambe a papà.» Riprendo il telefono e trovo una foto dei miei genitori, scattata lo stesso giorno. I riccioli rossi di mia mamma danzano al vento e lei sorride così tanto che ha gli occhi socchiusi. Papà, occhi azzurri e capelli castani con una spruzzata di grigio sulle tempie, le abbraccia le spalle. Le loro teste quasi si toccano.
Isabel studia anche quella foto, la memorizza. Poi mi restituisce il telefono. «Hai una bella famiglia, Kendra. È una fortuna e mi auguro che tu te ne renda conto.»
Non so mai cosa rispondere, quando mi dicono che ho una bella famiglia. Non è certo merito mio, quindi ringraziare mi sembra sciocco. Eppure la ringrazio e le sorrido, infilando di nuovo il telefono nella borsa.
«Allora» riprende Isabel, e sento che finalmente sta cambiando discorso. «Charles mi ha detto che lo scopo di questa intervista non è soltanto raccogliere materiale per una tesina.»
Ci metto un istante a fare il collegamento: Charles è il professor Briswell. «Sì, il mese prossimo corre il settantesimo anniversario della pace in Europa. Un altro professore del mio corso di laurea ha fatto un accordo con un giornale londinese. Le cinque tesine migliori tra quelle di fine semestre verranno pubblicate la settimana dell’8 maggio.»
Osservo attentamente la sua espressione per capire se questa informazione aggiuntiva mi causerà dei guai.
«Perciò quello che scriverai verrà letto da un vasto pubblico?»
«Soltanto se la mia tesina verrà scelta. Non posso esserne sicura. Ma se dovesse succedere, sarebbe un problema per lei?»
«Tu la scriverai con l’intenzione di entrare nella cinquina e vederla pubblicata?»
«Be’, sì.»
«E l’altro professore è amico di Charles? Ti sembra verosimile che giudichi il tuo lavoro soltanto per il suo valore? Sarebbe un peccato se scartasse la tua tesina perché è stato un collega ad aiutarti a trovare qualcuno da intervistare.»
Non ho ancora capito se la possibile pubblicazione della mia tesina su un quotidiano londinese stia giocando a mio favore oppure no. «Non so se siano amici. Immagino di sì, dato che insegnano nella stessa facoltà. Parlando con il professor Briswell, per caso è saltato fuori che ero in difficoltà con un altro corso e lui è stato così gentile da offrirsi di aiutarmi.»
Isabel si appoggia allo schienale del divano e si vede che è soddisfatta della mia risposta. «Che cosa ti ha detto Charles di me?» mi chiede.
Avevo già fatto tutte le ricerche necessarie sulle conseguenze che il Blitz aveva comportato per la popolazione femminile di Londra e, per finire di scrivere la tesina, mi serviva soltanto un’intervista. Quando la donna che stavo per intervistare è morta, ormai era troppo tardi per cambiare argomento perché sarei stata così indietro da non avere il tempo di terminare la tesina entro la scadenza. Era quello che avevo raccontato al professor Briswell, en passant, e lui mi aveva detto che avrebbe provato a convincere un’anziana amica di famiglia ad aiutarmi. Di solito non concedeva interviste, nemmeno quando si trattava dei suoi acquerelli, per cui era famosa in tutto il Sud-Est dell’Inghilterra. Il professore avrebbe fatto comunque un tentativo, spiegandole che ero alle strette. Ma secondo lui dovevo aspettarmi una risposta negativa.
«Mi ha detto che di solito non concede interviste» rispondo a Isabel.
Sorride. «Soltanto questo?»
«Anche che è famosa come pittrice di acquerelli. Anzi, mi lasci dire che ammiro molto le sue opere.»
«Ah, sì. Le mie ragazze con l’ombrello.»
Mi volto verso uno dei dipinti più in evidenza nel salotto: una ragazza in abito rosa passeggia in un campo di margherite luccicanti di rugiada con in mano l’ombrello bianco e rosso a pois, il suo marchio. Il sole fa capolino coraggiosamente tra le nuvole gonfie. «Ha sempre dipinto ragazze con l’ombrello?»
«No, non sempre.» Mi risponde subito, senza esitazione. Ma il modo in cui indugia sull’ultima parola mi lascia capire che c’è di più, dietro quella risposta. Eppure non aggiunge altro.
«Dimmi, Kendra» riprende, dopo una pausa. «Che cosa vorresti sapere del grande bombardamento di Londra? Immagino che siano state scritte decine di libri sull’argomento. Che informazioni cerchi, che non ci sono in un libro?»
Cerco di inventarmi una risposta. «A parte il fatto che intervistare qualcuno è uno dei requisiti di questo corso, secondo me… Insomma, secondo me le informazioni sono soltanto la metà di qualsiasi storia che coinvolga degli individui. L’altra parte è la loro esperienza personale. Non si può chiedere a un libro cosa voglia dire sopravvivere a un bombardamento.»
Isabel inclina la testa. «È questo che mi vuoi chiedere? Com’è stato vedere la mia casa bombardata?»
Mi accorgo allora di aver fatto una domanda elementare, che prevede una risposta altrettanto elementare. All’improvviso metto in dubbio tutte le mie domande. Guardo il quaderno che ho appoggiato sulle gambe e tutto quello che ho scritto mi sembra superficiale.
Com’era stare nel rifugio, una notte dopo l’altra?
Avevate paura?
Ha perso qualcuno cui voleva bene?
Vi chiedevate se sarebbe mai finita?
«Hai intenzione di accendere quel coso?»
Alzo la testa di scatto. Isabel sta indicando il registratore sul tavolino da caffè. «Le dà fastidio?»
«Visto che l’hai portato, tanto vale usarlo.»
Mentre mi chino per premere REC, il quaderno mi scivola dalle gambe e finisce a terra, sullo spesso tappeto persiano.
Raccogliendolo, mi rendo conto che c’è una sola domanda da fare a questa donna che da settant’anni rifiuta tutte le interviste e che neanche dieci minuti fa, quando ha spedito fuori Beryl, mi ha detto chiaro e tondo che è disposta a raccontare soltanto quello che vuole lei.
Appoggio il quaderno sul cuscino del divanetto, accanto a me. «C’è qualcosa che vuole raccontarmi della guerra, Isabel?»
Lei mi sorride, compiaciuta e forse colpita dalla rapidità con cui ho capito che quella è l’unica domanda cui risponderà.
Aspetta giusto un istante, poi mi dice: «Tanto per cominciare, non ho novantatré anni. E non mi chiamo Isabel».
2
Emmy
Londra, 1940
L’abito da sposa nella vetrina del negozio spumeggiava come champagne appena stappato, una cascata di bollicine che scendeva verso Emmy Downtree, in piedi davanti al vetro rotto. Le schegge scintillanti erano sparse tutto attorno all’ampia gonna e sembrava quasi che ne facessero parte. Dietro il manichino dall’espressione imbronciata si irradiavano nastri gialli che simulavano un sole dorato e ignaro. Anche ai piedi di Emmy, sul marciapiede, le schegge minacciose erano disseminate ovunque. Un biglietto scritto a mano – un’offerta di lavoro – ancora parzialmente appiccicato a uno spigolo tagliente, si protendeva in avanti verso lo stipite della vetrina e la quindicenne Emmy si inginocchiò per strapparlo con cautela. Dall’interno si sentiva la proprietaria del negozio parlare al telefono con la polizia, pretendendo che le dessero retta. Durante la notte le avevano sfondato la vetrina.
Julia, la sua sorellina di sette anni, alzò lo sguardo verso Emmy. «Perché ai tedeschi non piacciono gli abiti da sposa?»
Emmy non trovò per nulla ridicola la supposizione che fosse stata la Luftwaffe a frantumare la vetrina. Era un anno ormai che convivevano con gli allarmi antiaereo, le esercitazioni a scuola e le finestre oscurate. Avevano passato tante nottatacce rannicchiate con la mamma nel rifugio più vicino a casa, con gli altri abitanti della via, ogni volta che un’incursione sembrava imminente. Emmy e sua
sorella erano andate a scuola con la maschera antigas per un semestre intero. Dunque non era tanto incredibile che Julia, vedendo la vetrina frantumata, avesse concluso che alla fine le minacce si erano concretizzate.
Emmy si rialzò in piedi con il foglietto in mano. «Non sono stati i tedeschi, Ju. Sulla strada non ci sono altre vetrine rotte. Guarda. Dev’essere stata una macchina che è salita sul marciapiede. Il guidatore ha premuto l’acceleratore invece del freno. Qualcosa del genere.»
Julia non staccava lo sguardo dalla vetrina frantumata. «Sei sicura?»
«Sicurissima. Altrimenti avremmo sentito le sirene, no? Invece ieri sera non si è sentito niente.»
Era più di una settimana che le sirene tacevano e il ronzio sordo della Luftwaffe sopra di loro non si sentiva da almeno due. Era tutto tranquillo come quasi un anno prima, quando la guerra era ancora una vaga novità.
«Ormai quel vestito non lo vorrà più nessuno» disse Julia, apparentemente soddisfatta di sapere che, dopotutto, i nazisti non ce l’avevano con gli abiti da sposa. «È pieno di vetri.»
«Basta scuoterlo e cadranno. Scommetto che la sposa che lo comprerà non lo saprà mai.» Emmy staccò una scheggia dall’annuncio e lesse la scritta in piccolo. «Cuciture a mano e modifiche. Otto/dieci ore settimanali. Domandare all’interno.» Era la prima volta che lo notava e si chiese da quanto tempo osse esposto. Dovevano essere pochi giorni. Emmy si fermava abbastanza spesso davanti alla vetrina del Primrose Bridal da sapere che l’annuncio era nuovo.
«Io non me lo metterei, quel vestito. I tuoi mi piacciono pure di più. Sono più belli.»
Emmy scoppiò a ridere. «Davvero?» Guardò all’interno, oltre la vetrina in frantumi, la donna che insisteva perché le mandassero immediatamente un poliziotto.
«No, non è stata una rapina.» La sua voce arrivava forte e chiara fino al marciapiede. «Non è questo il punto! Mi hanno frantumato la vetrina.»
«Questo è troppo gonfio» ribadì Julia. «I tuoi sono più belli.»
«I miei sono soltanto disegni, Ju. Difficile dire come sarebbero nella realtà.» Emmy guardò verso la farmacia sull’altro lato della strada stretta e attraverso la vetrina vide la mamma, alla cassa. Sarebbe uscita di lì a poco. Rimise a posto l’annuncio, ma lo appoggiò a faccia in giù. Aveva intenzione di tornare quando la proprietaria non avrebbe avuto altre cose cui badare, portandosi dietro i suoi figurini migliori, casomai pretendesse una prova tangibile che valeva la pena di prenderla in considerazione.
«Comunque i tuoi sono più belli» concluse Julia.
Annie Downtree uscì sul marciapiede di fronte. Attraversò la strada tra le auto che si muovevano lente per raggiungere le sue figlie. Un uomo su una lucida Citroën blu si toccò il cappello fermandosi per lasciarla passare. Emmy notò che il guidatore passava in rassegna i riccioli color miele di sua madre, la sua vita sottile, le gambe lunghe e le caviglie snelle. Con soltanto sedici anni di differenza, ultimamente le scambiavano per sorelle. All’inizio Emmy ne era infastidita, ma presto si era resa conto che il fraintendimento, per lei, significava passare per l’adulta che si sentiva pronta a diventare. Prima si fosse resa indipendente da sua madre e prima avrebbe potuto scegliere i propri sogni. Sua madre, del resto, con lei si comportava come una sorella, le confidava i suoi segreti e un istante dopo ritrattava,
leggeva le riviste e fumava mentre Emmy preparava la cena, quando le andava rincasava tardi la sera e si consigliava con la figlia su come comportarsi con Neville, il suo amante a singhiozzo e padre di Julia. La mamma dispensava le sue competenze materne soprattutto con la figlia piccola, che non era mai stata scambiata per sua sorella.
«Andiamo» disse, quando raggiunse le figlie. Aveva infilato nella borsetta il pacchettino bianco ritirato per conto della signora per cui lavorava.
«Mamma, guarda cos’è successo al negozio di abiti da sposa» le disse Julia, agitata.
La mamma lanciò un’occhiata niente affatto interessata alla vetrina in frantumi. «Mi dispiace per loro, ma tanto di questi tempi non si sposa nessuno. Andiamo. Devo ancora passare dal macellaio prima di andare al lavoro. La signora Billingsley ha preteso un prosciutto.»
«Non è vero» disse Emmy.
La mamma, già avanti di qualche passo, si girò appena. «Sì che è vero. Te l’ho detto ieri che oggi avrei dovuto lavorare.»
«Intendevo che non è vero che non si sposa nessuno. Se fosse vero, il negozio avrebbe chiuso.» E la proprietaria non cercherebbe un’aiutante.
«Per l’amor del cielo, Emmy. Siamo in guerra, casomai te ne fossi dimenticata.» Si voltò di nuovo a guardare avanti e si rimise a camminare di buona lena.
«Ma non sono stati i tedeschi a rompere la vetrina!» insistette Julia.
La mamma si voltò senza rallentare il passo, ancora più accigliata. «Che cosa le hai messo in testa, Emmy?»
«Non le ho messo in testa un bel niente. Mi ha chiesto se i tedeschi hanno bombardato il negozio e le ho detto di no.»
La mamma sospirò e proseguì.
«Ci piace guardare i vestiti da sposa» disse Julia. «Non vogliamo andare dal macellaio.»
«A me invece piace guardare i gioielli della Corona» ribatté la mamma, senza voltarsi.
Emmy distolse lo sguardo dai resti della vetrina, dai metri di organza e dall’annuncio girato a faccia in giù.
Julia prese la mano di sua sorella mentre si allontanavano dal negozio facendo scricchiolare le schegge argentee sotto le scarpe. «Non mi piace la macelleria. Puzza di cose morte. Non mi piace.»
«Aspettiamo fuori.»
Avevano fatto appena una decina di passi quando Emmy sentì il fruscio di una scopa e il tintinnio dei vetri contro il bordo della paletta. Poi ci fu un grido, seguito da un’imprecazione sussurrata. Emmy si voltò e vide la scopa cadere sul marciapiede. La proprietaria del negozio si teneva una mano con l’altra e sul viso aveva una smorfia, non tanto di dolore quanto di fastidio. Scopa e paletta giacevano ai suoi piedi.
«Raggiungi la mamma.» Emmy lasciò Julia e tornò sui suoi passi, avvicinandosi alla donna. Una riga rossa le attraversava il palmo della mano, dove si era tagliata con una scheggia.
«Sta bene, signora?» le chiese Emmy.
«Sì, sì» borbottò la donna tirando fuori un fazzoletto dalla tasca del vestito e scuotendolo per spiegarlo. Se lo premette sul palmo. Emmy si chinò per prendere scopa e paletta.
«Stai attenta! Non ha senso che ci affettiamo una mano tutte e due.»
«Ha bisogno di aiuto? Posso pulire io, intanto che lei si medica.»
La donna la osservò attentamente, quasi non si aspettasse tanta gentilezza spontanea da parte di un’estranea. Poi la riconobbe e spalancò gli occhi.
«Io ti conosco. Ti ho visto guardare dentro la mia vetrina, vero? Diverse volte.»
Emmy arrossì. «Sì, signora. Mi piacciono… i suoi abiti. Spero di avere anch’io un negozio come il suo, un giorno.»
La donna le sorrise mentre si avvolgeva il fazzoletto attorno alla ferita e una macchia scarlatta cominciava a inzupparlo. «Ti auguro di cuore che il futuro ti riservi tempi migliori.» Indicò la vetrina frantumata con un cenno del capo. «Come vedi, gestire un’attività in proprio non è sempre rose e fiori. Soprattutto in tempo di guerra. Adesso scusami, devo andare a cercare una garza. Penserò dopo a pulire. Ma grazie.» Fece per rientrare in negozio.
«Ho visto che cerca un’aiutante» azzardò Emmy.
La donna si voltò, ma con scarso interesse. «Sì, è vero.»
Emmy deglutì per scacciare il nervosismo. «Posso tornare più tardi per parlarne?»
La donna esitò. «Quanti anni hai?»
«Quasi sedici.» Era una piccola bugia che le uscì di bocca senza che riuscisse a frenarsi. Mancava quasi un anno al compleanno successivo. Ma una quindicenne era ancora una bambina. Una quindicenne poteva essere costretta a sfollare.
«Hai esperienza?»
Emmy deglutì di nuovo. «Un pochino.»
Premendosi più forte il fazzoletto sulla mano, la proprietaria del negozio annuì. «Torna alla chiusura e ne parliamo. Alle sei. Mi servono delle referenze.»
«Ah, va bene. Allora alle sei. D’accordo» balbettò Emmy, che già tremava all’idea di dover convincere la donna che i suoi schizzi di abiti da sposa valessero come referenze.
«Sono la signora Crofton e non mi piacciono i ritardatari. Lascia pure qui la scopa e la paletta.»
«Io sono Em… Emmeline Downtree. Sarò qui alle sei in punto. Grazie, signora Crofton.»
La proprietaria rientrò nel suo negozio salutandola con un cenno, senza aggiungere una parola. Emmy appoggiò scopa e paletta allo stipite della vetrina senza vetro e si allontanò, meravigliata dal colpo di fortuna che le era capitato. Ormai era quasi un anno che, nel giorno di spesa, sbirciava la vetrina della Primrose Bridal, rapita dagli abiti fatati indossati dai manichini o appesi alle grucce imbottite. La scoperta di quell’affinità aveva oscurato il piacere di scarabocchiare vestitini durante le lezioni di Matematica e di fare innumerevoli bamboline di carta per Julia. Sua mamma era il tipo che passava davanti a quei negozi senza degnarli di uno sguardo, non tanto per la fretta quanto perché le erano indifferenti. Non si era mai sposata ed Emmy dubitava che, se un giorno l’avesse fatto, avrebbe
indossato un abito bianco. Per un istante Emmy fu tentata di ringraziare il mascalzone che aveva frantumato la vetrina e messo in moto la catena di eventi che aveva portato all’appuntamento di quella sera.
Girò l’angolo e per poco non si scontrò con Julia.
«Perché non sei con la mamma?» le chiese, senza fiato.
Julia la guardò, imbronciata. «Non mi piace il macellaio. Non mi piace l’odore che c’è nel suo negozio.»
Emmy afferrò la mano di sua sorella e la trascinò lungo il marciapiede. «Dovevi fare come ti ho detto.»
«Perché parlavi con la signora?»
«Adesso non ha importanza.»
«Ma ti ho visto, che le parlavi.»
«Le ho soltanto chiesto se voleva aiuto per raccogliere i vetri.»
«Si è tagliata.»
«Sì.»
Emmy accelerò il passo. La mamma le avrebbe sgridate per averci messo così tanto, ma almeno non avrebbe chiesto spiegazioni.
A lei non interessava sapere perché a Emmy piaceva guardare le vetrine dei negozi di abiti da sposa.
3
Emmy era davanti allo specchio nella stanza del piano di sopra che condivideva con Julia. Studiava il vestito che aveva preso nell’armadio di sua madre. L’aveva stirato, ma pur avendo eliminato tutte le pieghe, non era riuscita a eliminare il suo profumo: un effluvio floreale, stantio, che sembrava un invito. Quell’abito blu scuro con il colletto e i polsini avorio non era il suo preferito, nel guardaroba della mamma, però era più alla moda di tutto quello che c’era nel suo e sperava spudoratamente che nel tessuto fosse ancora impregnata un po’ di fortuna. La mamma lo aveva indossato due anni prima, quando era andata a fare il colloquio per un posto di lavoro nella cucina di una vedova milionaria, la signora Billingsley, e l’avevano assunta. Era un particolare che Emmy avrebbe potuto dimenticare, non fosse stato che la nonna era ancora viva ed era venuta a trovarle.
Era una bollente giornata di luglio e la guerra era ancora soltanto uno spiacevole disaccordo tra qualche Paese europeo. La mamma della mamma, arrivata dal Devonshire, stava insegnando a Emmy a ricamare. Le bambine la vedevano soltanto quando veniva da loro e non capitava spesso. A Emmy piacevano le sue visite, anche se lei e la mamma litigavano per quasi tutto. Era sempre triste quando la nonna ripartiva, ma almeno in casa tornava la pace. Quel pomeriggio la mamma era uscita dalla sua stanza con indosso il vestito blu scuro e si era messa in posa, come una modella, davanti alle figlie e a sua madre. Julia era scoppiata a ridere e la mamma pure. La nonna però aveva scosso la testa e le aveva detto che non era saggio puntare troppo in alto. Fino ad allora la mamma aveva lavorato nella
lavanderia di un albergo. A quanto ne sapeva Emmy, non aveva mai lavorato in una cucina. E di certo non aveva mai lavorato per una persona ricca.
«E perché no?» La mamma aveva aperto uno specchietto e si era passata il rossetto sulle labbra. Era sicura di sé come non mai.
«Un’ereditiera integerrima è una datrice di lavoro ben diversa da un albergo sempre pieno di gente.»
La mamma aveva chiuso lo specchietto di scatto. «Cosa vorrebbe dire?»
«Sei una ragazza madre» aveva detto la nonna a voce bassa, come se i muri della cucina potessero sentire la scandalosa verità e diffondere la notizia in tutta Londra. «Non è una cosa trascurabile. Se la signora Billingsley controlla le tue referenze, di sicuro scoprirà che le tue figlie sono nate da padri diversi e che non sei stata sposata con nessuno dei due.»
La mamma aveva socchiuso gli occhi e aveva guardato Emmy sorridendo con aria cospiratoria, come una sorella maggiore. Aveva ringraziato la nonna per il suo amorevole consiglio materno e se n’era andata sbattendo la porta.
La nonna aveva chiesto a Emmy dove avesse preso quel vestito.
Emmy non lo sapeva. A volte nel guardaroba di sua madre comparivano vestiti nuovi.
«E non ti sei mai chiesta da dove vengano?»
«Dice che glieli danno le persone con cui lavora, quando si stancano di indossarli.»
«Senz’altro» aveva borbottato la nonna, procedendo poi a mostrare a Emmy come fare un perfetto punto raso.
Un’ora dopo, mentre Emmy lavorava a un lungo centrino rettangolare e la nonna mostrava a Julia la sua scatola di legno piena di matassine colorate di filo da ricamo, la mamma era tornata, raggiante, con un’uniforme nera sul braccio.
La nonna era impallidita. «Ti hanno preso?»
Emmy era rimasta meravigliata dalla paura nella voce della nonna.
«Non capisco perché dovrebbe sorprenderti» aveva risposto la mamma. «Guarda che sono capace di far bollire l’acqua.»
«Certo, e non è l’unica cosa che sai fare» aveva detto la nonna, a bassa voce. Era stato quasi un sussurro, quasi.
La mamma si era voltata, dopo aver appoggiato l’uniforme sullo schienale di una sedia della cucina. «Cos’hai detto?»
«Niente.»
La mamma, calmissima, era andata a spalancare la porta d’ingresso. «Fuori.»
Emmy aveva guardato le due donne, prima una e poi l’altra; doveva esserle sfuggito qualcosa.
Le labbra della nonna si erano assottigliate in una linea tesa. Aveva chiuso la scatola dei fili da ricamo e l’aveva spinta verso Emmy. «Esercitati con questi punti, Emmeline» le aveva detto. «Almeno avrai qualcosa di costruttivo da fare mentre tua madre è fuori a guadagnarsi da vivere.»
Poi aveva dato un bacio a Julia e se n’era andata. Era stata l’ultima volta in cui Emmy l’aveva vista. Quattro mesi dopo era morta di infarto. Era arrivato un telegramma dello zio Stuart, il fratello maggiore della nonna che Emmy non aveva mai conosciuto, con la notizia del decesso. La mamma l’aveva letto, l’aveva appoggiato sul tavolo e si era chiusa in camera sua. Non si era fatta vedere per ore. Quando era uscita, Emmy aveva un mucchio di domande. Julia, a cinque anni, ne aveva soltanto una: dov’è la nonna? La mamma non aveva risposto a nessuna delle domande di Emmy. A Julia aveva detto che la nonna era in paradiso, dove tutto era perfetto, dunque almeno lì si sarebbe sentita a proprio agio. Emmy non aveva capito per cosa avessero litigato sua madre e sua nonna, quell’ultima volta. Sua madre era stata assunta per lavorare in cucina e non faceva nulla di diverso. La nonna invece sembrava aver insinuato che per quel nuovo posto di lavoro stesse facendo qualcosa di male; ma la signora Billingsley era una vedova rispettabile, la sua casa non era certo un bordello. E comunque, non c’erano uomini nella vita di Annie Downtree, non da quando il padre di Julia l’aveva lasciata, un anno prima.
Non molto tempo dopo la morte della nonna, Emmy era al tavolo della cucina a ricamare settembrini su una federa. La mamma, che stava uscendo per andare al lavoro, si era fermata a guardare la colorata collezione di filati nella scatola e aveva chiuso il coperchio sbattendolo. Da quel momento, Emmy aveva sempre tenuto la scatola in camera sua e di Julia…
Susan Meissner è nata a San Diego, in California, e si è laureata alla Point Loma Nazarene University. È sposata con un cappellano militare dell’Aeronautica e ha quattro figli. Oltre a scrivere romanzi, tutti di grande successo, organizza gruppi di scrittura creativa e di lettura. In questa collana è già apparso La sciarpa ricamata.
ebook a soli 8,99
Apprezzi il mio lavoro?
Librichepassione.it è affiliata ad Amazon. Se acquisterete dai links presenti nel sito, riceverò’ una piccola percentuale che mi aiuterà a pagare le spese per la gestione del sito. Il prezzo di acquisto per voi rimarrà lo stesso, senza aver alcun sovrapprezzo.
E’ anche possibile fare una donazione attraverso Paypal
Grazie per la vostra preziosa collaborazione!