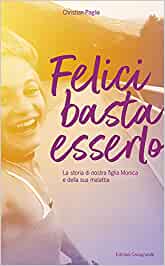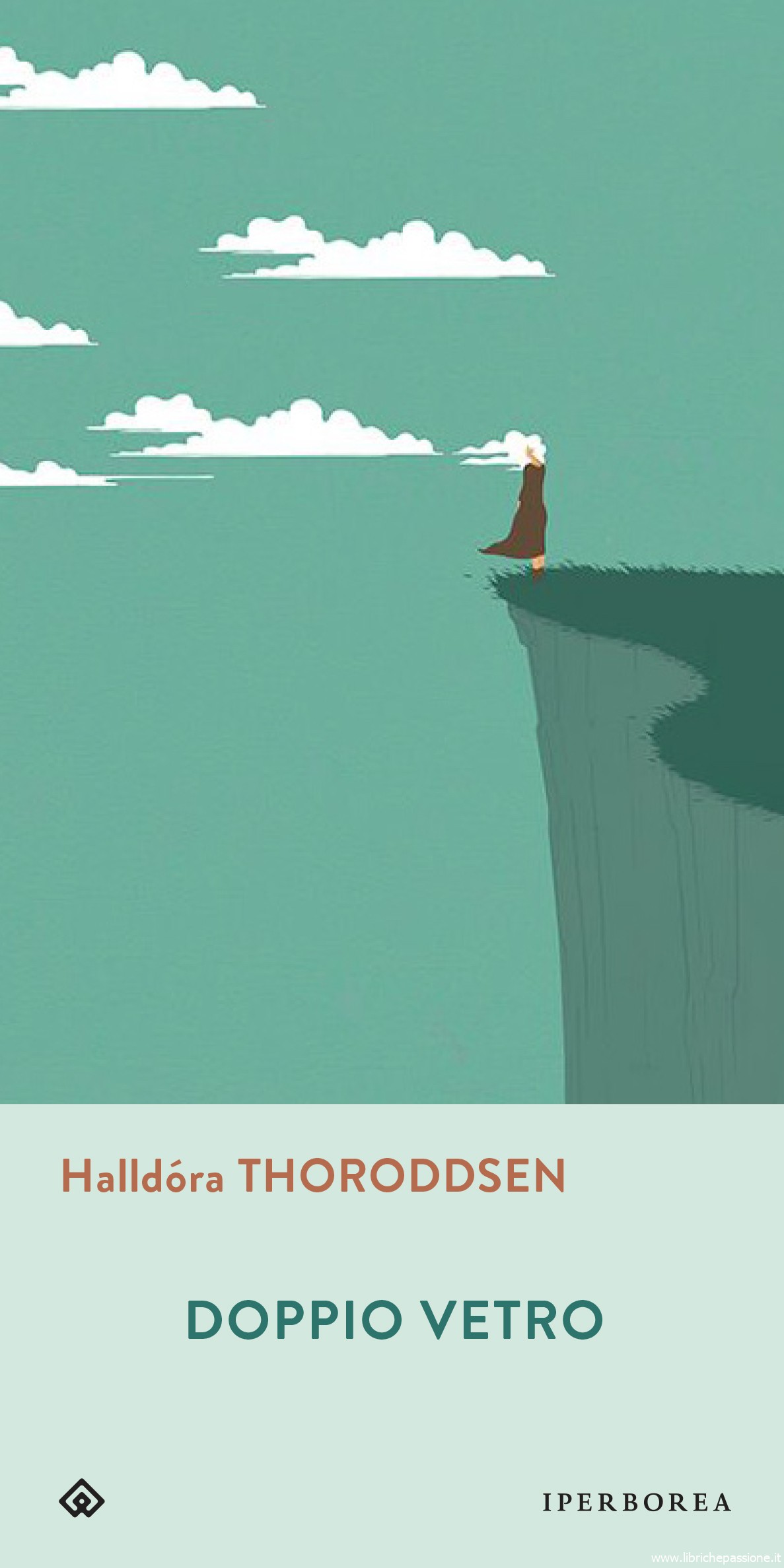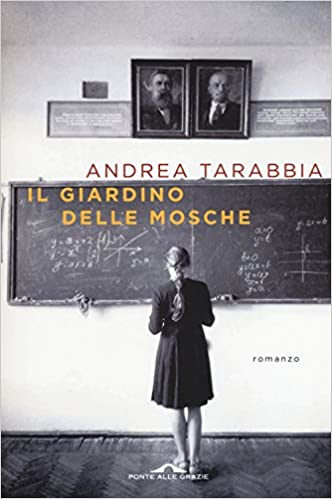

Tra il 1978 e il 1990, mentre in Unione Sovietica il potere si scopriva fragile e una certa visione del mondo si avviava al tramonto, Andrej Cikatilo, marito e padre di famiglia, comunista convinto e lavoratore, mutilava e uccideva nei modi più orrendi almeno cinquantasei persone. Le sue vittime bambini e ragazzi di entrambi i sessi, ma anche donne – avevano tutte una caratteristica comune: vivevano ai margini della società o non si sapevano adattare alle sue regole. Erano insomma simboli del fallimento dell’Idea comunista, sintomi dell’imminente crollo del Socialismo reale. Questo libro, sospeso tra romanzo e biografia, narra la storia di uno dei più feroci assassini del Novecento attraverso la visionaria, a tratti metafisica ricostruzione della confessione che egli rese in seguito all’arresto. E fa di più. Osa raccontare l’orrore e il fallimento in prima persona: Cikatilo, infatti, in questo libro dice “io”. È lui stesso a farci entrare nella propria vita e nella propria testa, a svelarci le sue pulsioni più segrete, le sue umiliazioni e ossessioni. “Il giardino delle mosche” è un libro lirico e crudele allo stesso tempo: la storia di un’anima sbagliata, una meditazione sul potere e la sconfitta e, soprattutto, una discesa impietosa fino alle radici del Male.

Se c’è un Dio, come sopportare di non esserlo?
Albert Camus, L’uomo in rivolta
E allora, e senza preavviso, la grande, feroce solitudine che dormiva in lui si raccolse e lo colpì.
William Faulkner, Le palme selvagge
La mia vita è collegata alla vita del Paese
Andrej Čikatilo, domanda di grazia al presidente El’cin, 18 luglio 1992
La morte per fame
(1936-1978)
I.
Per molto tempo, non so più nemmeno quanto, io ho vissuto in luoghi astratti. Stavo qui, nella mia casa o sul posto di lavoro, eppure non c’ero, disse, ero altrove. Io mi svegliavo – perché senza dubbio la mattina mi svegliavo – e avevo la sensazione di non esserci, come se il sonno mi avesse rubato o continuasse a esistere durante la veglia. Facevo ogni cosa come se al posto mio ci fosse qualcun altro. Lei deve credermi: era come se non sapessi chi ero. Questo le chiedo, di ascoltarmi e credermi, ma non mi domandi, non ancora, perché io mi sia deciso a raccontare. Ci saranno cose, da qui in avanti, se avrà pazienza e se avrò la forza di continuare, a cui non vorrà credere (fatico io stesso!), ma le assicuro che è tutto vero. Tutto è successo e succede, e voglio che sia chiaro da subito che ogni cosa che ho fatto, ciò che sono diventato, mi fa tremare. Io poi ho sempre fatto fatica a ricordare: sul lavoro, per esempio, mi appuntavo ogni cosa e poi dimenticavo dove avevo lasciato il biglietto. Anche quello è un luogo astratto. È stato così per anni: a volte per via di questa mia sbadataggine perdevo le commesse, o non ero pronto a ricevere le consegne. Per questo molti si lamentavano di me, i colleghi e i dirigenti scrivevano delle lettere al soviet in cui dicevano che il compagno Čikatilo era uno sfaticato, un sabotatore, uno che lavorava poco e male per rallentare la produzione e per questo bisognava sollevarlo dall’incarico. Io invece sono sempre stato un comunista, fin dalla prima infanzia ho vissuto e lavorato e lottato per la nostra Grande Causa Comune. Ho dato tutto a questo Paese, tutto, fin dal momento della mia nascita. In cambio ho ricevuto… no, non è ancora il momento per questo: ci sarà tempo per ogni cosa.
Dicevo che sono uno che dimentica. Tuttavia questi fatti, questa storia e questi nomi io me li ricordo – li ricordo tutti uno per uno, anche se in certi momenti della mia vita avrei voluto dimenticarli e fare come se non fosse successo niente. Anche adesso vorrei averli dimenticati, e invece sono tutti qui, davanti a me e a questo dito che mi duole e non si muove, e mi pare quasi, con un piccolo sforzo di concentrazione, di riuscire a ricordare perfino le circostanze in cui sono venuto al mondo, sul tavolo della nostra baracca a Jabločnoe. Sento le grida di quella donna che sarebbe diventata mia madre, e quasi la vedo, con le cosce magre e le caviglie gonfie, e vedo un pezzo di pane
raffermo che è caduto per terra e si è macchiato di sangue e placenta e so che qualcuno, forse proprio la mamma, tra poco lo mangerà, perché ogni cosa che si può mangiare deve essere mangiata. La donna che mi levò dalla pancia non mi aveva ancora pulito con il suo grembiule che la mamma, esausta, chiedeva del pane e un po’ d’acqua.
«Acqua ce n’è, compagna, ma non c’è pane» le rispose la mia levatrice.
Sul tavolo sporco di sangue e vergogne, la mamma si era liberata della presa dell’altra donna, una ragazzina che le aveva tenuto la testa mentre mi partoriva, e aveva bevuto da una tazza ricavata dalla scorza di una betulla. La ragazzina aveva gli occhi cerchiati di blu – il blu profondo che c’è nelle voragini che si aprono nelle strade – e, mentre io stavo sospeso, nudo, in mano alla levatrice, non aveva il coraggio di guardarmi.
«È vivo?» aveva chiesto la mamma, ma solo dopo aver bevuto.
«Speriamo di sì» aveva risposto la levatrice, e mi aveva picchiato sulle natiche.
Io mi ero messo a urlare e a piangere, espettorando il blocco catarrale che mi ostruiva i polmoni e la prima cosa che vidi, nella concitazione e nella tragedia del mio primo minuto di vita, furono proprio i solchi blu della ragazza che si ostinava a non guardarmi.
«Ho fame» diceva intanto la mamma. «Ho fame e voglio dormire».
«Avrai tempo per far tutto, compagna» aveva risposto la donna. «Ma non c’è pane. C’è solo quel pezzo che è caduto».
«Lavalo e dammelo».
La ragazza cerchiata di blu, senza dire niente, gliel’aveva dato, e la mamma ci aveva infilato i denti che le erano rimasti.
«Lo vuoi?» le aveva chiesto la levatrice, che mi teneva ancora per le gambe come si tengono i vitelli. Io avevo già smesso di piangere, perché ero spossato. «Bisognerà dargli del latte» aveva aggiunto la donna che mi aveva levato.
«Mettimelo vicino» aveva detto la mamma. «Ma latte non ne ho. Roman è andato al kolchoz per recuperarne un po’».
Così ero andato in braccio alla mamma mentre masticava il pane caduto nel sangue. Il momento più importante della vita di un uomo è la nascita, e quando dice la prima parola, e quando impara a camminare: eppure non li ricordiamo. Questa forma di oblio è, per me, la prima mutilazione a cui veniamo condannati nel momento stesso in cui veniamo al mondo. Per anni viviamo senza sapere come siamo nati, e che, per esempio, c’è stato un momento in cui le gambe hanno cominciato a sorreggerci. Invece io sono nato ed ero magrissimo e quasi non piangevo perché non ne avevo la forza. Ma c’ero, e fui uno dei primi bambini nati vivi nell’Ucraina orientale dopo la prima delle grandi carestie. Eccolo qui, il bambino, è un maschio: si chiamerà Andrej (che significa «uomo forte», «uomo virile»), e quello impresso nel mio nome non è che uno sberleffo crudele, la seconda mutilazione che dovetti sopportare non appena fui messo al mondo.
Ma lei non vuole che io parta dall’inizio. Allora le dirò che è stato nel 1978 che ho cominciato a fabbricare mosche. Era quasi la fine di dicembre e perché proprio le mosche non lo so dire. Io non ho mai amato gli animali, non ho quasi mai pensato a loro e non ne ho mai avuti. Ma le mosche, con le mosche è diverso: c’è stato un tempo, molti anni fa, in cui sembrava che tutto il mondo non fosse altro che lo spazio che c’è tra una mosca e l’altra. Dalla fetta di pane che mia madre mangiò, quando la ragazza cerchiata di blu la raccolse per lavarla, si sollevò in volo una nuvola di mosche grasse, che per via della mole e dell’ingordigia volarono via lentamente: tutti rimanemmo fermi a guardarle mentre, con il passo sazio di un bue, cercavano di volar via attraverso la porta. Così, per qualche motivo, nel 1978, quando il numero delle mosche era molto diminuito e tutti quanti noi stavamo meglio, io ho cominciato a costruirle. Non è difficile: ci vogliono solo pazienza ed esercizio e, almeno fino a che non si diventa un po’ esperti, dei materiali malleabili.
È per questo che la sera del 24 dicembre sono uscito a cercare del rame. Volevo camminare nel gelo e distrarmi. Naturalmente non ho raccontato a Fenja la storia delle mosche, e nemmeno ai ragazzi. Semplicemente mi sono alzato da tavola, dopocena, e ho detto: «Fenja, non trovo le soprascarpe».
«A cosa ti servono?» ha chiesto lei. «Non starai uscendo?» Si era messa a lavare i piatti, aveva le mani immerse nell’acqua calda e la faccia arrossata dal vapore.
«Vado a fare due passi. Così, per sgranchirmi».
«Andrjuša, c’è ghiaccio sulle strade, e ho sentito che stanotte nevicherà». Si era fermata e aveva spento l’acqua corrente. Jura, che allora aveva nove anni, stava seduto in poltrona e ci guardava.
«Ma non starò via per molto» ho detto. «Dove sono le mie soprascarpe?»
Vicino a me, Ljudmila aveva afferrato la scopa e si era messa a spostare le sedie per pulire. Lo dico perché mi ricordo, tra i suoni di quel momento, lo strofinio delle setole di sorgo sulle piastrelle del pavimento. Sono rimasto in piedi al centro della stanza, in silenzio, mentre mia figlia, senza aprire bocca, mi girava attorno con la scopa. Fenja si era sfilata i guanti di gomma e «Non capisco proprio perché tu debba uscire a quest’ora e con questo freddo» ripeteva.
«Ti ho chiesto le soprascarpe» ho detto mentre Ljudmila, come astratta, mi passava vicino e non mi guardava.
«Ma non puoi rimanere a casa con noi?»
Mentre osservavo Fenja che andava verso il bagno, le ho ripetuto che sarei stato via per poco tempo. È ricomparsa dopo pochi secondi con le dita infilate nelle mie soprascarpe.
«Eccole qua» ha detto, gettandomele ai piedi. «Le avevo messe nel bagno ad asciugare, ma con il tempo che c’è sono ancora umide. Se le ribagni, domattina non le potrai mettere per andare al lavoro».
Mi sono avvicinato alla porta per indossarle, mentre Jura mi chiedeva se poteva guardare uno dei miei libri intanto che aspettava di andare a letto. «Uno di quelli là in alto, con le figure» ha detto, indicando lo scaffale più alto della nostra misera biblioteca. Mi sono trascinato con le soprascarpe umide sul pavimento e gli ho preso, senza pensarci, un vecchio manuale sulla pittura olandese che aveva ancora sulla costa l’etichetta della biblioteca dell’Istituto Professionale n. 32 di Novošachtinsk.
«Che cos’è, papà?» ha domandato Jura.
«È un libro con i quadri» ho risposto. «Comincia a guardarlo tu, tra poco torno e lo sfogliamo insieme».
Se lo è messo sulle gambe e lo ha aperto in un punto dove era riprodotto un enorme dipinto pieno di colori, e laghi, e strani animali, e frutti, e uomini e donne nudi. Nel centro del quadro, attorno a una pozza d’acqua circolare, gli uomini e le donne cavalcavano in cerchio in sella ad animali di ogni specie tranne quella dei cavalli: leopardi, leoni, cervi, asini e altre bestie che non appartengono al nostro tempo e al nostro spazio. In basso, altre figure umane erano avvinghiate sopra il prato in un’orgia, o in una danza, e a quest’orgia e a questa danza prendevano parte anche le bestie, le piante e i frutti. Per un istante, Jura è rimasto come assorto: osservava quei corpi nudi e quelle bestie e qualcosa lo tratteneva dal voltare pagina. All’improvviso, il suo viso è avvampato, ma come in ritardo, come se uscisse da un sogno che si vergognava di aver sognato. Dalla poltrona, si è sforzato di non sollevare lo sguardo verso di me.
«Non guardare questo quadro» gli ho detto, pacato. «Nel libro ce ne sono molti altri».
Teneva gli angoli delle pagine tra le dita e non aveva il coraggio di chiudere il volume. Poi mi ha guardato negli occhi, ed era come se non mi volesse dire qualcosa che aveva capito all’improvviso.
«Perché sono tutti nudi, papà?» ha avuto infine il coraggio di chiedere.
«Ti ho detto: è meglio che non guardi questo quadro, Jura. È difficile da capire per un bambino».
Avevo rubato quel libro alla biblioteca della scuola poco prima che mi cacciassero. Lo avevo notato tra le mani dell’insegnante di storia dell’arte e, come Jura, all’inizio ero rimasto turbato dalle immagini che avevo intravisto. Così avevo cominciato a prenderlo in consultazione nelle ore libere, finché avevo deciso che, visto che mi avrebbero allontanato, lo avrei portato con me per vendetta. Quel libro è un’altra delle mie mutilazioni. So bene che il furto è uno dei reati più gravi che si possano commettere in Unione Sovietica: ma io avevo sottratto un bene a una collettività che mi aveva espulso e cacciato. È stata, questa, forse la prima e unica rivincita che io, Andrej Čikatilo, mi sono preso nel corso di una vita di umiliazioni e allontanamenti. A lungo, finché non decisi che avevo bisogno di qualcos’altro, la pittura fiamminga mi tenne compagnia nei periodi di solitudine – e per il momento questo è tutto ciò che ho da dire.
Sono uscito nella mezzaluce dei lampioni e c’era un vento che mi prendeva a schiaffi e mi spingeva indietro con le sue gigantesche mani d’aria: così, caracollando come un orso, sono andato verso la mia tana in vicolo Meževoj. È un rifugio segreto che ho comperato per millecinquecento rubli in un momento in cui, pur non avendo le idee chiare su come utilizzarlo, sentivo di volere un posto mio, solo mio. A lungo, Fenja e i ragazzi non hanno saputo niente della tana, e siccome in casa ero l’unico ad amministrare il denaro nessuno all’inizio si è accorto di nulla. Quando lo sono venuti a sapere era ormai troppo tardi. Anche adesso è tardi e forse, se ci penso, lo è sempre stato. La mia tana è poco più di una baracca, vi si accede per mezzo di alcuni gradoni di terra su cui sono stati infilzati dei tramezzi di legno per fare in modo che il gradone non crolli sotto il peso dei corpi e della neve. Dentro, nella mia tana, non c’è quasi niente: una lampadina che penzola dal soffitto e che ha l’aspetto di un impiccato la cui testa esplode di luce, un tavolo di legno con una (una) sedia, una branda su cui ho buttato nel corso degli anni tutte le coperte che sono riuscito a portare fuori di casa, un fornello da campo con un pentolino e una stufa a gas che grazie a dio ha sempre funzionato bene. La latrina, con un piccolo lavandino, è fuori, sul retro: d’estate lì dentro si muore di caldo, d’inverno si formano delle smisurate stalattiti di ghiaccio che penzolano dal tubo dello sciacquone, l’acqua del cesso si congela e non è possibile scaricare. Ma va bene così, io ho sempre vissuto con poco e non mi serve quasi niente. Ci sono andato, nella mia tana, perché il giorno prima, il 23 dicembre, mi era arrivata la voce che qualcuno aveva notato che la luce dell’unica stanza era rimasta accesa. Qui viene buio presto, d’inverno, ma non è normale che uno tenga accesa la luce per tutto il giorno, soprattutto la mattina. La gente di Šachty se non è al lavoro non ha molte cose da fare, perlopiù beve e si annoia e tende a notare le luci nelle case degli altri. Ho fatto i gradoni lentamente, perché c’era ghiaccio e perché – è stupido, lo so – dentro la luce era accesa davvero e lanciava un bagliore smorto eppure costante, una specie di richiamo. Ho immaginato che ci fosse qualcuno seduto al tavolo ad aspettarmi e per un attimo, un attimo solo, ho esitato. Tutto questo non ha senso, eppure l’ho pensato. C’è qualcuno dentro che mi qualcos’altro, la pittura fiamminga mi tenne compagnia nei periodi di solitudine – e per il momento questo è tutto ciò che ho da dire.
Sono uscito nella mezzaluce dei lampioni e c’era un vento che mi prendeva a schiaffi e mi spingeva indietro con le sue gigantesche mani d’aria: così, caracollando come un orso, sono andato verso la mia tana in vicolo Meževoj. È un rifugio segreto che ho comperato per millecinquecento rubli in un momento in cui, pur non avendo le idee chiare su come utilizzarlo, sentivo di volere un posto mio, solo mio. A lungo, Fenja e i ragazzi non hanno saputo niente della tana, e siccome in casa ero l’unico ad amministrare il denaro nessuno all’inizio si è accorto di nulla. Quando lo sono venuti a sapere era ormai troppo tardi. Anche adesso è tardi e forse, se ci penso, lo è sempre stato. La mia tana è poco più di una baracca, vi si accede per mezzo di alcuni gradoni di terra su cui sono stati infilzati dei tramezzi di legno per fare in modo che il gradone non crolli sotto il peso dei corpi e della neve. Dentro, nella mia tana, non c’è quasi niente: una lampadina che penzola dal soffitto e che ha l’aspetto di un impiccato la cui testa esplode di luce, un tavolo di legno con una (una) sedia, una branda su cui ho buttato nel corso degli anni tutte le coperte che sono riuscito a portare fuori di casa, un fornello da campo con un pentolino e una stufa a gas che grazie a dio ha sempre funzionato bene. La latrina, con un piccolo lavandino, è fuori, sul retro: d’estate lì dentro si muore di caldo, d’inverno si formano delle smisurate stalattiti di ghiaccio che penzolano dal tubo dello sciacquone, l’acqua del cesso si congela e non è possibile scaricare. Ma va bene così, io ho sempre vissuto con poco e non mi serve quasi niente. Ci sono andato, nella mia tana, perché il giorno prima, il 23 dicembre, mi era arrivata la voce che qualcuno aveva notato che la luce dell’unica stanza era rimasta accesa. Qui viene buio presto, d’inverno, ma non è normale che uno tenga accesa la luce per tutto il giorno, soprattutto la mattina. La gente di Šachty se non è al lavoro non ha molte cose da fare, perlopiù beve e si annoia e tende a notare le luci nelle case degli altri. Ho fatto i gradoni lentamente, perché c’era ghiaccio e perché – è stupido, lo so – dentro la luce era accesa davvero e lanciava un bagliore smorto eppure costante, una specie di richiamo. Ho immaginato che ci fosse qualcuno seduto al tavolo ad aspettarmi e per un attimo, un attimo solo, ho esitato. Tutto questo non ha senso, eppure l’ho pensato. C’è qualcuno dentro che mi rimasto al buio, solo, con uno strato di brina sulle lenti e le gambe fiacche. Mi sentivo stanco. Ho annusato l’aria vuota della stanza, non c’era più nessun odore. Prima di spegnere la luce avevo fatto in tempo a vedere che il pavimento e l’anta della porta sembravano puliti. Non sapendo come fare, due giorni prima li avevo sfregati con della neve raccolta in un vecchio secchio di ferro arrugginito. Adesso faceva un freddo terribile, perché avevo lasciato la finestrella leggermente aperta affinché ci fosse un po’ di ricambio d’aria, e anche il profumo vagamente alcolico dell’acqua di colonia Šipr che avevo sparso si era volatilizzato. Era, la mia tana, un luogo vuoto dove non era accaduto nulla, un territorio piccolo, sperduto e fuori dal tempo: potevo non esserci mai stato e in un certo senso, ho pensato, è proprio così. In un angolo, nel secchio abbandonato, due dita di acqua marroncina e dal lieve odore di metallo e polvere avevano infradiciato del tutto lo straccio. Ho deciso di buttarlo, di lavare il secchio con la neve e di spruzzargli un po’ di Šipr prima di riportarlo fuori, nella latrina. Vicino alla stufa ho ritrovato il coltello e mi sono chiesto in che momento, due giorni prima, mi fossi ricordato di pulire la lama. Ho preso anche le tenaglie, perché le volevo usare per la faccenda del rame. Ma, ecco – è questo che voglio dire –, mentre stavo per uscire, dopo aver dato le spalle alla stanza mi sono bloccato all’improvviso. Ero lì, sulla soglia, solo e al buio, e per un istante sono rimasto immobile e mi sono imposto di non pensare a nulla, mentre in realtà avevo la sensazione precisa e terribile di non essermi fermato per mia volontà ma perché qualcuno mi aveva posato una mano sulla spalla. Sentivo (avevo sentito) un peso umano sul corpo, un tocco veloce, lungo appena un secondo o forse meno, eppure risoluto, schietto. Ho provato freddo, ma un freddo diverso da quello che c’era nella tana, e ho sentito una goccia di sudore, del tutto priva di senso in quel gelo assoluto, scivolare lentamente lungo l’asse della schiena facendosi strada tra la canottiera e la pelle. Ho sentito distintamente che stavo respirando, e nessuno ama ascoltare il proprio respiro: ogni emissione di fiato è un piccolo passo verso la fine, e più si respira veloce più la fine si avvicina. Ho stretto il coltello con la mano guantata e mi sono voltato, ma non di scatto, con circospezione, con perizia, e tutto questo benché mi trovassi in una situazione orribile, in un impazzimento di cuore. La mano che mi aveva chiamato si era ritirata da tempo, e io avevo perso ogni sintomo di stanchezza. Ho acceso la luce e mentre l’impiccato mi abbagliava ho visto che nella tana, com’è ovvio, non c’era nessuno.
Io non sono un uomo coraggioso, e il nome che porto non è che una beffa. Eppure sono rimasto dov’ero, il coltello nel palmo guantato, a guardarmi intorno come un animale. Piano piano mi calmavo, guardavo la stanza e la abbracciavo tutta, a destra e a sinistra, ed ero alla ricerca di un’ombra, di un sintomo. Per un minuto non è successo niente: le stanze del resto non danno segni. Poi ho notato qualcosa a terra – una cosa piccola, sciocca: un filo attorcigliato, nero, che artigliava una gamba del tavolo. Mi sono abbassato e ho raccolto un capello sottile, leggermente sporco. L’ho portato al naso: sapeva vagamente di Šipr. Me lo sono legato a un dito e, prima di uscire, mi sono guardato attorno con l’aria di chi ringrazia.
Quando mi sono ritrovato a una buona distanza da vicolo Meževoj, ho lasciato cadere il capello in una pozza e l’ho sepolto nella neve. Ero ormai sul limitare della foresta: i boschi nei dintorni di Šachty sono il mio personale giardino delle delizie, ma io allora non potevo che averne un sentore lontano, un sospetto, forse. Da un punto indistinto vicino al fiume provenivano i bagliori di alcuni fari e, se mi concentravo, riuscivo a sentire una confusione, un rumore generale fatto del rombo di alcuni motori e dei suoni di alcune voci umane. Mi sono infilato nel bosco e no, non avevo paura. I boschi dell’oblast’ di Rostov sono casa mia, tutti i boschi dell’Unione Sovietica lo sono fin dai tempi della Grande Guerra Patriottica, quando ci nascondevamo nella foresta per sfuggire ai tedeschi, o quando al Komsomol’ ci facevano immaginare di essere dei baluardi della Causa – noi, piccoli, smagriti e con i fazzolettoni rossi annodati al collo –, e ci facevano cantare (ma io non cantavo!, io non ho mai avuto la voce per cantare e mi sono sempre ingoiato i versi, che pure sapevo a memoria e amavo più di ogni altra cosa), ci facevano cantare la Canzone del pioniere, quella che dice
Portiamo i ladri in galera


Andrea Tarabbia è nato a Saronno nel 1978. Ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi La calligrafia come arte della guerra (Transeuropa, 2010), Marialuce (Zona, 2011), Il demone a Beslan (Mondadori, 2011), il racconto La ventinovesima ora (Mondadori, 2013) e il reportage La buona morte. Viaggio nell’eutanasia in Italia (Manni, 2014). Nel 2012 ha curato e tradotto Diavoleide di Michail Bulgakov per Voland. Vive a Bologna con la moglie e il figlio.