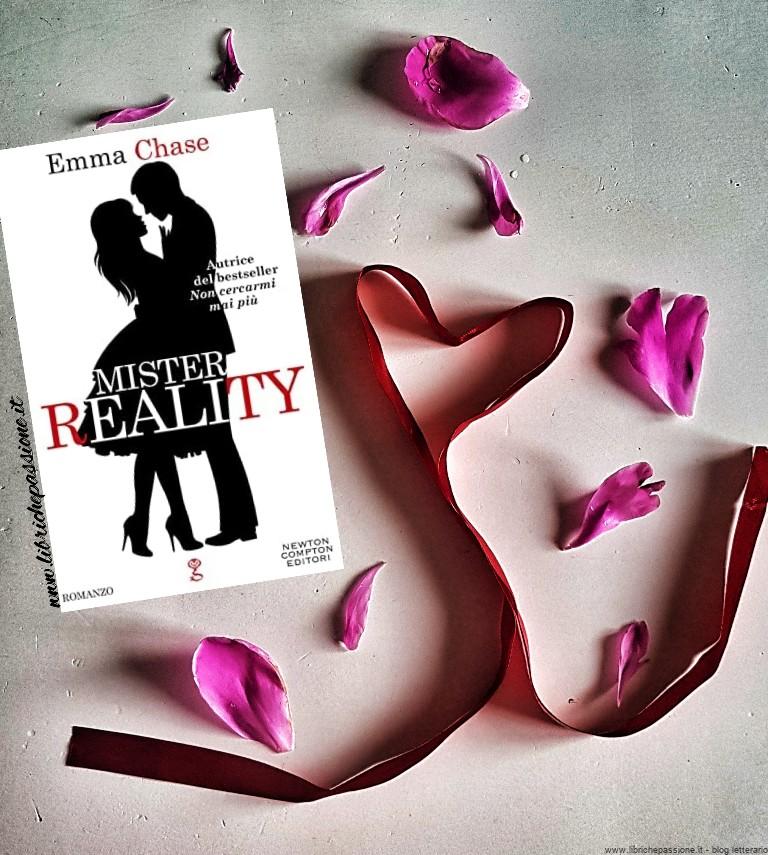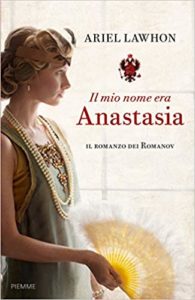 Il romanzo dei Romanov
Il romanzo dei Romanov
«Molti hanno raccontato la mia storia. Adesso è il mio turno.» Era il 16 luglio del 1918 quando i tumulti che scuotono la Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre prendono forma in uno degli atti più violenti che la storia dell’impero ricordi: l’esecuzione a sangue freddo dell’intera famiglia dello zar Nicola II Romanov. Sua moglie e i suoi figli furono tutti freddati a colpi di fucile nei sotterranei della casa di Ekaterinburg dove erano agli arresti domiciliari. Nessuno sopravvisse, o almeno così si pensò.
È il 17 febbraio del 1920 quando una giovane donna viene ritrovata a Berlino, in un canale, vicina alla morte per assideramento. In ospedale, ormai salva, i medici scoprono che il suo corpo è ricoperto di orrende cicatrici. E quando finalmente la donna apre bocca, sarà per dire il proprio nome: Anastasia. In molti non le credono: per loro è solo Anna Anderson, una polacca emigrata in Germania, a cui interessa soltanto la fortuna della famiglia zarista. Ma in Europa comincia a diffondersi, tra reali in esilio e circoli dell’alta società, la voce che la giovane Anastasia sia sopravvissuta. Che la figlia più piccola dello zar Nicola II e della zarina Alessandra, la spericolata bambina che tutti amavano, sia ancora viva.
Tra speculazione, verità, inganni, Ariel Lawhon costruisce un romanzo ricco, sorprendente e prezioso come un uovo Fabergé, raccontandoci la storia incredibile di Anastasia Romanova e di Anna Anderson, la donna che sostenne sempre di essere la granduchessa russa, giocando in modo irresistibile con la Storia e i suoi misteri.

Era il 16 luglio del 1918 quando i tumulti che scuotono la Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre prendono forma in uno degli atti più violenti che la storia dell’impero ricordi: l’esecuzione a sangue freddo dell’intera famiglia dello zar Nicola II Romanov. Sua moglie e i suoi figli furono tutti freddati a colpi di fucile nei sotterranei della casa di Ekaterinburg dove erano agli arresti domiciliari. Nessuno sopravvisse, o almeno così si pensò.
È il 17 febbraio del 1920 quando una giovane donna viene ritrovata a Berlino, in un canale, vicina alla morte per assideramento. In ospedale, ormai salva, i medici scoprono che il suo corpo è ricoperto di orrende cicatrici. E quando finalmente la donna apre bocca, sarà per dire il proprio nome: Anastasia. In molti non le credono: per loro è solo Anna Anderson, una polacca emigrata in Germania, a cui interessa soltanto la fortuna della famiglia zarista. Ma in Europa comincia a diffondersi, tra reali in esilio e circoli dell’alta società, la voce che la giovane Anastasia sia sopravvissuta. Che la figlia più piccola dello zar Nicola II e della zarina Alessandra, la spericolata bambina che tutti amavano, sia ancora viva.
Tra speculazione, verità, inganni, Ariel Lawhon costruisce un romanzo ricco, sorprendente e prezioso come un uovo Fabergé, raccontandoci la storia incredibile di Anastasia Romanova e di Anna Anderson, la donna che sostenne sempre di essere la granduchessa russa, giocando in modo irresistibile con la Storia e i suoi misteri.
Questo romanzo è un’opera di fantasia. Tutti i fatti, i dialoghi e le persone, a eccezione di alcune celebri figure storiche e pubbliche, sono frutto dell’immaginazione dell’autrice e non sono da considerarsi reali. Nei casi in cui compaiono personaggi storici e pubblici realmente esistiti, la maggior parte delle situazioni, dei fatti e dei dialoghi che li riguardano sono del tutto immaginari e non intendono rappresentare avvenimenti reali né modificare in alcun modo il carattere fittizio dell’opera. Sotto qualunque altro aspetto, ogni similitudine con persone reali, esistenti o esistite, è puramente casuale.
Come sempre, a mio marito Ashley,
perché senza di lui sarei persa.
E a Marybeth, che mi ha dato il titolo.
Infine a Melissa: editor, paladina e amica.
«Se la Storia fosse insegnata sotto forma di storie,
non verrebbe dimenticata.»
RUDYARD KIPLING, Opere complete
Avvertimento
Per narrarvi ciò che accadde quella notte a Ekaterinburg dovrò dipanare la mia memoria, svolgere il filo di ogni ricordo e porlo sul palmo della vostra mano. Sarà il dono e la maledizione che vi offro. Una confessione per la quale forse non mi perdonerete mai. Siete pronti a questo? Sarete in grado di tenere questa verità in mano senza distruggerla, come tutti gli altri? Perché io penso di no. Penso che non ne avrete il coraggio. Ma, come tanti altri nel corso degli anni, avete domandato: è vero che sono Anastasia Romanov? Una figlia adorata. Un’icona riverita. Una granduchessa russa.
O sono un’usurpatrice? Un’imbrogliona. Una bugiarda. La ladra del retaggio di un’altra.
Naturalmente spetta a voi deciderlo. Innumerevoli altri hanno già emesso la loro sentenza. Adesso è il vostro turno. Ma se volete la verità, dovete seguirmi con attenzione. Senza perdervi in fantasticherie né assopirvi. Senza parlare né interrompere. Avrete le risposte che cercate: ma prima dovete comprendere perché gli anni mi hanno condotto qui e quale perdita ha reso necessario questo viaggio. Quando avrò finito, e soltanto allora, avrete il diritto di dirmi chi sono.
Pronti? Bene.
Cominciamo.
PRIMA PARTE
La fine e il principio
«Eliminato l’impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, dev’essere per forza la verità.»
SIR ARTHUR CONAN DOYLE, Il segno dei quattro
Capitolo 1
Anna
FOLIE À DEUX
1970, 1968
Charlottesville, Virginia
17 febbraio 1970
Una sera di cinquant’anni fa esatti Anna si è gettata da un ponte di Berlino. Non è stato il suo primo incontro con la morte, e neppure il più violento, ma è stato l’unico che sia avvenuto per mano sua. Il marito di Anna, però, non lo sa. Lei lo osserva mentre la sta osservando, e sa che vede soltanto una donna vecchia e fragile che attende da troppo tempo che il mondo le dia ragione. Vede l’immagine accuratamente coltivata con cui lei si presenta al mondo: una corona di radi capelli argentei e occhi azzurri stanchi. Vecchiaia, smarrimento e una lieve aura di inettitudine. Quest’impressione non potrebbe essere più distante dal vero. Nel corso del tempo Anna è stata molte cose, ma non inetta. In questo momento, comunque, è semplicemente impaziente. Se ne sta seduta in soggiorno, a migliaia di chilometri dal suo passato, ad aspettare una sentenza.
Jack è come un coniglio spaventato, un fascio di nervi in tensione. Si alza di scatto dalla sedia e si mette a camminare su e giù nel salottino stipato di oggetti. «Perché non hanno telefonato? A quest’ora avrebbero già dovuto chiamare.»
«Sono sicura che hanno letto la sentenza da ore» dice Anna, appoggiando la testa allo schienale della poltrona e chiudendo gli occhi.
Qualunque notizia li aspetti, non sarà buona, ma non ha cuore di dirlo a Jack. È talmente fiducioso. Ha già scritto un comunicato stampa e scattato una polaroid in modo da poterli portare al «The Daily Progress» l’indomani mattina di buon’ora. Nel pomeriggio ha parlato con il redattore, suggerendogli di lasciare uno spazio per l’articolo in prima pagina. Spera in qualcosa sopra la piegatura. Spera in punti esclamativi.
Anche se lui non l’ha mai ammesso, Anna sa che non vede l’ora che tornino i giornalisti. Non ne vedono uno da mesi, e lei sospetta che si senta solo, con lei e gli animali come unica compagnia. Le dispiace un po’ per lui, costretto ad accollarsela in quel modo. Ma non c’erano altre possibilità. Gleb aveva insistito per quella soluzione, e Gleb Botkin è sempre stato il suo amico più devoto, il suo sostenitore più convinto. È morto già da due anni, ormai. L’ennesima perdita in una serie infinita di perdite. Jack è buono con lei – proprio come aveva assicurato Gleb – e comunque, a caval donato non si guarda in bocca. Anna se lo ripete ogni giorno.
Squilla il telefono. Tre trilli metallici che li fanno sussultare, prima che Jack strappi il ricevitore dalla forcella.
«Casa Manahan.» Un attimo di silenzio e poi: «Sì, è qui. Attenda un attimo». Il filo non arriva dall’altra parte della stanza, così appoggia il telefono sulla credenza. Ha un’espressione felice stampata in volto. «Una chiamata dalla Germania.»
«Chi è?»
«Il principe.» Jack sorride raggiante, poi precisa (ci sono stati diversi principi nella vita di Anna): «Federico».
Quel nome le suscita una violenta fitta di collera. Non ha dimenticato cos’ha fatto Federico, non ha dimenticato il mucchio di resti bruciati dietro il suo chalet ai margini della Foresta nera. Tutti quegli ossicini carbonizzati. Se l’annuncio venisse da chiunque altro, prenderebbe la telefonata. «Non voglio parlare con lui.»
«Ma…»
«Lui sa perché.»
«Penso proprio che a questo punto dovresti…»
Anna alza una mano, un gesto fermo, definitivo. «Fatti lasciare un messaggio.»
Jack mette il muso ma non protesta. Sa che è inutile discutere. Anna non cambia idea. E neppure dimentica. Riprende in mano la cornetta. «Mi dispiace, in questo momento non ha voglia di parlare. Perché non lo dice a me?»
E poi lei vede l’espressione di Jack afflosciarsi gradualmente, in piccoli scatti strazianti. Prima il sorriso. Poi le sopracciglia inarcate, piene di aspettativa. Il braccio destro ricade lungo il fianco. Tutto il suo entusiasmo si è smontato. «Non capisco» dice infine, quindi si raschia la gola come se avesse inghiottito una ragnatela.
«Scrivilo» ordina Anna. «Parola per parola.» Non vuole che la sentenza le giunga filtrata dalla sua collera dopo che avrà riagganciato. Vuole sapere con esattezza cos’ha da dire la corte d’appello. Jack è troppo emotivo e incline all’esagerazione. Deve trascrivere la sentenza per intero, o qualche informazione fondamentale andrà persa appena riattaccherà. Con Gleb non ce ne sarebbe bisogno. Saprebbe cosa fare. Saprebbe cosa domandare. Ma Gleb non c’è più, e ancora una volta quella constatazione la lascia smarrita.
«Mi lasci prendere nota» dice Jack, come se fosse un’idea sua. Lei lo guarda rovistare tra le pile di fogli che ingombrano la credenza per cercare un taccuino con qualche pagina bianca. Non trovandolo, afferra una busta e la gira. «Continui pure. Sono pronto.»
Dieci anni fa l’avvocato di Anna le ha detto che quella causa era la più lunga nella storia della Germania. Il ricorso si è protratto fino a trasformarsi in qualcosa di peggio, un incubo interminabile. Ed ecco che Jack sta scrivendo la nota in calce a tutti i suoi sforzi sul retro della bolletta dell’elettricità, nella sua calligrafia minuta, perfettamente leggibile. «Come si scrive?» domanda a un certo punto, tenendo la cornetta con una mano e prendendo nota con l’altra. Non butta giù degli sgorbi frettolosi, ma traccia ogni parola con precisione certosina, chiedendo ogni tanto a Federico di ripetere.
Jack e Anna hanno pochi amici. Non sono sposati da molto, due anni appena, e il loro è un rapporto basato sulla convenienza e sulla necessità, non sull’amore. Sono vecchi ed eccentrici, e non adatti alla buona società di quella cittadina universitaria d’altri tempi. Ma a breve dovrebbero arrivare alcune persone, per lo più ex professori dell’Università della Virginia, come Jack. Anna non vuole sapere in che modo li abbia convinti a venire. Ricevere degli ospiti l’avrebbe messa in imbarazzo se la sentenza fosse stata favorevole. In questo caso la prospettiva è atroce. Decide che quella sera non ci sarà nessun ricevimento. Non se la sente di intrattenere degli estranei.
Ma Jack, nel suo entusiasmo sfrenato, ha preparato una cena di festeggiamento. Il loro minuscolo soggiorno è disseminato di vassoi di frutta e sandwich. Uova ripiene e piatti di formaggi. Cetriolini sottaceto e mini-würstel infilzati su stuzzicadenti. Ha perfino comprato tre bottiglie di champagne che riposano in una ciotola di ghiaccio sotto la fila di lucine natalizie che ha fissato al soffitto con la spillatrice. Anna guarda le bottiglie con diffidenza. Non tocca quella roba da quasi quarant’anni. L’ultima volta che ha bevuto champagne è finita nuda sulla terrazza di un attico di New York.
Tutta la messa in scena è festosa e di cattivo gusto, proprio come suo marito. Per l’occasione, Jack ha comprato al negozio di costumi teatrali vicino al campus del college un diadema di strass, che ora giace su un pacchiano cuscino di velluto rosso accanto allo champagne. Muore dalla voglia di incoronarla da quando si sono conosciuti, e solo oggi, solo nella speranza di una sentenza favorevole, lei lo ha assecondato. Ma ora quella speranza è morta. Uccisa nell’aula di un tribunale tedesco dalla parte opposta del globo.
«Grazie,» dice infine Jack, e poi a voce più bassa, quasi un sussurro «senz’altro. Mi dispiace. Lo sa com’è a volte. Sono sicuro che la prossima volta le parlerà. Arrivederci.»
Quando si volta verso Anna, tiene la busta premuta sul petto. Non parla.
«Dobbiamo telefonare agli ospiti e dire che la festa è annullata» dice lei.
Jack è annichilito. «Mi dispiace tanto.»
«Non è colpa tua. Hai fatto quel che potevi.» Una scrollata di spalle. Un respiro profondo. «Cos’ha detto Federico?»
«Il tuo ricorso è stato respinto. Non ribalteranno la sentenza di grado inferiore.»
«Questo l’avevo capito. Ripetimi quello che ha detto parola per parola.»
Jack dà un’occhiata al foglio. «Giudicano la tua istanza di riconoscimento un “non liquet”.»
«Interessante.»
«Che significa?»
«“Non chiaro” o “non dimostrato”.»
Quando Jack si acciglia, arriccia la bocca fino a sfiorare il naso con il labbro superiore. È un’espressone stranamente infantile e da quando conosce Anna gli capita di usarla sempre più di frequente. «È tedesco?»
«Latino.»
«Conosci il latino?»
«Molto poco, ormai.» Anna agita una mano con impazienza. «Vai avanti.»
«I giudici hanno detto che, per quanto non sia mai stato provato che sei morta, non lo è stato nemmeno che sei sopravvissuta.»
«Ah. Ingegnoso.» Anna sorride a quel dilemma. È il circolo vizioso per eccellenza. È impossibile provare che è sopravvissuta senza una dichiarazione ufficiale di identità da parte del tribunale. «Leggi il resto, per favore.»
Jack tiene la busta a dieci centimetri dal naso e recita lentamente la sentenza. «Nonabbiamo concluso che la ricorrente non è la granduchessa Anastasia, ma solo che il tribunale di Amburgo ha emesso la sua sentenza senza errori legali né vizi procedurali.» Alza lo sguardo. «Quindi non hanno concluso… nulla?»
Anna scuote la testa lentamente, e poi in modo più deciso. «Oh, hanno concluso tutto.»
«È colpa di quella foto, vero? I giudici devono averla vista. Non c’è altro motivo per cui si sarebbero pronunciati contro di te. Accidenti a quella Rasputin. Accidenti a lei!» Jack ricomincia a camminare su e giù. «Potremmo rilasciare una dichiarazione….»
«No. È finita.» Anna alza il mento con tutta la dignità di cui è capace e incrocia le mani in grembo. È rassegnata e regale. «Non mi riconosceranno mai ufficialmente come Anastasia Romanov.»
DUE ANNI PRIMA
Charlottesville, Virginia
23 dicembre 1968
Anna non vuole sposare Jack Manahan. Preferirebbe sposare Gleb. Anche dopo tutti i problemi che le ha causato nel corso degli anni. Ma la loro è una storia di false partenze e incontri mancati. Tempi sbagliati. Lontananza. E colpi di testa. Non erano destinati a stare insieme. Così Gleb ha insistito perché sposasse Jack, invece. Tutto quel disastro è una sua idea: il tribunale, quel ridicolo vestito rosa, il bouquet di rose e pigne, il cappello di pelo di coniglio bianco che lei dovrebbe indossare fuori dal tribunale per incontrare i fotografi (questi ultimi convocati da Jack, perché quell’accidente d’uomo non può fare a meno di scatenare un putiferio ovunque vada). Gleb continua a sostenere che il cappello le dà un aspetto da granduchessa russa. Lei rifiuta di metterselo. Povero coniglio.
Quando hanno parlato di quell’assurdo progetto, ad agosto, Gleb ha incolpato la sua salute. Non poteva sposarla lui perché si sarebbe ritrovata a doverlo accudire. Anna invece è convinta che le stia facendo scontare un rancore di vecchia data. Occhio per occhio. Ferita per ferita. L’ha amata per decenni, e lei non è mai stata in grado di ricambiare fino in fondo i suoi sentimenti. Ora lui fa da testimone a quelle sue nozze riluttanti. Testimone dello sposo, per la precisione.
Fuori dal tribunale nevica. Non le dure, rabbiose, brucianti schegge di neve a cui si è abituata in Germania, ma grossi fiocchi indolenti, che fluttuano e sfarfallano e se la prendono comoda prima di toccare terra. Neve pigra. Neve americana.
Anna ha avuto solo un’avventura da quella limpida estate in Baviera di tanti anni prima, ma Gleb ha voltato pagina. Si è sposato. Ha avuto figli. Non hanno mai parlato degli anni trascorsi da allora, e ormai non vale più la pena di sollevare l’argomento. Anna ha più di settant’anni, troppi per sposarsi, soprattutto per la prima volta. Jack Manahan ne ha venti di meno. Un ex professore innamorato della storia russa, e di lei… o almeno, dell’idea di lei. In ogni caso, non ha opposto molta resistenza quando gli hanno prospettato il piano. L’unico segno di esitazione da parte sua è stata la lunga occhiata penetrante che ha dato a Gleb, per valutare quanto fosse affezionato ad Anna e disposto a lasciarla andare.
A un certo punto – già troppo avanzato – dei preparativi, le è venuto in mente che non aveva considerato la questione del sesso. Jack è giovane. Più giovane, almeno. E lei… be’… lei no. L’idea di dover consumare per poco non l’ha spinta a tirarsi indietro e mandare a monte tutto. Quegli ormoni si sono tutti seccati, trasformati in polvere e volatilizzati. Ormai il desiderio è poco più che un dolce ricordo.
Gleb comunque si è occupato anche di quello, assicurandole che il sesso non rientra necessariamente nell’accordo. Lei e Jack avranno camere da letto separate. Sarà un matrimonio legale, sufficiente a farla rimanere negli Stati Uniti quando il suo visto scadrà, di lì a tre settimane, ma sarà solo un matrimonio di convenienza. Lo ha giurato, un’infinità di volte, davanti all’ultima bottiglia di vino che hanno bevuto insieme. Jack non la toccherà nemmeno con un dito. A meno che non sia lei a volerlo. Perché abbia aggiunto l’ultima frase non le è del tutto chiaro. L’ha detta senza guardarla negli occhi, e lei non ha replicato. È stata una piccola crudeltà: tra di loro è così, a quanto pare. Piccole ferite. Tagli della carta. Abbastanza da bruciare, ma senza far male sul serio. Tutto sommato, forse è meglio che non stiano per sposarsi.
Gleb sguscia nell’anticamera attigua all’aula del tribunale e contempla la sua figurina snella. «Stai bene.»
Lui è pallido, debole e stanco. Negli ultimi tempi è dimagrito e le spalle che un tempo erano larghe si sono ristrette per la malattia e la vecchiaia. Anna vorrebbe domandargli se il suo cuore è peggiorato. Ma ha paura di sentire la risposta. Così dice: «Sono ridicola».
«Tutte le spose sono ridicole. È per questo che sono così affascinanti.»
Anna torna a voltarsi verso la finestra. È fine pomeriggio, l’oscurità sta calando a vista d’occhio e la luce che viene dal soffitto si riflette sul vetro, rinviandole la sua immagine. Si porta una mano alla guancia. Segue una ruga profonda dopo l’altra, e ognuna racconta una storia che ha deciso di dimenticare da tempo.
«Sono troppo vecchia per questo.»
«Lo so.»
«Quindi lo ammetti?» Scruta anche il riflesso di Gleb, che aleggia sopra la sua spalla. «Ma senza scusarti, vedo.»
«O fai questo o te ne torni in Germania. Non abbiamo più tempo.»
«Pare che sia sempre così tra di noi, no?»
«Navi che si incrociano nella notte» sussurra Gleb, posandole una grande mano calda sulla spalla. «Sei pronta? Il sergente Pace sta aspettando. E anche Jack.»
«Sergente?»
«Il giudice Morris ha telefonato stamattina per dire che è malato.»
Anna si volta verso di lui e guarda, non il suo viso, ma il nodo della sua cravatta. Fissa le strisce rosse e blu che si alternano sulla stoffa, quelle righe che si avvitano su se stesse, tutte attorcigliate e rigirate. Anche lei ha un nodo in gola, ma adesso, improvvisamente, per l’ilarità.
«Verrò sposata» domanda, sollevando il mento per incrociare quegli occhi verdi scintillanti «non da un prete o da un giudice, ma da un poliziotto?»
«Dà tutto un altro significato alla lettura dei tuoi diritti, no?»
Allora scoppiano in una risata, lunga e sonora.
Lei si volta di nuovo verso la finestra e rimangono lì, in un silenzio rilassato, a guardare Charlottesville scomparire sotto la neve. Alla fine Anna reclina la testa all’indietro, sul petto di Gleb. «Come sono arrivata qui?» sospira, conoscendo già la risposta. È arrivata lì, è sopravvissuta, facendo sempre ciò che è necessario fare.
QUATTRO MESI PRIMA
Charlottesville, Virginia
20 agosto 1968
La Virginia in agosto dà ad Anna la netta sensazione di essersi trasferita nel cuore incandescente dell’inferno. Non immaginava che potesse esistere un caldo simile. Così come non conosceva il significato della parola “umidità” prima di arrivare negli Stati Uniti. Eppure eccola lì, seduta sulla veranda di Jack Manahan a bere tè – col ghiaccio, nientemeno – e a squagliarsi sulla sedia a dondolo mentre chiacchierano del più e del meno.
Si sventola il viso con una vecchia rivista – una cosa che parla di giardini e armi da fuoco – rammaricandosi che il sole non tramonti un po’ più in fretta. «Come fai a vivere così?»
Jack la scruta da sopra il bordo di un bicchiere imperlato di condensa. «Così come?»
«Come una patata messa ad arrostire in forno. È insopportabile.»
«È agosto» dice lui, come se fosse una spiegazione sufficiente. Ha i pantaloni, le maniche lunghe e una sgargiante cravatta a quadri stretta fino al pomo d’Adamo. Non sembra minimamente a disagio. «Non ci faccio quasi più caso.»
È tipicamente americano, pensa Anna, avere una conversazione tutta incentrata sul tempo. Sono seduti su quella veranda da quasi due ore ad aspettare Gleb, che è andato a fare una commissione in città e ha promesso di tornare per cena. Finora hanno parlato delle differenze di clima lungo la costa orientale degli Stati Uniti, della distribuzione delle piogge nel Midwest e di una rovinosa siccità in California che sta mettendo in ginocchio i coltivatori di mandorle. Quel tipo adora il suono della propria voce e ha bisogno di pochissimo incoraggiamento da parte sua. Un semplice mugolio o mormorio è sufficiente per farlo lanciare in un altro monologo. Anna si domanda quanto ancora sarà in grado di sopportare prima di uscire di senno, quando una lunga ed elegante automobile nera imbocca l’University Circle e avanza verso la casa. È il genere di veicolo che puzza lontano un miglio di spocchia e ostentazione.
«Chi è?» domanda Jack mentre l’auto entra nel vialetto e parcheggia dietro la sua station wagon.
«Non saprei.» Anna tenta di non sentirsi in colpa per la menzogna. Ha uno sgradevole sospetto su chi potrebbe essere il visitatore.
«Sembrano molto decise.» Jack si sporge in avanti per osservare le due donne che saltano giù dall’auto e percorrono a passo di carica il marciapiede verso di loro.
«Anastasia!» grida la più vecchia quando giunge ai piedi dei gradini. L’espressione del viso è di un entusiasmo allarmante.
Quella donna è russa. Quella donna è pericolosa.
Sale la rampa con un’energia e un’aggressività che Anna non possiede più da anni. La sua compagna la segue a due passi di distanza, osservando con prudenza la scena. Ha la messa in piega, le labbra dipinte di rosso e gli occhi incorniciati da un paio di occhiali neri di marca. In una mano tiene un taccuino, nell’altra un registratore. Una giornalista. Anna si irrigidisce sulla sedia.
Un istante dopo la prima donna se ne sta davanti ad Anna ciarlando e piegando il busto: non proprio un inchino, ma un accenno. Anna si ritrae, mentre trovano conferma il viso familiare e la voce profonda, rauca. I capelli neri – tinti, pensa; non c’è un filo di grigio – e gli occhi penetranti. Il naso spigoloso. La bocca scaltra. Il corpo grosso e squadrato come un blocco di cemento. La donna le agguanta la mano e la stringe con un tale vigore che Anna teme di essere strappata dalla sedia e risucchiata in un abbraccio.
Ciò che ha sempre odiato dell’essere minuta è quanto sia svantaggiata in situazioni come quella. La gente presume di poterti toccare, darti delle pacche, stringerti la mano senza autorizzazione. Presume che, se sei poco più grande di una bambina, tu debba essere una bambina. Che ti si possa zittire o ridurre all’obbedienza. È difficile per chi è piccolo di statura incutere timore o farsi prendere sul serio. Per compensare quella carenza, nel tempo Anna ha dovuto sviluppare altre capacità: acuire l’ingegno, usare la lingua come una lama e la mente come la pietra su cui affilarla.
«Non sono una bambola di pezza. Non c’è bisogno che mi scuota così. Né che mi tocchi, se è per questo.»
«Mi scusi» dice l’altra donna, facendosi avanti. «Non ci siamo presentate. Sono Patricia Barham, ma la prego, mi chiami Patte…»
«Oggi non sono interessata a parlare con i giornalisti.»
Patte guarda gli oggetti che ha in mano e poi li nasconde dietro la schiena, come se si fosse scordata della loro presenza e tutt’a un tratto se ne vergognasse. «Non sono una giornalista, o almeno non nel senso tradizionale del termine.» Piega la testa in direzione dell’amica. «E certo ricorderà Maria Rasputin. A quanto dice, vi conoscete fin da bambine.»
«Rasputin?» A quel nome Jack diventa tutt’orecchi e si raddrizza di scatto sulla sedia. «Come Grigorij? Il monaco eretico?»
«Non era un monaco,» dice Maria «e lo testimonia la mia esistenza. L’etichetta di eretico, ovviamente, si presta a varie interpretazioni.» Ha l’aria tirata di una che è stanca di difendere l’indifendibile.
Anna deve ancora alzarsi dalla sedia o offrirne una a quelle ospiti non invitate. Diffida di Maria Rasputin, e a buon diritto.
I cambi di tono melodrammatici della voce di Maria danno l’impressione che stia recitando in uno spettacolo teatrale. Ad Anna non piacciono i gesti ampi e pomposi che fa con le braccia né la maniera aggressiva in cui sorride. Quei piccoli denti candidi che scintillano e si chiudono di scatto. Ma quello che la infastidisce di più sono gli occhi. Sono di un azzurro intenso, quasi innaturale. Acuti, ma non in un modo che invita ad avvicinarsi. Anna ha l’impulso di girare la testa per sottrarsi a quello sguardo penetrante. Non dovrebbe stupirsene: è noto che Grigorij Rasputin aveva quegli stessi occhi terrificanti, ipnotici. Tale padre, tale figlia.
Ma è difficile sfuggire allo sguardo di Maria, tanto più che si avvicina fino a incombere sulla sedia di Anna.
«Sì» dice infine, come se giungesse a una conclusione attesa da tempo. «In lei c’è qualcosa.» Di nuovo, agitando il braccio in maniera pomposa. «Una certa nobiltà. È lì, nel suo contegno. Nella sua voce.» Maria fa un brusco cenno di assenso. «Ritengo che si tratti di Anastasia Romanov.»
«Cosa vuoi?» Anna si preme le mani sulle ginocchia per non cancellarle dal viso quel sorriso compiaciuto con uno schiaffo.
«Solo fare visita a una vecchia amica…»
«Pensavamo che magari avremmo potuto invitarla a cena» interloquisce Patte. Ha riposto il taccuino e il registratore nella borsa, e ora le mani pendono libere e innocue lungo i fianchi.
Sentendo parlare di cibo Jack si ringalluzzisce. «Una cena tra amici potrebbe essere divertente. C’è un fantastico ristorante italiano poco lontano da qui.»
«Siete venute fin qua… da dove, mi hai detto?» domanda Anna.
«Non l’ho detto. Ma da New York, visto che sei curiosa.»
«Fin qua da New York solo per andare a cena?»
«A cena, già.» Ed è a questo punto che Maria scopre le carte, perché non riesce a trattenere un sorriso diabolico. «Ma ho anche una proposta da farti.»
«Non andrò a Hollywood.» Anna posa la forchetta.
Quando sono andati via con Maria e Patte Barham, Jack ha lasciato un biglietto per dire a Gleb che sarebbero stati da Salvio’s, ma lui non li ha ancora raggiunti e Anna guarda la porta ogni due secondi. È stato un errore. Lei e Jack sono costretti a stare ad ascoltare quelle donne e il loro assurdo progetto. Si è pentita di aver accettato di cenare con loro.
«Non sia precipitosa» dice Patte. «Si possono fare un sacco di soldi.»
«La mia storia non è in vendita.»
Patte non lo dice esplicitamente, ma dall’ampio sogghigno si capisce che è convinta che la storia di chiunque sia in vendita. Si stringe nelle spalle. Infilza un pezzo di fungo. Lo ingoia senza masticare. «La gente è curiosa. Vuole sapere com’era. Vuole sapere com’è sopravvissuta. Non c’è nulla di male se nel frattempo lei si guadagna da vivere.» Guarda il semplice vestitino di cotone di Anna, sbiadito dai troppi lavaggi, con il colletto logoro, e indugia a sufficienza con lo sguardo per dichiarare quanto Anna abbia bisogno di quel denaro. E poi, per ribadire il concetto, aggiusta la catenina di una costosa collana d’oro che le cinge il collo.
Anna allontana il piatto. «Vorrei andare a casa.»
«E dov’è “casa”, di preciso?» domanda Maria Rasputin.
«Sono ospite di Jack.»
Maria sorride tra sé e mangia lentamente, con cura, un boccone di cannelloni. Il cambio di tattica è improvviso. «Quanto tempo hai detto che saresti rimasta negli Stati Uniti?»
«Sei mesi.»
«E sei qui da quanto… due mesi? Tre?»
Anna sa che le sta tendendo una trappola, ma non riesce a vederla. «Due.»
«Che tipo di visto hai ottenuto?»
«Turistico.»
«Peccato. I viaggi internazionali sono talmente cari.»
Anna fa ciò che ha fatto per decenni. Inclina il capo di lato e verso l’alto. Rivolge a quella donna l’ombra di un sorriso, una smorfia di condiscendenza che lascia intendere che non è disposta a raccogliere l’insinuazione né ad ammettere che sì, in effetti è a corto di denaro e non le restano molte opzioni.
Maria continua imperterrita. Mangia un altro boccone. Intinge il pane nel denso olio d’oliva dal gusto deciso. Beve un sorso di vino. «E cosa farai quando scadrà il visto?
Tornerai in Germania? Dai tuoi amici a Unterlengenhardt? Dai tuoi animali?»
Ecco che è arrivata. La frecciata la colpisce nel vivo. Anna deve lottare con tutte le sue forze per non boccheggiare per l’indignazione. Chiaramente Maria sa che non ha una casa a cui tornare, che non resta altro che una fossa comune dietro lo chalet in cui un tempo viveva. Il ruolo giocato da Maria in quegli avvenimenti aleggia tra di loro, tacito e carico di implicazioni.
La figlia di Rasputin sorride vittoriosa. «Immagino che il principe Federico sarebbe felice di accoglierti al tuo ritorno. Ti è sempre stato così affezionato.» Mastica un boccone. Deglutisce. «E così fedele.»
Quel babbeo di Jack è ignaro di tutto. Ha mangiato un piatto di fettuccine grosso come la sua testa, accompagnato da mezzo filone di pane, e ora ha scostato la sedia dal tavolo per stare ad ascoltare dandosi dei colpetti soddisfatti alla pancia. Per lui è solo una conversazione tra due donne che parlano di vecchi amici. Per lei è un ricatto.
Anna alza le spalle, senza sbilanciarsi. «Arrivati alla mia età, si vive alla giornata. Non mi sono ancora decisa per un’opzione in particolare.»
«Il che significa che non ne hai nessuna, giusto? »
Jack e Patte si guardano sconcertati.
«Cosa stanno dicendo?» domanda Jack.
«Non lo so.»
Solo allora Anna si rende conto che lei e Maria sono passate al tedesco. La transizione è stata talmente fluida, talmente sottile, che non se n’è neanche accorta. Se Maria avesse cominciato a parlare russo, lo avrebbe notato immediatamente. Avrebbe rifiutato di proseguire la conversazione. Benché parli bene inglese – ha già vissuto negli Stati Uniti – il tedesco è la sua lingua d’elezione. Quella che le dà sicurezza.
«Lo immaginavo.» Maria allunga una mano sul tavolo per dare dei colpetti a quella di Anna. È facile scambiarlo per un gesto affettuoso, ben più gentile di quanto non sia in realtà. «Non devi vergognarti. È difficile, lo so. Perché credi che abbia permesso a Patte di seguirmi come un cagnolino per tutto questo tempo? Tutti noi dobbiamo guadagnarci da vivere. Non c’è niente di vergognoso in questo.»
Anna ritira la mano, ma continua a guardarla negli occhi.
«Voglio che sia assolutamente chiaro. Non sarò il tuo buono pasto.» Sceglie volutamente quelle parole, scandendole bene, godendosi l’espressione dell’altra mentre le riconosce. Sono le stesse che ha usato Maria quando è spuntata all’improvviso a Unterlengenhardt e ha tramato per ridurre in cenere il suo mondo.
ra si appoggia allo schienale della sedia e scoppia a ridere come se Anna avesse detto qualcosa di buffo, ma nei suoi occhi brilla una luce furiosa, pericolosa.
«Non andrò in California insieme a te. Né a nessun altro, se è per questo. Non venderò la mia storia.» Anna guarda prima Patte e poi Jack, mentre ripete in inglese la richiesta fatta poco prima. «Vorrei andare a casa.»
«Be’, io vorrei il dessert» dice Maria.
Il tavolo è già ingombro di vassoi e cestini del pane e bottiglie di vino vuote. Anna non pensa che ci sia posto per un altro piatto, ma Maria chiama il cameriere e ordina panettone e caffè. Anna si maledice ancora una volta per non aver insistito per prendere la macchina di Jack. Adesso sono in balia di quelle intruse. Così aspetta pazientemente che Maria finisca l’ennesima portata. Quella Rasputin non è che una vecchia che si comporta come una bambina petulante, facendogliela pagare perché non vuole stare al gioco.
«Come hai fatto a trovarmi?» domanda Anna. È la seconda volta che Maria Rasputin l’ha scovata. Resta da vedere se le conseguenze saranno altrettanto catastrofiche.
«Non è stato difficile.» Piega la testa in direzione di Jack. «Il tipo con cui ti sei messa va matto per i giornali. Sono scorsi fiumi di inchiostro su di te, da quando sei arrivata negli Stati Uniti.»
«Non mi sono messa con lui.»
«Non ancora. Scommetto che è solo questione di tempo. Tu li ami, i tuoi… benefattori.»
Jack e Patte hanno rinunciato a seguire la loro conversazione e stanno chiacchierando tranquillamente di scrittura e ricerca sul lato opposto del tavolo. Si fanno quasi le nove prima che il cameriere porti il conto. Se ne sono andate ore ad ascoltare prima Patte, e poi Maria, tentare di convincere Anna a cedere i diritti della storia della sua vita in modo che possano ricavarne un film. Fanno discorsi altisonanti e citano grossi nomi. Propongono una serie di attrici famose che potrebbero interpretare Anastasia. Lei omette di far presente che Ingrid Bergman l’ha già fatto e che per quel ruolo ha vinto il premio Oscar nel 1957. Ma a nessuna delle due interessa granché la sua opinione. Sono concentrate solo sulla prospettiva di un ricco compenso.
Maria prende il conto e Anna si alza, sollevata di averla fatta finita con quella cena e di poter finalmente tornare a casa. Ma poi Maria fa scivolare il conto sul tavolo e glielo piazza davanti. Nel suo sorriso non c’è fascino né arguzia, solo volontà di vendetta.
«È stato fantastico rivederti… Anastasia. Grazie per la cena.»
«Cos’altro ti vuoi aspettare da una Rasputin?» La voce di Gleb si trasforma gradualmente in un urlo mentre cammina avanti e indietro nel soggiorno di Jack. «Imbroglioni bugiardi e ladri, tutti quanti!»
Jack arretra, sulla difensiva. «Non sapevo che ci avesse rifilato il conto. Non ho seguito con attenzione.»
«Non ha rifilato il conto a te. Tu puoi permettertelo. L’ha rifilato ad Anna. E sono sicuro che era quello che aveva in mente fin dall’inizio.»
«No» dice Anna. «Se avessi acconsentito al suo piano, avrebbe pagato lei. Voleva solo punirmi.»
«Sei stata punita a sufficienza.»
Ora Jack è imbarazzato. Confuso. «Cos’avrei dovuto fare?»
«Tanto per cominciare, avresti potuto non parlarle affatto.»
«Era solo una cena.»
«Non era solo una cena, era un’uscita in pubblico. Una Rasputin scredita la nostra causa. Ogni rapporto con quella famiglia è pericoloso. Non ne verrà nulla di buono.» Gleb smette di ballonzolare nervosamente e guarda Anna. «Non dire a nessuno, non a una sola persona, che hai passato la serata con quella donna. Me lo prometti?»
Il silenzio di Anna è eloquente.
Gleb geme. «Che c’è?»
«Prima di cena ha chiesto a quella biografa di scattare una fotografia di noi due insieme.»
La fotografia viene pubblicata alcuni giorni dopo. Non finisce su tutte le prime pagine in cui probabilmente sperava Maria Rasputin, ma appare in diverse rubriche mondane e viene ripresa anche dall’Associated Press. Prima della fine della settimana, mezza America e gran parte del mondo sanno che Maria Rasputin ha dichiarato che Anna è la granduchessa Anastasia Romanov. Maria viene intervistata a lungo, racconta estasiata della sua amica che non vedeva da tanto tempo, arriva perfino alle lacrime nel rimembrare i loro ricordi d’infanzia. Anna brucia i giornali, disgustata.
«Ci servono!» esclama inorridito Jack quando va in fiamme l’ultimo.
Anna lo ignora. Guarda Gleb. «Mi dispiace tanto. Non sapevo che avrebbe fatto una cosa del genere.»
«Non potevi saperlo.»
“Non è del tutto vero” pensa Anna, ma per il momento non lo confessa a Gleb. Invece domanda: «Quanto nuocerà al ricorso?».
«Impossibile dirlo. I Rasputin sono invisi all’estero, per ottime ragioni. Dipende da chi legge quegli articoli e da come vengono recepiti.»
«I giudici non crederanno mica che dietro ci sia io? Che stia fabbricando delle prove?»
«Non c’è che aspettare e vedere.»
 foto presa dal web
foto presa dal web
Ariel Lawhon è un’acclamata autrice americana di narrativa storica. Co-fondatrice di SheReads.org, uno dei più seguiti book club d’America. Vive a Nashville, Tennessee, con il marito e i quattro figli.