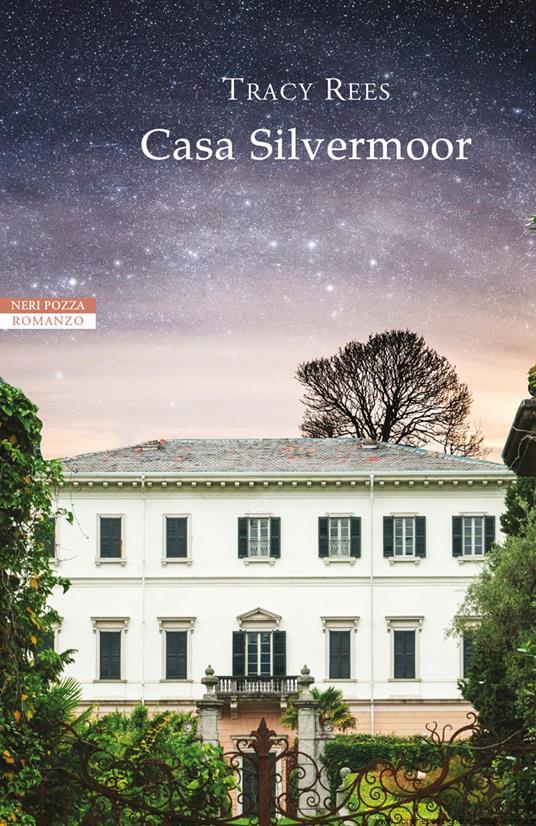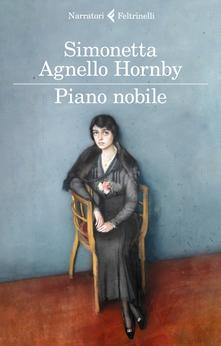Trama
«L’esordio di Stina Jackson è inquietante e coivolgente. La luce infinita dell’estate nordica conferisce alla sua storia una qualità strana, quasi onirica.»
The Guardian
Sono ormai tre estati che Lelle, insegnante di liceo e padre di un’adolescente, trascorre ogni notte alla guida della sua auto. Conosce ogni metro degli oltre cinquecento chilometri della Via dell’Argento, la strada che serpeggia tra gli alberi dell’antica foresta nel Nord della Svezia, al confine con la Norvegia. Quella che il sole di mezzanotte non riesce a illuminare.
Lelle conosce ogni paesino isolato, ogni insediamento, ogni specchio d’acqua.
Sono tre anni che sua figlia è scomparsa, da qualche parte fra il ghiaccio e l’argento, lungo quell’autostrada che d’estate, sotto il sole di mezzanotte, sembra un nastro d’asfalto sulla luna. Lelle ha soltanto l’estate per cercare sua figlia, perché in autunno inizia l’anno scolastico e deve interrompersi. Lelle non ha speranze, eppure la speranza è l’ultima cosa che gli resta.
Meja ha diciassette anni e viene dalla città, ma sua madre l’ha costretta a trasferirsi a Glimmersträsk: un puntino sconosciuto lungo la Via dell’Argento.
Lontana da tutto ciò che amava, Meja è sola e disperata. Finché non incontra qualcuno che può darle più di quanto abbia mai avuto: una nuova famiglia.
Con l’arrivo dell’autunno e la sparizione di un’altra ragazza, i destini di Lelle e Meja iniziano a intrecciarsi in modo indissolubile. E sconvolgente.
Un esordio geniale. Un’autrice dalla grande abilità nel delineare personaggi e rapporti umani, scavando nelle ombre più cupe dell’animo.
Estratto
A Robert
PARTE PRIMA
La luce. Lo sferzava, lo bruciava, lo scuoteva. Si stendeva sui boschi e sui laghi come un invito a continuare a respirare, come la promessa dell’arrivo di una nuova vita. La luce che lo inondava di inquietudine rubandogli il sonno. Già a maggio era sveglio ben prima che l’alba si facesse strada nella casa attraverso tessuti, pertugi e fessure. Lui sentiva l’acqua scorrere nel terreno ghiacciato facendo sanguinare a morte l’inverno. Sentiva i ruscelli e i torrenti che mormoravano e si ingrossavano mentre i monti si sfilavano gli abiti invernali. A breve, la luce avrebbe invaso le notti, allungandosi sul mondo fino a divenire accecante, riportando in vita tutto ciò che dormiva sotto le foglie marcite. La luce avrebbe riempito di calore i germogli degli alberi facendoli esplodere, e tutte quelle vite appena sbocciate avrebbero fatto risuonare la foresta di grida affamate. Il sole di mezzanotte avrebbe snidato gli uomini dalle loro tane, colmandoli di desiderio. Pronti a ridere e ad amare e farsi violenza l’un altro. In quei giorni capitava che alcune persone scomparissero, che rimanessero abbagliate e perdessero la via. Ma lui non voleva credere che potessero morire.
Fumava soltanto quando andava a cercarla.
Ogni volta che lui si accendeva una sigaretta, dal sedile del passeggero, lei se ne accorgeva subito. Le sue smorfie, l’occhiata penetrante che gli lanciava da sopra gli occhiali.
«Credevo che avessi smesso.»
«Infatti. Questa è un’eccezione.»
La vedeva scuotere la testa, scoprire i canini affilati di cui si vergognava. La sua presenza si faceva più tangibile in quei momenti, mentre lui guidava nella notte e la luce non accennava a svanire. Aveva i capelli biondi di una tonalità chiarissima, che diventavano quasi bianchi quando il sole li illuminava, scuri grappoli di lentiggini sul dorso del naso che negli ultimi anni aveva iniziato a coprire col trucco, e poi quegli occhi che vedevano tutto anche mentre sembravano non guardare nulla. Assomigliava più ad Anette che a lui, ed era una fortuna: nel proprio corredo genetico non era compresa la bellezza. Lei invece era bella, e non lo pensava solo perché era sua figlia. Lina aveva sempre fatto voltare la gente per strada, anche da piccola. Era stata una bambina in grado di strappare un sorriso anche alle persone più malinconiche. Ma ormai nessuno la guardava più. Erano tre anni che nessuno la vedeva – o per lo meno, nessuno che potesse ammetterlo.
Le sigarette finirono prima che arrivasse a Jörn. Lina non era più seduta accanto a lui. L’auto era vuota, e lui aveva quasi dimenticato dove si trovasse. Gli occhi fissi sulla strada, anche se non la vedeva. Aveva percorso la statale, che la gente del luogo chiamava familiarmente Via dell’argento, così tante volte da conoscerla come le proprie tasche. Sapeva dov’erano i curvoni e persino gli strappi nelle recinzioni che permettevano ad alci e renne di invadere il manto stradale. Sapeva dove si raccoglieva la pioggia, e dove la nebbia saliva dai laghi cambiando la fisionomia del mondo. La strada era un’eco di un’epoca passata, in cui era utilizzata per trasportare l’argento da Nasafjäll al golfo di Botnia. Ora si snodava come un fiume tra i monti e la costa, collegando Glimmersträsk alle altre località dell’entroterra, e per quanto lui ormai odiasse tutte le anse e le curve che attraversavano la fitta boscaglia, non l’avrebbe mai abbandonata. Era lì che lei era scomparsa, era stata quella strada a inghiottire sua figlia.
Nessuno sapeva che di notte lui saliva in auto per andare a cercare Lina. Che fumava una sigaretta dietro l’altra con il braccio attorno al sedile del passeggero, che parlava con sua figlia come se lei fosse realmente lì, come se non fosse mai scomparsa. Non aveva nessuno a cui raccontarlo. Non da quando Anette l’aveva lasciato. Aveva detto che era stata colpa sua fin da subito. Era stato lui ad accompagnare Lina al bus, quella mattina. Era lui ad avere la responsabilità.
Arrivò a Skellefteå verso le tre. Si fermò a far benzina e a riempire il termos di caffè. Malgrado l’ora, il ragazzo alla cassa aveva gli occhi vispi e un’aria vivace, con i capelli rossicci pettinati da un lato. Era giovane, poteva avere al massimo diciannove, vent’anni. La stessa età di Lina. Anche se lui non riusciva a immaginarsela adulta. Comprò un altro pacchetto di Marlboro Lights ignorando i sensi di colpa. Lo sguardo gli cadde su un espositore di unguento antizanzare accanto alla cassa. La carta di credito quasi gli cadde di mano. Tutto gli ricordava Lina. Quell’ultima mattina lei era completamente ricoperta di unguento antizanzare. In realtà, quella era l’unica cosa che ricordava: dopo averla lasciata alla fermata del bus, aveva abbassato il finestrino per mandar via l’odore. Non ricordava cosa si fossero detti, se lei fosse felice o triste, o cos’avessero mangiato a colazione. Quel che era capitato dopo occupava troppo spazio: non restava che l’unguento antizanzare. Quella sera, l’aveva raccontato ai poliziotti: Lina puzzava di unguento. Anette l’aveva guardato come se fosse un perfetto estraneo, qualcuno di cui si vergognava. Ricordava anche quello.
Aprì il pacchetto nuovo e s’infilò una sigaretta tra le labbra, lasciandola lì mentre tornava indietro, questa volta in direzione nord. Il viaggio di rientro era sempre più veloce, più desolato. Il cuore d’argento di Lina penzolava dallo specchietto, catturando i raggi di sole. Ora lei era di nuovo accanto a lui, con i capelli biondi che le coprivano il viso come una tenda.
«Papà, lo sai che hai fumato ventuno sigarette nel giro di qualche ora?»
Lelle fece cadere la cenere fuori dal finestrino, soffiando il fumo lontano da lei.
«Davvero così tante?»
Lina alzò lo sguardo al tettuccio, come a invocare una potenza superiore.
«Lo sai che ogni sigaretta ti costa nove minuti di vita? Questa sera ti sei accorciato l’esistenza di centottantanove minuti.»
«Accidenti», disse Lelle. «Ma che cosa mi resta per cui valga la pena vivere?»
Quando lei lo guardò, aveva gli occhi velati dall’ombra di un rimprovero.
«Devi trovarmi. Sei l’unico che può riuscirci.»
Meja stava distesa con le mani sul ventre e provava a ignorare i rumori.
I morsi della fame e tutto il resto. Quei suoni disgustosi che attraversavano le assi rade del pavimento. Il respiro ansimante di Silje e quello di lui, del nuovo uomo. Il cigolio del letto, poi il cane che si mise ad abbaiare. Sentì l’uomo urlargli di andare a cuccia.
Era notte fonda, ma il sole illuminava la minuscola soffitta. Si stendeva in pennellate di un giallo caldo sopra le pareti grigiastre, e svelava l’intrico dei capillari sotto le palpebre chiuse. Meja non riusciva a dormire. Si inginocchiò davanti alla bassa finestra, strappò le ragnatele con la mano. Nient’altro che il cielo azzurro e la foresta bluastra, a perdita d’occhio. Allungando il collo riusciva a vedere uno spicchio di lago, nero e immobile, a suo modo invitante. Si sentiva come la principessa imprigionata di una fiaba. Rinchiusa in una torre tetra, circondata da una foresta impenetrabile e condannata ad ascoltare le prodezze sessuali della matrigna cattiva nella stanza di sotto. Anche se Silje non era la sua matrigna: era sua madre.
Nessuna delle due era mai stata nel Nordland, prima. Durante il lungo viaggio in treno, il dubbio aveva assalito entrambe: avevano litigato e pianto, ed erano rimaste in silenzio a lungo, mentre il bosco s’infittiva fuori dal finestrino e la distanza tra le stazioni si faceva sempre più ampia. Silje aveva giurato che quello sarebbe stato l’ultimo trasloco. L’uomo che dovevano incontrare si chiamava Torbjörn e possedeva una fattoria in un villaggio di nome Glimmersträsk. Lui e Silje si erano conosciuti su Internet e poi avevano chiacchierato per ore al telefono. Meja aveva captato la sua brusca inflessione dialettale, e aveva visto le foto di un uomo baffuto, con il collo taurino e gli occhi che, quando sorrideva, si riducevano a due fessure. In una foto stava suonando una fisarmonica, in un’altra era chino su un buco nel ghiaccio e sollevava un pesce dalle squame rosse. Torbjörn era un vero uomo, secondo Silje, un uomo che sapeva come sopravvivere nelle circostanze più sfavorevoli, e che avrebbe potuto prendersi cura di loro.
La stazione in cui finalmente erano scese era poco più che una casetta tra i pini, e quando provarono ad aprire la porta la trovarono chiusa a chiave. Non era sceso nessun altro, e vennero travolte dalla corrente d’aria quando il treno ripartì per poi sparire tra gli alberi. Il terreno continuò a lungo a vibrare sotto i loro piedi. Silje si accese una sigaretta e iniziò a trascinare la valigia lungo il marciapiede dissestato, mentre Meja rimase per qualche istante ad ascoltare il fruscio dei rami e il ronzio di milioni e milioni di zanzare appena nate. Le sembrò che un urlo iniziasse a montarle nello stomaco. Non voleva seguire Silje, ma d’altro canto non aveva il coraggio di restare indietro. Al di là dei binari la foresta si stagliava come un sipario verde scuro contro il cielo luminoso, e migliaia di ombre si muovevano tra i rami. Non vedeva animali, ma si sentiva osservata come se si trovasse al centro di una piazza affollata. Milioni di occhi che le solleticavano la pelle.
Silje raggiunse il parcheggio sconnesso dove le aspettava una Ford mangiata dalla ruggine. Un uomo col volto coperto da un cappellino nero era appoggiato al cofano. Quando le vide, si raddrizzò e sorrise, rivelando una pallina di snus sotto il labbro. Torbjörn sembrava ancor più massiccio dal vivo, più solido. Ma c’era qualcosa di goffo e docile nei suoi movimenti, sembrava non rendersi conto della propria stazza. Silje abbandonò la valigia e lo abbracciò, come se fosse un salvagente in un oceano di pini. Meja rimase defilata, a osservare una crepa nell’asfalto in cui si erano infilati dei petali di tarassaco. Li sentì baciarsi, percepì le lingue che si avvolgevano.
«Questa è mia figlia, Meja.»
Silje si asciugò la bocca e fece un gesto verso di lei. Torbjörn la scrutò da sotto la visiera del cappello e le diede il benvenuto nel suo rude dialetto. Meja invece tenne lo sguardo fisso a terra, per rimarcare che tutto ciò stava accadendo contro la sua volontà.
L’auto puzzava di cane bagnato, e sul sedile posteriore era stesa una pelle d’animale, rigida e ingrigita. Dal sedile spuntava l’imbottitura gialla. Meja si sedette sul bordo, respirando con la bocca. Silje aveva detto che Torbjörn se la passava bene, ma a giudicare dall’auto doveva trattarsi di un’iperbole. Lungo la strada che portava alla fattoria non c’era altro che un bosco desolato, inframmezzato da radure e piccoli laghi solitari che scintillavano come lacrime tra gli alberi.
Quando arrivarono a Glimmersträsk, Meja sentì un groppo rovente serrarle la gola. Sul sedile anteriore, Torbjörn posò la mano sulla coscia di Silje, sollevandola solo di tanto in tanto per indicare quel che gli pareva importante – un supermercato ICA, la scuola, la pizzeria, l’ufficio postale e la banca. Sembrava piuttosto orgoglioso dell’assortimento. Le case erano grandi, sparpagliate qua e là. Man mano che procedevano lungo la strada, la distanza tra gli edifici aumentava. Tra loro si frapponevano boschi e campi e recinti per animali. Talvolta si udiva il latrare di un cane. Sul sedile anteriore, le gote di Silje erano rosse e lucide.
«Guarda che bello, Meja. Sembra una favola!»
Torbjörn le disse di contenere l’entusiasmo, perché lui abitava dall’altra parte del lago. Meja si chiese cosa significasse. La strada davanti a loro si fece più stretta mentre la foresta incombeva sempre più vicina e l’auto si riempiva di un cupo silenzio. Meja si accorse che respirava a fatica osservando gli alti pini che sfrecciavano loro accanto.
La casa di Torbjörn sorgeva solitaria in una radura. Era un edificio a due piani che forse un tempo era stato maestoso ma che ormai si era scrollato di dosso l’intonaco rosso e sembrava sul punto di sprofondare nella terra. Un cane arruffato corse tirando fino in fondo la catena e abbaiò appena scesero dall’auto. Per il resto non c’era che il silenzio, tranne quando il vento soffiava afferrando i rami degli abeti. Guardandosi attorno, Meja sentì quasi cederle le gambe.
«Eccola qua», disse Torbjörn allargando le braccia.
«Che silenzio e che pace», disse Silje, ma l’incanto era già svanito.
Torbjörn portò dentro le loro valigie, posandole su un pavimento nero di sporcizia. Dentro, l’aria era stantia, c’era puzza di cenere e fumo. Mobili nodosi che avevano visto anni migliori ricambiarono il loro sguardo. La tappezzeria a strisce marroni era decorata con corna di animali e coltelli in guaine ricurve, più coltelli di quanti Meja ne avesse mai visti. Provò a incrociare lo sguardo di Silje, ma fu inutile. Silje si era stampata in faccia quel sorriso che significava che era pronta a sopportare quasi ogni cosa, che non avrebbe mai ammesso di aver commesso un errore.
I gemiti dal piano inferiore erano cessati cedendo il posto agli uccelli. Non aveva mai sentito dei richiami simili: sembravano isterici, ostili. Il soffitto era spiovente e formava un triangolo sulla sua testa, centinaia di nodi nel legno la fissavano come occhi. Torbjörn l’aveva chiamata la stanza a triangolo quando, in cima alle scale, le aveva mostrato la sua camera. Una camera tutta per lei, al secondo piano. Da tanto non aveva una stanza per sé. Ma non aveva altro che le sue mani per scacciare i rumori. Rumori di cattiverie tra adulti e di disperazione e di corpi che si muovevano l’uno contro l’altro. Non importava a quale distanza si trasferissero lei o sua madre: i rumori la raggiungevano sempre.
*
Lelle avvertì la stanchezza solo quando accostò al margine della strada, facendo gemere le ruote sotto di sé. Abbassò il finestrino e si prese a schiaffi fino a sentire bruciare la pelle. Il sedile accanto era vuoto, Lina era scomparsa. Non avrebbe mai approvato la sua abitudine di guidare di notte. Si infilò un’altra sigaretta tra le labbra per restare sveglio.
Aveva le guance ancora rosse per gli schiaffi quando fece ritorno a Glimmersträsk. Rallentò vicino alla fermata dei bus e parcheggiò. Osservò con diffidenza l’insignificante pensilina in vetro, decorata da graffiti a pennarello ed escrementi d’uccello. Era quasi l’alba, il primo bus non era ancora partito.
Lelle scese dall’auto e si avvicinò alla panchina graffiata. Carte di caramelle e grumi di gomme da masticare a terra. La luce si rifletteva sulle pozzanghere. Lelle non ricordava che avesse piovuto. Girò più volte attorno alla pensilina, si fermò come sempre nel punto in cui stava Lina quando l’aveva salutata. Appoggiò la spalla al vetro sporco, proprio come aveva fatto lei. Con nonchalance, come a sottolineare che non le importava più di tanto. Il primo vero lavoretto estivo. Piantare abeti ad Arjeplog. Guadagnare un bel gruzzolo prima dell’inizio della scuola. Non c’era mica nulla di strano.
Era stata colpa di Lelle se erano arrivati così in anticipo: temeva che perdesse il bus e facesse tardi il primo giorno di lavoro. Lina non si era lamentata, quella mattina di giugno era colma di cinguettii e di calore. Era rimasta lì, unica presenza alla pensilina, mentre il sole si rifletteva sugli occhiali da aviatore che Lelle e Anette le avevano regalato per sfinimento, anche se le coprivano mezza faccia. Forse gli aveva rivolto un saluto, forse gli aveva persino mandato un bacio. Di solito lo faceva.
Il poliziotto giovane aveva occhiali simili. Se li era sollevati sulla fronte quando era entrato, puntando lo sguardo su Lelle e Anette.
«Vostra figlia non ha mai preso l’autobus questa mattina.»
«Non può essere», aveva detto Lelle, «L’ho lasciata alla fermata!»
Il poliziotto aveva scosso la testa, facendo scivolare gli occhiali al loro posto.
«Sua figlia non era sul bus, abbiamo parlato con l’autista e i passeggeri. Nessuno l’ha vista.»
Già allora l’avevano guardato in maniera strana. Lo sentiva. I poliziotti e Anette. Il rimprovero nel loro sguardo l’aveva trapassato, dissipando ogni sua energia. D’altronde, era l’ultimo ad averla vista; era stato lui ad accompagnarla, era lui ad avere la responsabilità. Continuavano a porgli le stesse stupide domande, volevano sapere l’ora esatta, di che umore era Lina quella mattina. Come andavano le cose in famiglia? C’erano state liti di recente?
Alla fine era esploso. Aveva afferrato una delle sedie della cucina e l’aveva scagliata con tutte le sue forze contro uno degli agenti, un cacasotto che era corso fuori a chiamare i rinforzi. Lelle aveva ancora addosso il gelo che gli avevano trasmesso le assi del pavimento, quando gli agenti l’avevano immobilizzato a terra per ammanettarlo. Mentre lo portavano via, aveva sentito piangere Anette, che però non aveva preso le sue difese. Né allora né tantomeno in seguito. La loro unica figlia era scomparsa e lei non aveva nessun altro a cui dare la colpa.
Lelle accese il motore e si allontanò dalla pensilina solitaria. Erano passati tre anni da quando lei, lì accanto, gli aveva sorriso. Tre anni, e ancora era l’ultimo ad averla vista.
*
Meja sarebbe rimasta per sempre nella stanza a triangolo, non fosse stato per i morsi della fame. Non era mai riuscita a sfuggire alla fame, che la perseguitava ovunque lei e sua madre si trasferissero. Si premette una mano sul ventre per metterlo a tacere e socchiuse la porta. I gradini erano così stretti che dovette procedere in punta di piedi, e quasi tutti scricchiolavano e gemevano sotto il suo peso, rendendo inutile il tentativo di non farsi notare. La cucina era buia e vuota, e la porta della camera di Torbjörn era chiusa. Il cane era disteso sul pavimento dell’ingresso, e la osservò con sospetto quando gli passò accanto. Quando aprì la porta d’ingresso, il cane si alzò e le si infilò tra le gambe prima che lei potesse richiuderla. Alzò la zampa contro un arbusto di ribes, e poi fece qualche giro su se stesso tra le erbacce, col muso a terra.
«Perché hai fatto uscire il cane?»
Meja non si era accorta di Silje, seduta su una sdraio accanto al muro. Fumava una sigaretta e indossava una camicia di flanella che non le apparteneva. I capelli le si sollevavano sulla testa come la criniera di un leone, e dagli occhi si capiva che non aveva dormito.
«Non l’ho fatto apposta, è scappato.»
«È una femmina», disse Silje. «Si chiama Jolly.»
«Jolly?»
«Mmm.»
Sentendo il suo nome, il cane reagì e tornò subito sulla veranda. Si distese a fissarle, con la lingua che sembrava una cravatta contro il legno scurito. Silje le porse il pacchetto di sigarette e Meja notò che aveva dei segni rossi sul collo.
«Cos’hai combinato lì?»
Silje le lanciò un sorrisetto.
«Non fare la finta tonta.»
Meja prese una sigaretta, anche se avrebbe preferito del cibo. Sperava che Silje le risparmiasse i dettagli. Lanciò un’occhiata verso la foresta e le parve che qualcosa si muovesse. Non ci avrebbe mai messo piede. Aspirò e provò di nuovo quel senso di soffocamento: l’impressione di essere in trappola, accerchiata.
«Davvero vivremo qua?»
Silje sollevò la gamba sul bracciolo, scoprendo le mutandine nere. Dondolava freneticamente il piede.
«Dobbiamo fare un tentativo.»
«Perché?»
«Perché non abbiamo scelta.»
Silje non la stava più guardando. L’euforia del giorno prima era svanita, la luce nei suoi occhi si era spenta, ma la voce era ferma.
«Torbjörn ha i soldi. Ha una casa, un lavoro fisso, qui possiamo vivere decentemente senza preoccuparci del prossimo affitto.»
«Una catapecchia nel mezzo del nulla non la definirei vivere decentemente.»
Il collo di Silje parve andare in fiamme, lei si posò una mano sulla clavicola per non perdere il controllo.
«Non ce la faccio più», disse. «Sono stanca di vivere nella miseria. Ho bisogno di un uomo che si prenda cura di noi, e Torbjörn è disposto a farlo.»
«Ne sei sicura?»
«Di cosa?»
«Che sia disposto?»
Silje sollevò l’angolo della bocca.
«Farò in modo che lo sia, non ti preoccupare.»
Meja spense la sigaretta fumata a metà sotto la scarpa.
«C’è qualcosa da mangiare?»
Silje fece un tiro profondo e sorrise.
«C’è più cibo in questa casa di quanto tu ne abbia mai visto in tutta la tua vita.»
*
Lelle venne svegliato dal cellulare che gli vibrava in tasca. Era steso sulla sdraio accanto al lillà e sentì una fitta di dolore quando accostò il telefono all’orecchio.
«Lelle, dormivi?»
«Ma no!» mentì. «Sto lavorando in giardino.»
«Le fragole stanno maturando?»
Lelle lanciò un’occhiata all’aiuola invasa dalle erbacce.
«Non ancora, ma manca poco.»
All’altro capo, Anette fece un respiro profondo, come se stesse cercando di mantenere la calma.
«Ho aggiornato la pagina Facebook», disse. «Per la veglia di domenica.»
«La veglia?»
«Per i tre anni. Non te ne sei dimenticato, vero?»
La sdraio scricchiolò quando lui si mise in piedi. Un’ondata di vertigini lo costrinse ad appoggiarsi al parapetto della veranda.
«Ovvio che non me ne sono dimenticato, e che cazzo!»
«Thomas e io abbiamo comprato le fiaccole, il circolo di ricamo di mamma ha stampato delle magliette. Pensavamo di partire dalla chiesa e marciare insieme fino alla fermata. Preparati un discorso, se ti va di dire qualcosa.»
«Non ho bisogno di prepararmi. Tutto quel che devo dire ce l’ho già in testa.»
Anette replicò con tono sconfortato: «Sarebbe meglio se facessimo fronte unico. Per Lina».
Lelle si massaggiò le tempie.
«Dobbiamo anche tenerci per mano? Tu, io e Thomas?»
Un profondo sospiro ronzò nella cornetta.
«Ci vediamo domenica. Senti, Lelle…»
«Cosa?»
«Non stai passando le notti in macchina, vero?»
Lui sollevò gli occhi al cielo, dove il sole premeva contro le nuvole.
«Ci vediamo domenica», disse e riagganciò.
Erano le undici e mezzo di mattina. Aveva dormito per quattro ore sulla sdraio, dopo il giro della notte. Più del solito. Gli prudeva la nuca, e quando si grattò il morso di zanzara gli rimase del sangue sotto le unghie. Entrò, mise su il caffè e si sciacquò il viso nel lavello. Si asciugò con lo strofinaccio e nel silenzio quasi gli parve di udire l’eco delle rimostranze di Anette. Gli strofinacci servivano per la porcellana e le superfici lucide, non per la sua ruvida pelle, ed era la polizia che doveva cercare Lina, non lui, un padre travolto dall’angoscia. Anette, quel giorno di tre anni prima, l’aveva preso a schiaffi, urlando che era tutta colpa sua, che lui sarebbe dovuto restare lì per controllare che Lina salisse sull’autobus, che era stato lui a portarle via la sua bambina. L’aveva colpito e graffiato finché lui non le aveva afferrato le braccia e l’aveva stretta più forte che poteva, finché i muscoli non si erano rilassati e lei era crollata sotto di lui. Il giorno in cui Lina era scomparsa, era stato l’ultimo in cui si erano toccati.
Anette poi si era rivolta ad altri, ad amici, psicologi e giornalisti. Allo specialista in terapia occupazionale Thomas, lì bello pronto con le braccia aperte e l’erezione vivace, un uomo disposto ad ascoltare e a scacciare i problemi a suon di scopate. Anette aveva iniziato ad assumere sonniferi e calmanti, che le avevano offuscato la mente rendendola troppo loquace. Aveva aperto una pagina Facebook dedicata alla scomparsa di Lina, organizzando raduni e rilasciando interviste che a Lelle davano la pelle d’oca. Dettagli sulla loro vita più intima. Dettagli sulla vita di Lina, che lui non avrebbe mai dato in pasto a estranei.
Tant’è che Lelle non parlava con nessuno. Non ne aveva il tempo. Doveva trovare Lina. La ricerca era l’unica cosa che contava. I viaggi lungo la Via dell’argento erano iniziati da subito, in quell’estate.
Lelle scoperchiò ogni bidone dell’immondizia, setacciò in ogni container e cava abbandonata e palude, a mani nude. Restava davanti al computer a leggere lunghe discussioni su qualche forum, dove perfetti sconosciuti esponevano le loro teorie su Lina. Un’enorme, folle rete di teorie e congetture: era scappata, l’avevano uccisa, rapita, fatta a pezzi, aveva preso una brutta strada, era annegata, finita sotto un’auto, costretta a prostituirsi, e un’infinita serie di scenari da incubo che lui non poteva accettare ma con i quali era obbligato a confrontarsi. Quasi ogni giorno chiamava la centrale di polizia, urlando che facessero il loro lavoro. Non dormiva, aveva perso l’appetito. Tornava a casa dopo lunghi giorni di ricerche, con gli abiti insozzati, quasi da buttare, e il viso pieno di graffi, senza nemmeno ricordare in quale frangente se li fosse procurati. Anette invece smise di fare domande. Quando lo lasciò per Thomas, Lelle provò quasi sollievo: avrebbe avuto più tempo da dedicare alla ricerca di Lina. Era tutto ciò che gli restava.
Lelle si sedette col caffè davanti al computer. Lina gli sorrise dal salvaschermo. L’aria nella stanza era pesante e stantia. Le veneziane erano abbassate, la polvere vorticava nella luce che filtrava. Un fiore morto ciondolava sul davanzale. Dovunque c’erano mesti ricordi del declino di Lelle, di quel che era diventato. Entrò nella pagina Facebook su cui era stato caricato l’invito alla veglia. Centotré persone avevano messo mi piace, sessantaquattro avevano comunicato l’intenzione di partecipare. Lina, ci manchi e non perderemo mai la speranza, aveva scritto uno dei suoi amici, seguito da punti esclamativi e faccine piangenti. Cinquantatré persone avevano cliccato mi piace. Tra loro anche Anette Gustafsson. Lelle si chiese se avrebbe mai cambiato cognome. Clic dopo clic, si fece strada tra poesie, immagini ed esclamazioni di rabbia. Qualcuno sa cos’è successo a Lina, è ora che tu ti faccia avanti e dica la verità! Faccine rosse d’ira. Novantatré mi piace. Venti commenti. Uscì dalla pagina. Facebook non faceva che deprimerlo.
«Perché non ti dai da fare sui social?» si lamentava Anette.
«Darmi da fare per cosa? Un piagnisteo virtuale?»
«Si tratta di Lina.»
«Forse non l’hai capito, ma io ho intenzione di trovarla, non di piangerla.»
Lelle assaggiò il caffè ed eseguì l’accesso su Flashback. Nella discussione sulla scomparsa di Lina non c’era nulla di nuovo. L’ultimo post risaliva al dicembre dell’anno prima, era di un utente che si chiamava «Cercandolaverità».
La polizia dovrebbe controllare i camionisti che si trovavano sulla Via dell’argento quella mattina. Tutti sanno che è il mestiere preferito dei serial killer, basta pensare al Canada e agli USA. Laggiù, ogni giorno sulle autostrade sparisce qualcuno.
A giudicare dai milleventiquattro post su Flashback, gli utenti anonimi sembravano tutti concordi, in maniera quasi commovente, che Lina fosse stata adescata e rapita da un camionista prima dell’arrivo del bus. La stessa teoria della polizia, sostanzialmente. Lelle aveva contattato di persona le ditte di trasporti e di logistica, per scoprire quali autisti si trovavano in zona al momento della scomparsa di Lina. Aveva preso un caffè con alcuni di loro, aveva ispezionato i loro veicoli, segnalato il loro nome alla polizia. Ma su nessuno di loro gravavano sospetti o indizi, e nessuno di loro aveva visto nulla. La polizia non gradiva l’insistenza di Lelle. Quello era il Norrland, mica gli Stati Uniti. La Via dell’argento non era un’autostrada americana, da quelle parti non giravano serial killer.
Si alzò e si rimboccò le maniche della camicia intrisa di fumo. Si accostò alla mappa del Norrland, fissando il grappolo di capocchie di spillo che fioriva al centro della regione. Prese un nuovo spillo dal cassetto della scrivania e forò per l’ennesima volta la mappa, per segnare il punto che aveva ispezionato la notte precedente. Non si sarebbe arreso prima di aver perlustrato ogni millimetro, prima di aver controllato ogni vicolo cieco e slargo e capannone marcescente. Passò l’unghia insanguinata sulla mappa, in cerca del prossimo luogo isolato da visitare. Inserì le coordinate sul cellulare e si allungò a prendere le chiavi. Aveva già sprecato fin troppo tempo.
*
Negli occhi di Silje ricomparve quell’entusiasmo folle. Come se d’un tratto tutto fosse possibile, come se quella catapecchia nel bosco fosse la risposta alle sue preghiere. La sua voce salì di qualche ottava, si fece limpida e melodiosa. Quando parlava le parole uscivano rapide, inciampando l’una sull’altra. Torbjörn pareva apprezzarlo. Restava immerso in un silenzio soddisfatto mentre Silje cinguettava senza sosta. Gli diceva quanto gli voleva bene, e quanto le piaceva casa sua, quanto amava ogni cosa, dal motivo del linoleum alle tende a fiori enormi. Per non parlare della natura che li circondava, proprio come aveva sognato in tutti quegli anni. Con aria solenne preparò cavalletto, tavolozza e pennelli. Giurò che avrebbe dipinto le sue opere migliori con l’aiuto di quella bizzarra luce notturna. Lì, in quello spazio aperto, la sua anima avrebbe potuto respirare, soltanto lì sarebbe riuscita davvero a creare. Quell’inedito entusiasmo la rendeva più calorosa. Ogni esternazione andava sottolineata con baci e carezze e lunghi abbracci. L’improvvisa energia di Silje scatenava brividi di inquietudine lungo la schiena di Meja. L’esaltazione era sempre l’inizio di un nuovo inferno.
Le medicine finirono nell’immondizia già la seconda sera. Scatole di pillole mezzo piene sorridevano a Meja tra bucce di patate e fondi di caffè. Pillole potenti dagli innocui colori pastello.Piccoli miracoli chimici in grado di scacciare follia e tenebre. In grado di tenere in vita una persona.
«Perché hai buttato le medicine?»
«Perché non ne ho più bisogno.»
«Chi dice che non ne hai bisogno? Hai parlato col medico?»
«Non mi serve parlare con nessun medico. Lo capisco da me, che non ne ho bisogno. Qui mi sento nel mio elemento naturale. Finalmente posso essere me stessa. Qui le tenebre non possono raggiungermi.»
«Ma ti ascolti quando parli?»
Silje scoppiò a ridere.
«Perché devi sempre preoccuparti per tutto? Impara a rilassarti, Meja.»
Nelle lunghe notti luminose, Meja restava a letto a fissare lo zaino che conteneva ancora tutte le sue cose. Avrebbe potuto rubare dei soldi e prendere il treno verso sud. Dormire da un’amica intanto che cercava un lavoro. Chiedere aiuto ai servizi sociali, nella peggiore delle ipotesi. ..
Stina Jackson è nata e cresciuta a Skellefteå, nel Nord della Svezia. Poco più di dieci anni fa si è trasferita a Denver, in Colorado, dove ha scritto il suo romanzo d’esordio, l’acclamato Ghiaccio e argento con il quale si è imposta in tutto il mondo come nuova stella della suspense nordica, con 290.000 copie vendute in patria a un anno dall’uscita.