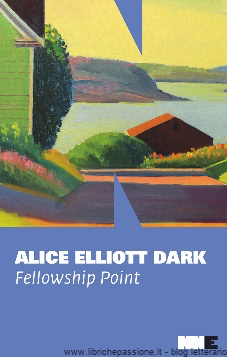Un racconto carico di tensione che gioca sul contrasto tra i soleggiati paesaggi toscani e le ombre interiori del protagonista.
Ora che è anziano, le giornate di Agostino, detto Gosto, scorrono l’una uguale all’altra nel podere immerso nella campagna ereditato anni prima. La moglie, cinica e pettegola, lo ha lasciato e l’unica figlia sembra interessata solamente ai soldi. Eppure, Gosto crede ancora nel bene e nella giustizia; conduce una vita appartata, ama la natura e prova a ignorare l’ostilità della gente del paese in cui, da sempre, è considerato un estraneo. Con pazienza, cerca di rimettere in sesto il terreno di sua proprietà anche se i ricordi del passato spesso tornano a tormentarlo. Girando per il borgo, si riconosce nell’intraprendenza del meccanico Nuccio, rivede le promesse dell’amore nella giovane Stella e nutre tutta la sua diffidenza verso il Terzi, un vicino prepotente che ha sempre spadroneggiato nella zona e che non ha mai smesso di vessarlo. Quando Stella lascia improvvisamente il paese e sparisce senza fare ritorno, Gosto è convinto che le sia accaduto qualcosa e che la sua sparizione abbia a che fare con le occhiate piene di disprezzo e di odio che gli lancia il Terzi.
Autrice dalla voce forte e ben riconoscibile, Anna Luisa Pignatelli offre ai lettori un racconto amaro e profondo, che, attraverso brevi ricordi, traccia la parabola esistenziale di un uomo riflettendo allo stesso tempo sull’iniquità e la crudeltà del mondo. Gosto è un vecchio solo, stretto tra il luogo inospitale in cui si trova a vivere e la malvagità dei suoi compaesani, ma è anche il ritratto di chi non ha mai perso la fiducia nel prossimo e ha mantenuto intatto il suo amore per la vita. Con una prosa asciutta e limpida, l’autrice si inserisce nel solco di una tradizione ben consolidata e lo fa con uno stile proprio che, come scrisse Antonio Tabucchi, fa di lei «una voce insolita nella letteratura italiana di oggi: lirica, tagliente e desolata».
Sui libri dell’autrice hanno scritto:
«Severo e bello Ruggine. Un ritratto del mondo che dà i brividi».
Ida Bozzi, «La Lettura – Corriere della Sera»
«L’arte di non coincidere perfettamente con il proprio tempo è quella che rende un testo vicino all’essere un classico e questo è il caso di Ruggine».
Filippo La Porta, «Il Sole 24 Ore»
«Una scrittrice dal palato letterario fine e ben riconoscibile».
Renato Minore, «Il Messaggero»
«Impossibile non lasciarsi stregare dagli ambienti descritti: un libro crudo e onesto, poetico e triste».
Valeria Strambi, «la Repubblica»
«Nell’asciuttezza dello stile, nella precisione dello sguardo, l’autrice ricorda Federigo Tozzi e Silvio D’Arzo».
Alessandro Zaccuri, «Avvenire»
«La prosa di Anna Luisa Pignatelli appartiene alla migliore tradizione narrativa italiana».
Guido Caserza, «Il Mattino»

1
Era il suo primo giorno da pensionato e, non avendo da alzarsi presto, Gosto rimase a letto.
Steso sul materasso, gli parve di essere entrato nel tunnel silenzioso che si apre davanti a chi, terminata la vita attiva, ha per meta solo la morte.
C’era a chi mancava la forza di affrontare quell’ultimo tratto d’esistenza, com’era successo a Ilio Casini, trovato in cantina appeso a una trave, o al Cisterni, dentro un pozzo.
Pur essendosi insinuato anche in lui il dubbio di essere diventato inutile, Gosto quel tunnel era determinato a percorrerlo fino in fondo: non è poi tanto lungo, anche se può sembrare interminabile, perché nessuno ti viene più a cercare.
Amici non ne aveva, e meno che mai se n’era fatti durante gli anni passati a Castelnuovo, dapprima a Ruffolo, la casa che aveva condiviso con la moglie Zelia, e poi da solo, nel suo podere di nome Focaia.
A volte si sentiva come un naufrago che, spinto dalle onde dopo tante traversie su una spiaggia deserta, non sapendo dove si trova, nell’assoluto silenzio che lo circonda, sente il peso di essere ancora vivo.
Per sconfiggere quel senso di vuoto e d’inutilità, l’aiutava pensare che, se la mancanza di voglia di fare avesse accelerato la sua fine, la figlia Mirella ne sarebbe stata contenta. Quell’unica figlia era per lui una spina nel fianco.
Gosto voleva soprattutto evitare che, sopravvivendogli, fosse Zelia a vincere la scommessa che lui aveva fatto dentro di sé con lei quando, nei primi tempi della loro convivenza, gli aveva detto che le sue illusioni l’avrebbero portato alla tomba anzitempo.
Pur di carattere introverso, non aveva mai condiviso la visione amara e disillusa che Zelia aveva della vita: lui aveva bisogno, più ancora che del pane, di avere fiducia negli esseri umani, e quando si rendeva conto che non la meritavano, come nel caso di sua figlia, ci stava male.
Anche per evitare delusioni, aveva sempre preferito stare per conto suo.
Zelia invece, per quanto fosse stata sempre lei a fare il primo passo verso gli altri, era convinta che non esistesse sulla faccia della terra, e in specie a Castelnuovo, un solo individuo su cui poter contare.
Nonostante la famiglia in cui era nato – il padre e il fratello erano stati i suoi primi nemici –, Gosto non aveva mai voluto perdere la speranza che spuntasse prima o poi all’orizzonte qualcuno in cui credere.
Ora, nella fase finale della sua esistenza, era pronto a sfidare il vuoto che gli si sarebbe parato ogni giorno davanti.
Nelle acque tranquille cui era giunto dopo anni di venti e di maree, gli sembrava perfino dolce potersi finalmente guardare indietro, vagare fra i ricordi, riflettere sulla gente che aveva incontrato e sul bene e il male che ne aveva tratto.
Per quanto fosse certo che non potesse capitargli più nulla degno di nota – che poteva succedergli ormai? – amava la vita, anche se sempre più spesso pensava alla morte.
La morte, se ti metti a pensare a lei, perde vigore.
Se la guardi in faccia, s’allontana: s’approfitta di quelli che la temono per annientarli anzitempo.
Gosto voleva dimostrarle che non si faceva abbattere dalla sua prossimità, che anzi ricavava soddisfazione dai giorni che gli restavano da vivere.
Nutrire in sé la fiducia nel prossimo, così come la convinzione che chiunque fosse in grado di distinguere il bene dal male, gli aveva permesso, nel corso dell’esistenza, di sentirsi meno solo, in specie quando gli era nata quell’unica figlia.
L’aveva chiamata Mirella.
A volte, guardandosi indietro, gli era capitato di chiedersi a cos’era servita quella sua vita passata in un baleno. Una domanda che restava senza risposta.
Alla fine s’era detto che, dopotutto, almeno una cosa l’aveva fatta: aveva perpetuato la specie.
Ma ora, alla sola immagine della figlia, quella risposta che s’era dato, lungi dal tranquillizzarlo, l’angustiava ancora di più.
L’aveva mantenuta con il suo lavoro, che era consistito nel consegnare con un camioncino, alle trattorie, ai ristoranti, alle botteghe e ai privati, casse di vino, d’olio, di aceto, a volte anche di frutta.
Gli si chiedeva di essere puntuale e guidare con prudenza e lui l’aveva fatto: ci teneva a quell’impiego presso l’azienda agricola Il Palazzaccio, che gli consentiva di non stare gomito a gomito tutto il giorno con gli altri dipendenti e sottrarsi alla loro meschinità sempre in agguato. Non gli piaceva sentire le loro battute grasse a spese dell’uno o dell’altro, i loro discorsi sulle partite, sul cibo, sulle donne: argomenti di chi non aveva immaginazione e niente in cui credere. Al contrario di loro, lui era un essere schivo e fattivo e, da quando era stato assunto, considerava il suo tempo libero come un dono di Dio. E questo aveva esacerbato la sua solitudine.
Il Palazzaccio era una casa di mattoni a tre piani, circondata da cipressi e da oliveti, sinistra da quando apparteneva a Guelfo Tagliaferri, uno che faceva affidamento prima di tutto sull’arroganza, anche se, andava riconosciuto, non aspettava che i soldi gli piovessero nel piatto: arava lui la terra e curava le viti, trovando pure il tempo per andare a caccia.
Del suo vino Gosto però non riusciva a buttare giù più di un sorso: il vino porta in sé l’anima di chi lo fa.
Il Tagliaferri un giorno gli aveva detto: «Ti do il permesso di effettuare, col mio camioncino, anche rimesse per conto terzi, però fuori dall’orario di lavoro, così potrai intascarti quel che ti danno, ma la benzina in tal caso te la paghi da te».
Così a volte Gosto, concluse le consegne, trasportava anche letti, materassi, divanetti per chi glielo veniva a chiedere, senza impaccarli, trattandosi sempre di roba di poco conto.
Quando nevicava, il comune si rivolgeva a lui per trasportare i sacchi di sale da spargere sull’asfalto la mattina presto per far sciogliere il ghiaccio.
Veniva ad aiutarlo il figliolo del Beci, Giuliano, che non aveva voglia di far niente ma a lui non diceva mai di no.
Il Beci, che era stato impiegato di banca, aveva detto una volta del figlio: «Non avere nulla da fare gli dà soddisfazione».
Dopo il giro di consegne, a volte il Tagliaferri dava a Gosto da aggiustare una serratura, un infisso, verniciare una botte, o lo mandava a casa dicendo: «Puoi andare dalla tu’ moglie», con un tono di compassione, quasi che finire la serata in quel modo fosse la conferma di una vita senza senso.
Appena poteva, Gosto si metteva a leggere, dei giornali e qualche libro. La sua ignoranza gli pesava da quando, alle medie, il professor Papini gli aveva inculcato curiosità per la cultura, un mondo in cui solo pochi erano disposti a entrare: presupponeva uno sforzo, e anche il rischio di distinguersi dagli altri, di essere diverso.
Leggere era anche un modo di sfuggire alle chiacchiere che Zelia raccoglieva dalle donne del vicinato e che gli propinava a cena, per fargli aprire gli occhi sulla natura ombrosa e perversa della gente di Castelnuovo, dov’erano andati a vivere quando s’erano sposati, di cui s’era accorto anche lui, nonostante non volesse farci caso.
Gosto non era di quel luogo, e neppure Zelia: lui era nato a Montici, a una ventina di chilometri di distanza, e lei in campagna, a Rivoli di Sotto, sempre da quelle parti.
In quel paese Gosto aveva fatto le elementari e le medie: il Papini, suo insegnante d’italiano, notando la sua inclinazione alla lettura, gli aveva detto: «Quando il tuo babbo ti dà qualche spicciolo vai a comprarti un libro, meglio se scritto da un italiano, così migliori il tuo modo d’esprimerti e vedi come si ragiona».
Ma a Montici di librerie non ce n’erano. Solo il giornalaio teneva qualche libro: uno, dalla copertina ingiallita dal sole, spiccava in vetrina da anni, di un autore dal nome che sembrava russo e dal titolo che alludeva a delle umiliazioni.
Incuriosito, Gosto l’aveva comprato, spinto dalla voglia di entrare in un mondo nuovo.
Ci aveva messo del tempo a finirlo, per lo sforzo di calarsi nei panni del protagonista, uno studente squattrinato che campava in un tugurio e che, per affermare il bene, aveva deciso di contrastare il male col male stesso. Gli era piaciuto: lui, nelle sue letture da autodidatta, non amava imbattersi in eroi carichi di gloria. Sapeva che non avrebbe mai potuto annoverarsi fra quelle schiere e che la sua vita sarebbe stata scialba e grigia come quella dei vecchi che ora gli ruotavano intorno, anche se da loro si sentiva ben diverso.


Anna Luisa Pignatelli, toscana di nascita, ha trascorso molti anni fuori dall’Italia, fra cui diversi in Tanzania, Portogallo, Corea del Sud e Guatemala. È molto conosciuta in Francia, dove, nel 2010, ha vinto il Prix des lecteurs du Var con la traduzione della raccolta di racconti Nero toscano. Con Ruggine (Fazi Editore, 2016), molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, ha vinto il Premio Lugnano 2016. Sempre per Fazi Editore, nel 2019, è uscito Foschia.