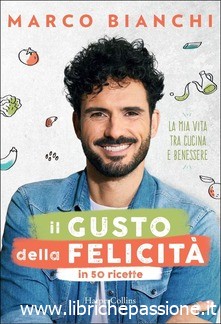![]()
Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare; ha quattordici anni ed è solo. Suo padre, con cui è partito dalla Siria per fuggire la guerra, è disperso nel mar Mediterraneo. Ahmed si nasconde perché non vuole finire in un istituto per minori non accompagnati, e vagando riesce a entrare in una cantina che diventa il suo rifugio. Nella casa sopra di lui vive Max, un ragazzo americano che trascorre un anno a Bruxelles con la sua famiglia. Non è bravo a scuola, non ha nessuna voglia di imparare il francese e il Belgio non gli piace. Ahmed e Max sono quasi coetanei, ma le loro esperienze non potrebbero essere più diverse. Eppure il loro incontro è l’inizio di una grande avventura, di quelle che solo due veri amici possono affrontare. Età di lettura: da 13 anni.
Il libro
Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare; ha quattordici anni ed è solo. Suo padre, con cui è partito dalla Siria per fuggire la guerra, è disperso nel mar Mediterraneo.
Ahmed si nasconde perché non vuole finire in un istituto per minori non accompagnati, e vagando riesce a entrare in una cantina che diventa il suo rifugio.
Nella casa sopra di lui vive Max, un ragazzo americano che trascorre un anno a Bruxelles con la sua famiglia. Non è bravo a scuola, non ha nessuna voglia di imparare il francese e il Belgio non gli piace.
Ahmed e Max sono quasi coetanei, ma le loro esperienze non potrebbero essere più diverse. Eppure il loro incontro è l’inizio di una grande avventura, di quelle che solo due veri amici possono affrontare.
A Sasha, Natalia e ai bambini del mondo
À Sasha, à Natalia et aux enfants du monde
CAPITOLO UNO
Avevano aspettato che fosse una notte di luglio nuvolosa e senza luna. I trafficanti avevano detto che così la guardia costiera greca avrebbe fatto più fatica a scoprirli, ma la loro invisibilità era diventata un problema. Il gommone affiorava di soli dieci centimetri dal Mar Egeo, molti meno di quando erano partiti. Non c’era terra in vista. Il capitano faticava a riaccendere il motore, mentre le sagome di diciotto uomini, tre donne e quattro bambini si stringevano l’uno all’altro. Alcuni indossavano giubbotti di salvataggio malconci e della misura sbagliata; pochi di loro sapevano nuotare.
«Se il motore non si accende, annegheremo» disse una delle donne, la voce debole agitata dalla paura.
Nessuno replicò.
Ahmed Nasser si strinse al petto il giubbotto salvagente, che era troppo piccolo per un ragazzo di quattordici anni alto già quasi quanto suo padre. Si ricordava le storie che aveva sentito in Turchia: certi trafficanti vendevano giubbotti difettosi che facevano annegare le persone invece di salvarle.
Sentì una mano toccargli la spalla. «Ahmed, anima mia, non avere paura.»
Ahmed guardò suo padre, il suo corpo robusto stretto su un lato della barca. Teneva a tracolla una camera d’aria e sorrideva calmo, come se sapesse che sarebbe andato tutto bene, ma l’odore di corpi sudati e sporchi, gli sguardi terrorizzati e l’urto nauseante delle onde suggerivano il contrario.
«La signora ha ragione» disse Ahmed. «La barca si sta sgonfiando. Se il motore non si accende…»
«Silenzio» rispose il padre.
La sua voce era autoritaria ma gentile, come se stesse consolando un neonato, ma Ahmed era grande abbastanza da notare l’impotenza che si nascondeva dietro quel tono. Pensò a sua madre, alle sue sorelle, a suo nonno… la loro morte era stata peggiore di come sarebbe stata la sua? Suo padre gli aveva assicurato che non avevano sofferto. Di certo era stata una morte rapida. Non c’era stato tempo per parole di falso conforto.
Meno di dieci chilometri separavano la costa della Turchia dall’isola greca di Lesbo. Ahmed cercò di scorgere qualche luce che indicasse la terra o altre imbarcazioni, ma non riuscì a vederne nessuna. Dov’era l’Europa? Non c’era nemmeno una stella in cielo, nessuna promessa che un posto migliore esistesse davvero. Il cielo era scuro quanto l’acqua sotto di loro. Ahmed riusciva a malapena a intravedere il quadrante dell’orologio di acciaio che suo padre si era tolto per metterglielo al polso, proprio quella sera. Era appartenuto al suo bisnonno, modello Omega Seamaster, un nome che in quel momento aveva un che di ironico.
«Baba, sai che non so nuotare» sussurrò Ahmed.
«Non ce ne sarà bisogno» disse il padre.
L’acqua bagnava le scarpe da tennis di Ahmed. La sentiva muoversi avanti e indietro dentro il gommone. La gente cominciò a gettare borse nel mare per alleggerire il carico. Ahmed osservò le borse galleggiare per un po’ prima di allontanarsi o affondare. Alcuni cercarono di svuotare l’acqua sul fondo usando bottiglie di plastica, ma non è che facesse molta differenza. La donna davanti a loro scoppiò a piangere. Solo allora Ahmed notò che portava in braccio un bambino in fasce.
«Non piangere» le disse il padre di Ahmed. «C’è già abbastanza acqua sulla barca.»
Quelle parole riuscirono solo a farla piangere ancora di più.
«Allahu Akbar» pregarono alcune persone.
«Baba…»
«La donna ha ragione» lo interruppe il padre. «Bisogna fare in modo che il gommone continui a muoversi. Ma non affonderai. Né tu né gli altri.»
Ahmed lo vide lanciare un’occhiata alla donna col bambino e al resto degli sconosciuti disperati e impauriti, stretti l’uno all’altro sull’imbarcazione sovraffollata. Si tolse la camera d’aria dalla spalla e la passò intorno alla testa e al torace di Ahmed. Poi si avvicinò e gli sussurrò nell’orecchio.
«Perdonami, anima mia. Ti devo lasciare da solo per un momento.»
«Lasciarmi? E perché?»
Ma il padre si era già voltato.
«Baba!»
Ahmed cercò di allungare le braccia ma si accorse che erano immobilizzate sui fianchi dal tubo di gomma. Quando finalmente riuscì a liberarle, la gamba di suo padre stava già scavalcando il bordo del gommone.
Ahmed si lanciò in avanti per afferrarlo, ma era troppo tardi. Suo padre scivolò nell’acqua nera come un’anguilla. Un momento dopo riapparve, agitando l’acqua intorno a sé.
«Che stai facendo?!» gridò Ahmed.
«Dobbiamo trainare la barca.» Gli occhi del padre si misero a cercare tra gli altri passeggeri. «Qualcun altro sa nuotare?»
Venivano da Paesi diversi: Siria, Iraq, Afghanistan… e dalle occhiate di smarrimento che si scambiavano Ahmed capì che avevano una cosa in comune: nessuno sapeva nuotare.
Una voce dall’accento iracheno si levò dietro di lui. «Io sì.»
Ahmed si voltò. Un uomo magro e slanciato si tolse la giacca e la camicia, le diede alla donna vicino a lui e lei le piegò per bene, come a indicargli che si aspettava di vederlo tornare. Tra di loro sedeva una ragazzina infilata in un giubbotto troppo grande.
«Anch’io» disse il capitano. Pareva imbarazzato a causa del motore, ma Ahmed sapeva che non era colpa sua. Non era nemmeno un vero capitano. Era uno studente d’ingegneria di Homs che i trafficanti avevano scelto tra i rifugiati perché guidasse il gommone. Un compito ingrato, grazie a cui aveva ottenuto un’oblunga boa arancione. La gettò in mare e si tuffò.
Ahmed cercò di restituire a suo padre la camera d’aria, ma lui si rifiutò di prenderla, dicendo che l’avrebbe rallentato. Gli uomini nuotarono davanti all’imbarcazione e, mentre un passeggero illuminava con la torcia l’acqua scura, avvolsero la fune da traino a prua intorno al galleggiante, discutendo a voce troppo bassa perché Ahmed potesse sentirli.
Ciascuno di loro afferrò la fune con una mano, mentre battevano i piedi e nuotavano con il braccio libero.
Il padre di Ahmed era davanti, gli altri due appena dietro.
La barca balzò in avanti come se una mano gigante le avesse dato una spinta.
I passeggeri esultarono e alcuni gridarono: «Grazie a Dio!». Quelli in mezzo alla barca raccoglievano l’acqua dal fondo e la passavano a quelli sui lati, perché la versassero in mare. Mentre Ahmed riempiva una bottiglia dopo l’altra, la paura in lui lasciò il posto all’orgoglio di sapere che suo padre stava guidando il gruppo di nuotatori. Questo gli ricordò quei lunghi weekend prima della guerra in cui la sua famiglia andava fuori Aleppo per fare picnic e barbecue. La sera tardi suo padre guidava la dabka, una danza in cui i ballerini in fila piroettavano sbattendo i piedi al suono di tamburi e tamburelli. Ahmed fissava il cielo pieno di stelle e si lasciava trascinare dalla musica, fiero, pensando che era suo padre a guidare gli altri.
Mezz’ora più tardi venne riportato a forza nel mondo reale: il vento si era alzato e le onde alte facevano dondolare il gommone. Ogni tanto l’acqua superava i bordi flosci dell’imbarcazione, e Ahmed la sentiva scorrere sul fondo. Guardò ansioso verso il fascio di luce che illuminava suo padre e gli altri nuotatori. Le creste delle onde si infrangevano contro le loro teste, rallentando il ritmo delle bracciate, ma i tre continuavano a tirare la barca avanti.
Una forte pioggia estiva cominciò a cadere dal cielo. In pochi minuti Ahmed fu bagnato fradicio. Cercò di convincersi che una pioggia così intensa non durava mai a lungo, ma il mare si faceva sempre più agitato. I nuotatori tiravano il gommone dritto contro le onde. La barca beccheggiava e oscillava, strattonando la corda a cui erano aggrappati, ma sembrava rimanere a galla.
Poi arrivò un’onda di lato.
Ahmed non la vide, ma la sentì. Il gommone s’inclinò su un fianco e per un momento rimase sospeso, come se stesse considerando il valore delle persone che conteneva. Ahmed inspirò a fondo, aspettandosi di essere scaraventato in acqua, ma il lato del gommone si abbassò e l’onda proseguì verso i nuotatori, inghiottendoli. Poi strappò il galleggiante dalla fune e lo scaraventò lontano nell’oscurità.
Ci fu un attimo di silenzio dovuto allo spavento, dopodiché i passeggeri si misero a gridare e a puntare le torce dei loro telefonini in direzione dell’acqua.
«Dove sono? Qualcuno riesce a vederli?»
Il capitano riemerse, ansimando e sputando acqua. L’iracheno apparve accanto a lui, con la mano ancora stretta alla fune.
E suo padre dov’era?
In lontananza, sotto la pioggia battente, ad Ahmed parve di veder spuntare la testa di suo padre.
«Baba!» gridò.
Non ci fu risposta, e quando guardò di nuovo tutto quello che riuscì a scorgere furono le onde infinite e le loro creste bianche.
CAPITOLO DUE
Per poco Max Howard non si strozzò con una gaufre.
«Che cosa?!»
Aveva capito che doveva stare in guardia quando i suoi genitori gli avevano proposto di mangiare la seconda gaufre della giornata. Avevano appena lasciato la Grand Place, l’immensa piazza nel centro di Bruxelles in cui i turisti guardavano incantati i palazzi scolpiti e ornati d’oro; era il loro terzo giorno in Belgio, e sua madre aveva insistito per fare una foto di famiglia proprio lì. Max pensava che l’avrebbe presto trovata su Facebook con una stupida didascalia del tipo “L’inizio del nostro eccitante anno in Europa!”.
Era la prima volta che Max andava in Europa, e proprio come la maggior parte di ciò che aveva visto fino ad allora, la Grand Place non gli era sembrata vera. Le viuzze acciottolate intorno alla piazza erano piene di cioccolaterie, chioschi che vendevano gaufres, negozi di souvenir in cui si trovavano boccali per la birra e portachiavi del Manneken Pis, la statua del ragazzino che fa la pipì diventata la mascotte di Bruxelles. I turisti passavano accanto al loro tavolo fuori dal locale che vendeva gaufres, parlando un miscuglio di lingue diverse, e anche se sembrava che fosse ancora mattina, i camerieri erano già intenti a cambiare i cartelloni dei ristoranti e a prepararsi per la cena. Benché mezzo stordito dal jet lag, Max sapeva che c’era qualcosa di tremendamente sbagliato in quello che gli avevano detto i suoi genitori.
«Pensavo di andare alla scuola americana. Come Claire.»
Fissò la sorella maggiore seduta dall’altra parte del tavolo. Sapeva qualcosa o no? Sua sorella agitò i lunghi capelli biondi e continuò a mandare messaggi ai suoi milioni di amici in America. Max avrebbe voluto strapparle il telefono dalle mani e gridarle: “Traditrice!”. A Washington lei gli riferiva sempre quello che stavano tramando i genitori, e con i suoi consigli lo aiutava a evitare che si arrabbiassero per i voti a scuola. Ma aveva reagito ancor peggio di Max all’annuncio del trasferimento; sarebbero rimasti a Bruxelles per un anno, in modo che il padre potesse lavorare come consulente alla difesa della NATO, un’organizzazione che proteggeva l’Europa dalla Russia. E ora sua sorella stava mettendo in chiaro che Max doveva cavarsela da solo.
Sua madre si sporse verso di lui dalla sedia accanto. Era esile e minuta, eppure riusciva sempre a farlo sentire in trappola.
«Claire va al liceo. Non può permettersi un’avventura come la tua.»
Max non si fece ingannare dalla parola “avventura”. Sapeva che quello che sua madre intendeva dire in realtà era qualcosa di più simile a: “Claire è una studentessa eccellente, sulla buona strada per Harvard o Yale. Tu hai passato a malapena la prima media, e temiamo che finirai per vivere nel nostro seminterrato”.
Si voltò verso suo padre. Stava bevendo un cortissimo caffè europeo, ma con la faccia scottata dal sole, i bermuda beige e una maglietta della maratona dei Marines, non c’era dubbio che fosse americano. Max non aveva visto nessun altro uomo in calzoni corti in tutta la Grand Place.
«Papà?»
Max sapeva che i suoi genitori non erano quasi mai d’accordo su nulla. Suo padre si limitò a sorridere, come se intuisse quello che Max stava pensando, e scosse il capo.
«È una buona idea, Max.»
Max fissò i genitori con un’aria di disgusto (avrebbe incluso anche Claire, se si fosse degnata di alzare lo sguardo dal telefonino).
«Ehm, sapete che non parlo francese?»
«Lo imparerai» disse suo padre.
«La signora Krantz ha detto che hai orecchio» aggiunse sua madre.
Max aveva il sospetto che grazie alla sua indole da avvocato avesse aspettato il momento giusto per usare quella frase come prova schiacciante. “Eh? Puoi ripetere?” pensò, ma si trattenne. Era una battuta stupida, e si sentiva troppo sconfortato per farla.
La signora Krantz era la specialista dell’apprendimento che i suoi genitori avevano assunto a Washington D.C. dopo che lui aveva rischiato di avere tutte le materie insufficienti, tranne storia. La donna aveva detto ai suoi genitori che Max doveva imparare un metodo di studio e lavorare sulla concentrazione, e doveva anche cercare di essere meno impulsivo. Questo, però, era senz’altro dovuto all’episodio della bici. Un ragazzo più grande aveva rubato la bici al suo amico Kevin e Max l’aveva inseguito. Fin qui niente di male, ma quando Max l’aveva afferrato, quello aveva perso il controllo della bicicletta e si era rotto il braccio. I genitori del ragazzo avevano dato la colpa a Max, e anche Kevin si era arrabbiato perché la sua bici dopo lo schianto era tutta storta.
Ma non era nulla in confronto a ciò che stava vivendo. Era sbarcato in uno strano Paese straniero dove la gente mangiava la carne di cavallo (sua madre gliel’aveva fatto notare al supermercato perciò Max sapeva che era vero) e quando parlava sembrava che scatarrasse, e gli era stato appena negato il diritto di frequentare una classe in cui si parlava una lingua che potesse capire. La scuola media era già abbastanza difficile in inglese, per non parlare poi degli amici. A Washington ne aveva alcuni, come Kevin e Malik, a cui piacevano i giochi di ruolo e i fumetti. Ma come avrebbe potuto farsi dei nuovi amici se non riusciva nemmeno a parlare?
Perfino il tempo sembrava essergli avverso. Pochi minuti prima c’era il sole, ma in quel momento un sottile strato di nuvole grigie stava coprendo il cielo.
Sentiva sua madre che lo incalzava, una tempesta di entusiasmo forzato.
«Potrai dormire fino a tardi! La scuola è dietro l’angolo. Claire dovrà alzarsi presto per prendere l’autobus…»