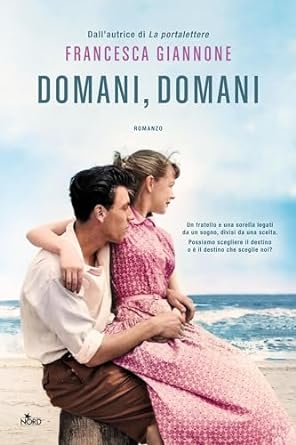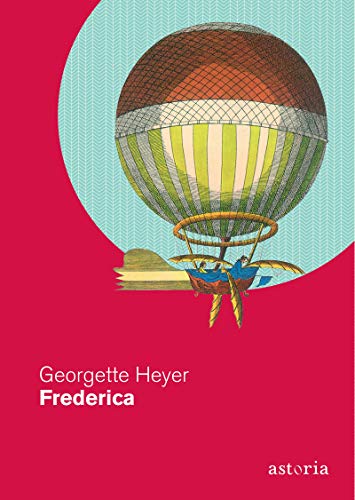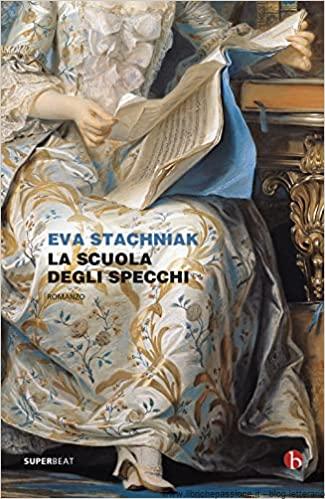

Parigi, 1755. Véronique Roux ha solo tredici anni quando, nella modesta stanza in affitto che divide con la madre e i fratelli, riceve la visita di un uomo alto e magro con una redingote di velluto viola e in pugno un bastone da passeggio. A monsieur Durand, questo il nome con cui l’uomo si presenta, basta una sola occhiata per rendersi conto che Véronique è delicata e graziosa, con i lineamenti di una bambola di porcellana e una figura dalla linea così morbida che nemmeno i vestiti grossolani possono rovinare. L’accordo, in men che non si dica, è preso: Véronique andrà a servizio, vivrà in una casa sfarzosa e sua madre avrà una bocca in meno da sfamare. Quello che la giovane non sa, tuttavia, è che dietro monsieur Durand si cela in realtà Dominique-Guillaume Lebel, premier valet de chambre du roi, colui che governa il regno dei piaceri più intimi del re. Luigi XV, stanco degli intrighi di corte, è diventato un appassionato di innocenza: aborrisce l’astuzia e l’artificio, detesta le guance imbellettate, gli abiti sfarzosi e i discorsi allusivi. Le donne che vuole nel suo letto devono essere pure e incorrotte. Dal momento che è impossibile materializzare all’improvviso fanciulle di questo tipo, il compito di Lebel è quello di giocare d’anticipo: nella città di Versailles, all’incrocio tra rue Saint-Médéric e rue des Tournelles, c’è una scuola in cui, sotto la sorveglianza di madame la marquise de Pompadour, vengono accolte le giovani e inconsapevoli ragazze in attesa di ricevere un’adeguata «istruzione». Si chiama Parc-aux-cerfs, ed è abbastanza vicina a palazzo da essere comoda ma abbastanza lontana da non attirare l’attenzione di cortigiani ficcanaso. Al momento giusto, ogni ragazza viene introdotta di nascosto a corte, attraverso la sua leggendaria Sala degli Specchi, e presentata al re… In bilico tra lo sfarzo abbagliante di Versailles e le ombre della Rivoluzione francese, La scuola degli specchi si addentra nell’avventura tragica della caduta della monarchia francese, restituendo appieno il volto vivido e oscuro di un’epoca.

Alla memoria di mia madre
Parigi 1793
Corre dietro al carretto che sobbalza, con il cuore che inciampa, corre, inciampa di nuovo.
È una mattina piena di brio, il cielo è azzurro come un uovo di pettirosso. Le strade sono vuote. Le case chiuse, le porte sbarrate. Qua e là i camini sputano pennacchi di fumo denso. Ha sentito mormorare che i traditori stanno bruciando i loro peccati. Madame Guillotine non è abbastanza veloce.
Il carretto, tirato da un unico cavallo, ondeggia. L’uomo sul pianale, i capelli un tempo neri ormai striati di grigio, si tiene aggrappato alla fiancata. La segue con gli occhi senza lasciarla andare, neanche per un istante.
Sul quai d’Orsay, scivoloso per la pioggia notturna, intravede una vecchia ossuta rannicchiata su una soglia. Sul pont de la Concorde un mendicante gobbo, con un sacco rigonfio sul petto, fruga in un mucchio di stracci.
In place de la Révolution, il carretto rallenta. Intorno a un patibolo si è radunata una piccola folla. Un bambino piange e viene subito zittito. Un cane abbaia.
Lei intravede il luccichio della lama e si ferma.
Prima parte
Versailles, 1755-1757
1755
Mia madre non mi spiegò molto.
Mi disse che sarei dovuta andare a servizio. Non era ciò che lei o il mio defunto padre avevano sperato per me, ma così doveva essere. Avrei potuto cavarmela bene, se solo avessi imparato in fretta, o meglio, se avessi imparato a compiacere. Sempre, non solo quando ti conviene, perché sei una fanciulla capricciosa, disposta ad ascoltare tutti tranne la tua carne e il tuo sangue.
Avrei forse dovuto immaginare quale affare aveva concluso in mio nome? Forse, ma ero ancora una bambina, anche se avevo già compiuto tredici anni. Non sapevo indovinare il pericolo nel silenzio tra le parole. Non conoscevo la sequenza di passi nella danza del sacrificio e del tradimento.
Il mestiere di mia madre erano i capi femminili usati. Vecchi vestiti di taffettà con gli orli sfilacciati, le ascelle marcite di sudore; eleganti abiti di corte, un tempo ricamati d’argento e oro, ormai privi di decorazioni; le gonne strappate e infangate delle suicide ripescate dal fiume. Odiavo quando li portava a casa per selezionarli e rammendarli, impregnati della puzza delle proprietarie precedenti, sporchi, infestati dalle pulci.
Allora abitavamo in rue Saint-Honoré, al quinto piano di un edificio che si affacciava sul mercato di Quinze-Vingts. Nella nostra vecchia casa, in rue des Jardins-Saint-Paul, c’era la tipografia di papa, che stampava e vendeva opuscoli e libri, e noi vivevamo nell’appartamento soprastante. Invece lì la stanza che avevamo preso in affitto era divisa con delle corde su cui appendevo ad asciugare il bucato. Dormivamo su brandine che ripiegavamo di giorno: in una i miei fratelli, io e maman in un’altra. Mangiavamo sul banco di lavoro sgangherato di papa, che fungeva anche da tavolo da cucito. Preparavamo i pasti nella cucina comune al piano di sotto, con il camino che tirava male e le pareti umide e ammuffite, teatro di continui litigi per la legna da ardere e lo spazio per spignattare, e talvolta di veri e propri furti. Il giorno stesso in cui ci trasferimmo imparai le regole di base: girati e il tuo cucchiaio di legno sparirà. Lascia la pentola incustodita e il tuo cibo svanirà.
Allora Marcel aveva undici anni, Eugène dieci, Gaston otto. Non frequentavano più la scuola parrocchiale, ma facevano dei lavoretti per il falegname o il macellaio che avevano le bancarelle nel cortile interno. Marcel sosteneva che la moglie del falegname si lasciava toccare le tette rosee. Eugène gli dava dello sfacciato bugiardo. Gaston imitava i fratelli maggiori con venerazione. Venivano a casa solo per mangiare e dormire. A volte, quando raccoglievo i loro vestiti per lavarli, nelle tasche scoprivo dadi, sassi o topi morti.
Come sarebbe stata Adèle se fosse sopravvissuta?
Maman diceva spesso che i bambini ti capitano. E poi capita che sopravvivano o muoiano. Dio, che aveva richiamato mia sorella al Suo fianco, è imperscrutabile. Può prenderti con sé perché ti ama o perché vuole punirti per i tuoi peccati.
La sera, sdraiata nel letto accanto a maman, pensavo a papa e Adèle, e mi chiedevo dove potessero essere. Immaginavo Adèle avvolta nella luce, gioiosa nella sua beatitudine paradisiaca, intenta a adorare il Trono celeste, serva fedele e amata di Dio. Immaginavo che con lei ci fosse anche papa; anche se a volte mi tornava in mente che non era un bambino e poteva aver peccato, e allora lo vedevo in Purgatorio, inquieto nella fila eterna di anime che attendono il momento della liberazione.
Il giorno in cui il mio destino fu deciso, ero in cucina a scaldare una pentola di stufato di fagioli: mescolavo di continuo per evitare che bruciasse, e al tempo stesso tenevo d’occhio i miei fratelli. Il camino mandava fumo come sempre. Gaston correva in tondo, urlava come posseduto dal demonio, si fermava per inspirare e ricominciava, con voce stridula e forte: «Qui, cagnolino, qui! Seduto! Zampa!»
«Sono un falco!» gridava Marcel, scagliandosi contro il fratellino.
«Prendilo, prendilo!» lo incitava Eugène.
Urlai che la smettessero e stavo minacciando di colpirli con il cucchiaio se non avessero obbedito, quando entrò di corsa la cameriera di madame Rambeaux, di cui si sussurrava avesse affogato il suo bastardo nella Senna. Maman mi voleva di sopra subito, disse.
Mentre Marcel mi sfrecciava davanti lo afferrai per un braccio e gli feci giurare che avrebbe smesso di prendere in giro Gaston. Lui acconsentì, poi dissi a Eugène di badare alla pentola e mi affrettai a salire.
«Dove sono le tue buone maniere, Véronique?» chiese maman, quando entrai accaldata e con il fiato corto. «Far aspettare così il nostro onorevole ospite!»
Fu allora che lo vidi: un uomo alto e magro con una redingote di velluto viola e in pugno un bastone da passeggio. La cipria con cui si era spolverato il viso rendeva più profonda la rete di rughe sulle guance, e lo faceva sembrare un cadavere. Più avanti avrei imparato a riconoscere con il nome corretto l’aroma muschiato che gli aleggiava intorno: ambra grigia.
«È lei quella che intendevate, monsieur…?»
«Durand» disse l’uomo completando la frase di maman.
Pensai che era altezzoso, perché quando maman lo implorò di sedersi, indicando l’unica poltrona sopravvissuta al trasloco da rue des Jardins, lui la guardò con disgusto. Forse a causa della pila di vestiti che torreggiava lì accanto, messi da parte per essere rammendati?
«È lei che intendevate?» ripeté maman, facendomi cenno di avvicinarmi. Lisciati la gonna, mi ordinò il suo sguardo. Stai dritta. Smettila di ansimare come un cane.
Sistemai la stoffa ruvida e grigia, mi strinsi il fichu di crespo intorno al collo. Era macchiato di marrone ma non sarebbe venuto pulito, quindi non valeva la pena venderlo. Mi costrinsi a rallentare il respiro.
Monsieur Durand faceva tap-tap sul pavimento con il bastone da passeggio.
Ebbi la vaga sensazione di averlo già visto, ma non ci riflettei molto. Allora gli uomini mi seguivano spesso, mi provocavano con discorsi sciocchi. Mi accusavano di aver scoccato una freccia nel loro cuore; sostenevano che sarebbero morti se non avessi concesso loro un bacio. Ero una bellezza rara, dicevano, una gioia per gli occhi.
Ma quale bellezza, replicava maman beffarda. Secondo lei ero dinoccolata, tutta ossa e spigoli acuminati. Bastava poco a montarmi la testa, vero?
Nanette la Grassa, che viveva nella stanza accanto, diceva che maman era gelosa. Ero delicata e graziosa, con dei lineamenti fini come una bambola di porcellana. La mia figura aveva una linea così morbida che nemmeno i vestiti grossolani potevano rovinarla. I miei occhi erano un raro miscuglio di azzurro e grigio, avevo ciglia lunghe e folte e una pelle radiosa. Bastava guardare i miei riccioli mogano dai riflessi ramati, diceva Nanette la Grassa, così serici sotto le dita. Un tempo, quando ancora gliene importava, avrebbe ucciso per avere un aspetto simile. Ahimè, la giovinezza non dura per sempre.
Monsieur Durand inspirò, secco e impaziente. I suoi occhi mi sfiorarono come se fossi solo uno degli oggetti di quella stanza ingombra.
«Sì, madame Roux» disse. «È lei».
La voce di maman si indurì. Ero una figlia buona e devota, dichiarò, la sua preferita, la più amata. Avevo un cervello sveglio e mani abili. Ero capace di imparare in fretta qualsiasi cosa. Disse che ero un tesoro, un gioiello per qualsiasi famiglia.
Monsieur Durand la interruppe bruscamente. «Possiedo una mente in grado di formulare giudizi autonomi». Poi si rivolse a me.
«Sai tenere pulita e in ordine una stanza?»
Annuii.
«Per caso sai anche parlare?»
«So tenere pulita una stanza» risposi.
«Sai leggere?»
«Sì. Me l’ha insegnato papa».
«Abbastanza bene da farlo ad alta voce?»
«Sì».
«Hai una buona grafia?»
«Sì».
«Non sei troppo modesta, eh?»
Mi ordinò di fare qualche passo a destra e poi a sinistra, anche se questo non c’entrava nulla con il saper leggere e scrivere. Feci quel che mi chiese, piuttosto maldestramente, dimenticandomi dell’asse inchiodata male che mi faceva sempre inciampare.
«Ho visto abbastanza, madame Roux» disse voltandosi verso maman.
«Lasciaci soli, Véronique» disse maman.
Fui felice di obbedire. Avevo già deciso che non ero piaciuta a monsieur Durand e che non l’avrei più rivisto.
Al piano di sotto, trovai Eugène, Marcel e Gaston seduti sul pavimento della cucina, spalla a spalla. Guardando sopra le loro teste vidi che tenevano in mano dei bastoncini, li infilavano in un favo e ne leccavano via il miele.
Eugène mi spiegò che non l’avevano rubato. Era il regalo di qualcuno che non potevano nominare.
Dita, labbra, canottiere, brache appiccicose, pensai. Un altro bucato. Un’altra stiratura. Perché devo essere la maggiore? E l’unica femmina?
Quando tornammo nella nostra stanza con la pentola di stufato di fagioli maman non disse nulla. Se non fosse stato per l’aroma persistente del profumo di monsieur Durand, avrei potuto anche fingere che non fosse mai venuto a trovarci. Ma quando ci sedemmo a tavola, maman non si lamentò che lo stufato era leggermente bruciato e ci lasciò persino prendere una seconda porzione. Non mi rimproverò perché giocherellavo con i capelli, non se la prese con Eugène perché parlava troppo; e quando si fece buio, accese due candele invece di una.
Quando i miei fratelli si furono messi a letto, dopo una serie di calci e gomitate, quando ebbi raccolto e piegato i loro vestiti e svuotato il loro vaso da notte nel bugliolo, maman mi fece cenno di sedermi a tavola di fronte a lei e si schiarì la voce.


Eva Stachniak è nata in Polonia. Laureata in Letteratura inglese alla McGill University di Montréal, ha insegnato inglese presso l’università di Breslavia, in Polonia, e allo Sheridan College di Toronto, Canada. Ha esordito nel 2000 con il romanzo, Necessary Lies, premiato come miglior opera prima dell’anno.
In Italia ha pubblicato Il giardino di Venere con Rizzoli (2005); Il Palazzo d’inverno (BEAT) nel 2014
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso