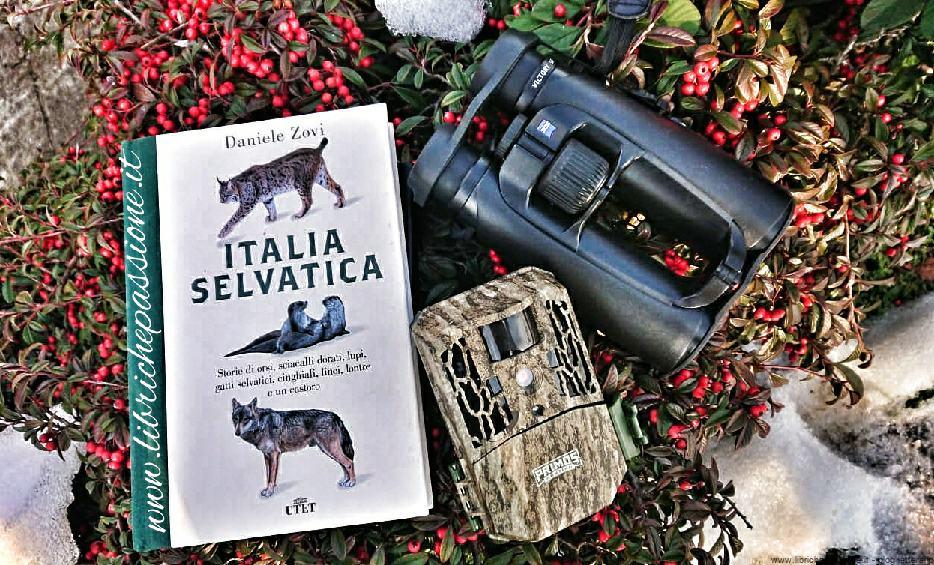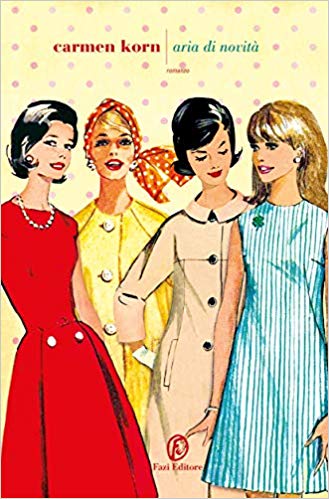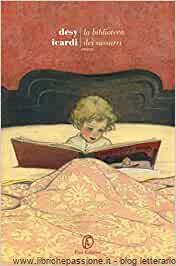Sinossi
Si narra che la Sibilla, adirata contro le fate che ballavano con i pastori, avrebbe scagliato loro le pietre che divennero poi il paese di Arquata: pietre destinate a rotolare drammaticamente di nuovo, durante il terremoto. Le sorelle Nadia e Olga si sentono a casa proprio qui, in questa terra che si muove, e che scendendo dai Sibillini verso il mare si fa campagna. Qui il loro papà ha trascorso la vita lavorando la terra, per questo ancora oggi la famiglia viene trattata con rispetto. Ma adesso tutto è cambiato. L’amore e il lavoro le hanno portate lontano, i figli sono cittadini del mondo. La gente vuole fragole e susine anche a gennaio. È una nuova stagione. E, per loro, è tempo di separarsi dalla terra. Inizia per le sorelle un viaggio a ritroso, nella memoria, e uno reale, attraverso gli incredibili colloqui con i possibili acquirenti del terreno, ex mezzadri arricchiti o emissari di multinazionali della frutta; tutti maschi, tutti ambigui, tutti apparentemente incapaci di capire quanto male facciano le radici, quando bisogna tagliarle. È davvero tutto immutabile nell’avvicendarsi delle generazioni, dei raccolti? Possiamo ancora sperare di lasciare questo pianeta un po’ migliore di come lo abbiamo ricevuto? Silvia Ballestra scrive un romanzo attualissimo e antico, come i luoghi dove è nata, cui dedica pagine di graffiante umorismo ma al tempo stesso piene della nostalgia e dello stupore di chi sente iniziare una nuova stagione.
Estratto
“Una posizione meravigliosa, un bel fiume profondo. Unica cosa è che, certo, bisogna mettere un po’ a posto, ripulire… In primo luogo, diciamocelo pure, buttar giù tutti i rustici, compresa questa casa, che non servono più a niente, tagliare il vecchio giardino dei ciliegi…”
Anton Čechov, Il giardino dei ciliegi
“Di lassù si vede luccicare il mare all’orizzonte e si abbraccia tutto intero il poderoso nodo montano; intorno, colline di forme capricciose, brevi pianure come piazzuole verdi e piccole valli scavate dai fiumi che, buoni buoni, se ne vanno dai monti al mare serpeggiando con grazia.”
Dolores Prato, Campane a Sangiocondo
L’estate che le mie cugine vendettero la terra fu un’estate di particolare siccità. L’anno con meno pioggia degli ultimi due secoli.
In compenso a luglio c’era stata una grandinata spaventosa sulla costa. Su un paio di paesi del sud delle Marche si era abbattuta una sassaiola di ghiaccio dalle zocche grosse come limoni. La spiaggia, dopo quella furiosa passata, era imbiancata manco fosse Natale. Tutte le tapparelle delle finestre verso nord apparivano bucherellate come per effetto di mitragliate. Facciate di case da rifare, tettucci e cofani delle macchine bugnati da piccoli crateri, foglie segate longitudinalmente, tendoni squarciati come da pugnalate, vetri delle finestre in frantumi. Era durato poco ma era stato stupefacente e, dopo, abitanti e turisti si aggiravano per le vie come se fossero stati flagellati, presi a schiaffi dal cielo.
Mesi prima, altri eventi eccezionali avevano ferito quei posti. Terremoti di forte intensità avevano colpito l’entroterra causando centinaia di vittime e danni terribili a decine di paesi. Era successo in agosto, poi di nuovo a ottobre, poi a gennaio.
Con i terremoti dell’inverno era arrivata anche un’enorme nevicata che aveva provocato una grossa valanga: tonnellate di ghiaccio e pietre e alberi e neve avevano investito un albergo abruzzese seppellendolo e uccidendo ventinove persone.
Quella parte di Italia, il centro del paese che molti indicavano con immagini come il cuore, o la spina dorsale, dunque oltre che luogo mediano e interno anche nucleo innegabilmente vitale e forte, capace di irrorare e dare rilievo a tutto il resto, era sotto shock da allora, dalla notte di agosto di un anno prima. E faticava a riprendersi.
Era come se quei luoghi, da sempre dolci e domestici, accoglienti e benigni, si fossero trasformati in posti aspri e oscuri. Incattiviti. Imprevedibili. Sibillini come il nome di una delle loro catene montuose.
Le quiete colline si muovevano. In montagna, le gole normalmente percorribili franavano. Le belle piazze dei paesi si mostravano ostili. Gli amati borghi sembravano volersi liberare degli abitanti, svuotarsi. Le casette di pietra antiche, magari ingentilite da belle linee e decori, si scrollavano via pareti e tetti e balconi, avendo avuto l’accortezza di allontanare tutti con una scossa di avvertimento che aveva evitato altre vittime.
La terra sgroppava.
Lo aveva sempre fatto, nei secoli, ma in quel modo brutale e spaventoso non succedeva da un pezzo. I più vecchi erano stati portati via, alcune famiglie e certi giovani tenaci provavano a resistere, ma molti si erano trasferiti altrove, scacciati dai crolli e dalla tensione continua per le scosse che non cessavano, seppure ormai si manifestassero solo a bassa intensità, come brontolio, come ringhio sommesso.
Per pura coincidenza, non troppo distante da quei luoghi, fu in quei mesi che le mie cugine Olga e Nadia Gentili si separarono dai terreni che la loro famiglia aveva posseduto
più o meno da dopo l’Unità d’Italia: al contrario di chi si era visto crollare il mondo addosso, loro con quella vendita chiudevano per sempre una piccola storia e si congedavano da un passato remoto e dai luoghi di famiglia, per scelta. O, almeno, così pensavano loro.
Fu una strana estate. Sospesa, di passaggio.
Mi capitò di accompagnarle in un paio di occasioni (la visita all’ufficio tecnico del Comune di Altodono, una sortita alla ricerca di una macchina cippatrice a Servino) e ne approfittavamo per entrare e uscire dalle chiese, aggirarci per le vie, ammirare le mura dei paesi come se le vedessimo per la prima volta.
Dopo quello che era successo, un nuovo affetto ci legava a quei posti. Una volontà di cura, di protezione, di conoscenza.
Perché, mi aveva detto Olga che fra l’altro non viveva più lì da tanto tempo, era vero: quei posti la facevano dannare, e spesso l’avevano fatta sacramentare, ma lei non gli aveva mai voluto bene come in quei mesi terribili.
Quei luoghi le davano delle preoccupazioni, dei pensieri e talvolta anche dei dispiaceri, ma non poteva fare a meno di loro.
E lei, che veniva da una famiglia di proprietari terrieri, queste figure che risalivano a un passato di cui, diversamente da altrove, ci si era liberati in modo incruento e graduale e in fondo da poco, si trovava a fare i conti non solo con la materialità dei suoi beni, ma anche con i ricordi dell’infanzia, con la vita di tante persone che avevano lavorato insieme a lungo e con l’alternarsi di stagioni, più o meno floride, più o meno dense, che avevano governato quei luoghi come un regno. Ma di chi erano quei luoghi? Di chi li aveva accuditi o di chi li sentiva suoi per esserci nato e cresciuto?
Nel momento in cui a Olga, alla sorella Nadia e alla madre Liliana toccava fare un passo indietro affidando ad altri ciò che era stato il loro vecchio patrimonio, tutti gli sforzi e l’umana piccolezza dell’avvicendarsi su quella terra le tornavano in mente in forma di lascito e retaggio, storia sommersa e comune che veniva allo scoperto.
Come ogni anno, a giugno facemmo un’escursione sulla Sibilla, questa montagna che per secoli aveva attirato viandanti, pastori, pellegrini e ora turisti.
Sorge, maestosa e allo stesso tempo accessibile, fra il monte Vettore e il monte Priora. Per arrivarci bisogna puntare su Montemonaco, un grazioso borgo dallo spettacolare balcone a sprofondo su verdissimi dirupi, dove ci si può fermare a rifornirsi di panini con la lonza o con il ciauscolo. Fette di pane enormi che richiedono buone mascelle, da accompagnarsi poi con un dolce ricotta e cioccolato o con una fetta di crostata alle visciole comprati al forno del paese. Roba buonissima, vere bombe che aiutano ad affrontare le scarpinate in quota.
Presi i rifornimenti in centro, si ripartiva verso la frazione Collina, da dove sarebbe iniziata la salita in macchina fino al rifugio, su una pietraia che, dal basso, sembrava una serie di zeta sovrapposte e schiacciate, un vero sfregio alla montagna. Una strada di un chilometro e mezzo che però faceva più impressione vista che affrontata. Una volta imboccata, saliva, sì, con i suoi bei tornanti, ma era larga abbastanza e percorribile senza troppi problemi. A metà c’era sempre un gregge con la guardiania di cani bianchi – il pastore, invisibile, forse ricoverato nella roulotte ai lati della strada, forse al bar giù in paese – che a volte abbaiavano a volte ti fissavano in preoccupante silenzio. Se guardavi bene, passando, potevi vederne un paio immobili dietro le rocce, disposti a protezione del gregge secondo orientamenti noti solo a loro.
Nel parcheggio del rifugio c’erano, di solito, non più di tre-quattro macchine, almeno in quei primi mesi estivi e a metà settimana, i giorni che sceglievamo noi per non incontrare troppe persone.
Avevamo cominciato a fare escursioni solo da una ventina d’anni, da quando erano nati i figli di Olga e Nadia. La generazione dei nostri genitori era più per la montagna in inverno: sci e slittino, camminare neanche a pensarci.
Poi noi avevamo cominciato a salire dalla costa, a esplorare la parte montuosa della nostra regione proprio per “spezzare il mare”, mettere una pausa ogni tanto al fluire di nuotate e sudaticcio e cappone d’afa che dai primi anni del nuovo millennio, già a fine maggio, attanagliava pianura e città anche per settimane.
“Passami le racchette,” avevo chiesto a mia nipote, che mi aveva guardato beffarda mentre prendeva gli zaini dal bagagliaio della macchina.
“Sì, sono una vecchia,” dissi. “Le racchette servono a noi vecchie. E se continui a ridacchiare te ne do una in testa. Come fanno, per l’appunto, le vecchie.”
Ero fiera delle mie racchette. Da quando ne avevo acquistato un paio blu metallizzato, per quindici euro, scendevo che era una meraviglia. Servivano più per la discesa che per la salita.
“Sembra ieri che dovevamo metterli negli zaini porte-enfant,” disse Olga. “E adesso ci prendono in giro se rallentiamo un po’ per rifiatare.”
“Sì, fino a pochi anni fa li portavamo alla festa delle streghe e dei folletti di Montalto e adesso dicono che le streghe le portano loro.”
“Yuuuhu,” ci salutarono ormai a distanza i ragazzi, decisi a raggiungere il luogo che la leggenda voleva ritrovo di demoni e ombre notturne ma che al sole del mattino estivo era una magnifica meta da escursione classificata “facile”.
Nadia, Olga e io avevamo camicie leggere, scarponcini vintage antistorta e antivipera che avevano già affrontato il ghiaione delle Lame Rosse e i pantani di Accumoli, un paio di zaini con il mangiare e le bottigliette dell’acqua, felpe annodate in vita.
“Imo,” aveva proclamato Olga, facendosi scudo al sole con la mano. Forse in italiano esisteva solo “ite”, ma non importava. Era uno sprone. Partimmo.
La prima tratta era ancora abbastanza erbosa, poi i ciuffi si diradavano e i fiori di campo lasciavano il posto alle specie appenniniche: cardi, stelle e fritillarie che occhieggiavano, piccole e isolate, gialle e viola, tra i sassi.
All’inizio era meglio procedere in silenzio. Già dopo dieci minuti il sole picchiava sul coppino. Mi fermai a mettermi una manata di crema dietro il collo e quando ripresi a camminare mi accorsi di essere rimasta ultima. Le mie cugine salivano e avevano già svoltato un tornante; i ragazzi, avanti, manco si vedevano più. Attorno ronzavano insetti a tutto andare e avevo la netta impressione che l’odore pungente della crema protettiva li richiamasse tutti su di me.
A destra si apriva il panorama verso il mare. Da quella parte c’era Montefortino e, celata alla vista, Amandola. Era la parte dell’Infernaccio, con la sua gola ombrosa e sgocciolante. In fondo, nella spaccatura che divideva la Sibilla dalla Priora, le sorgenti del fiume Tenna ruscellavano nelle “pisciarelle”, un nome graziosetto, e allo stesso tempo crudo e sboccato, per le cascatelle sotto cui dovevi passare per forza, volendo affrontare la salita all’eremo di San Leonardo. Da noi era tutto così: pizzo del Diavolo e Infernaccio e Passo Cattivo, ma anche pisciarelle. Escursioni per famiglie, ma anche elisoccorso che ogni tanto doveva andare a ripescare qualche tedesco in cordata sul Palazzo Borghese o aiutare comitive di boy scout rimaste bloccate nell’Ambro. Placide terme per anziani a Sarnano, ma anche terremoti da cui dover fuggire a gambe levate. Posti da picnic domenicale, ma anche campi paramilitari a Venarotta per terroristi neri di Ascoli Piceno. Culto dei papi mandati a Roma da quelle terre, ma anche bestemmie a profusione. Divino e pagano, antico e moderno. Musica e urlo.
Scossi la testa; così, da sola. Pensai alla piscia della befana, di cui parla un Leopardi dodicenne in una lettera scherzosa a una conoscente, firmata, appunto, “la befana”.
Procedevo, puntando le mie picche accordate al ritmo dei passi – corti e regolari come si raccomanda in montagna – e pensavo alla natura matrigna, a come si era rivelata all’improvviso, da quelle parti, mesi addietro.
Pensavo che non eravamo certo i primi ad assistere a sconquassi del genere lì, ma pensavo pure che i precedenti più gravi risalivano a centinaia d’anni prima. E che a Norcia, per esempio, di là dal Vettore alle mie spalle, sotto la stupefacente piana di Castelluccio, la basilica aveva sofferto per vari terremoti ma solo questa volta si era sbriciolata.
Seguivo docilmente il sentiero sapendo che la leggenda della Sibilla suscitava ancora meraviglia e interesse, pure dopo secoli, anche se non riuscivo a cogliere il lato pauroso della faccenda. Nel tempo, poi, la sua figura era cambiata, attraversando paganesimo e cristianesimo, dai culti del sole, delle pietre e della terra, alla stregoneria medievale, passando per la letteratura, fino ad arrivare alla saggezza matristica di conoscitrice ed esperta di tecniche agricole, allevamento, artigianato, medicina e alimentazione. C’era chi si lasciava affascinare dal lato erotico della Sibilla, regina bellissima che con le sue fate e il ballo del saltarello insegnava ai giovani l’arte della seduzione, e chi si soffermava sul suo ruolo di depositaria della memoria e sulle capacità di vaticinio del futuro.
La storia, narrata la sera nelle veglie notturne, col fiato delle bestie e l’odore di ammoniaca che saliva in vapore dai pagliericci alla luce di candele, voleva che nella grotta dentro la montagna che ora mi si parava davanti vivesse una signora che, seduta al telaio, tesseva una trama con raggi di sole filtrati dalle crepe sulle rocce intrappolandoli nel suo ordito. E che nel tessuto di luci e ombre rimanesse impigliato il tempo in disegni e colori diversi, per le donne e per gli uomini, per gli animali e per le piante. E che ogni giorno le tre sorelle della signora indossassero i vestiti ricavati da quei tessuti, nei quali erano fissati i segni dello scorrere delle stagioni e degli eventi. La sorella vestita di bianco portava il vento, quella di rosso e oro portava il caldo di mezzogiorno, la sorella vestita di nero il sonno. Chi voleva cambiare vita doveva arrivare al telaio, guardare i disegni della stoffa e porre tre domande alla tessitrice, ma non doveva farlo per sé o con il misero intento di arricchirsi e ottenere potere, altrimenti le sorelle lo avrebbero punito: la bianca scaraventandolo sulle rocce con il suo figlio vento, la rossa facendolo bruciare da suo figlio sole, la nera buttandolo nella voragine davanti alla grotta e condannando le sue ossa a mai dormire e a illuminarne l’entrata con il loro biancore.
E questa era solo una delle storie su quei monti magici…
L’ autrice
SILVIA BALESTRA, marchigiana, vive e lavora a Milano. È autrice di romanzi, raccolte di racconti, saggi e traduzioni, pubblicati per i maggiori editori italiani. Fra i suoi libri, tradotti in varie lingue, i long seller Compleanno dell’iguana, Gli Orsi, Nina, I giorni della Rotonda, Amiche mie e Vicini alla terra. Storie di animali e di uomini che non li dimenticano quando tutto trema. Dal romanzo La guerra degli Antò è stato tratto l’omonimo film diretto da Riccardo Milani.