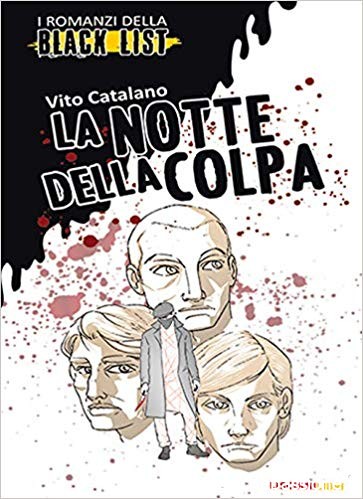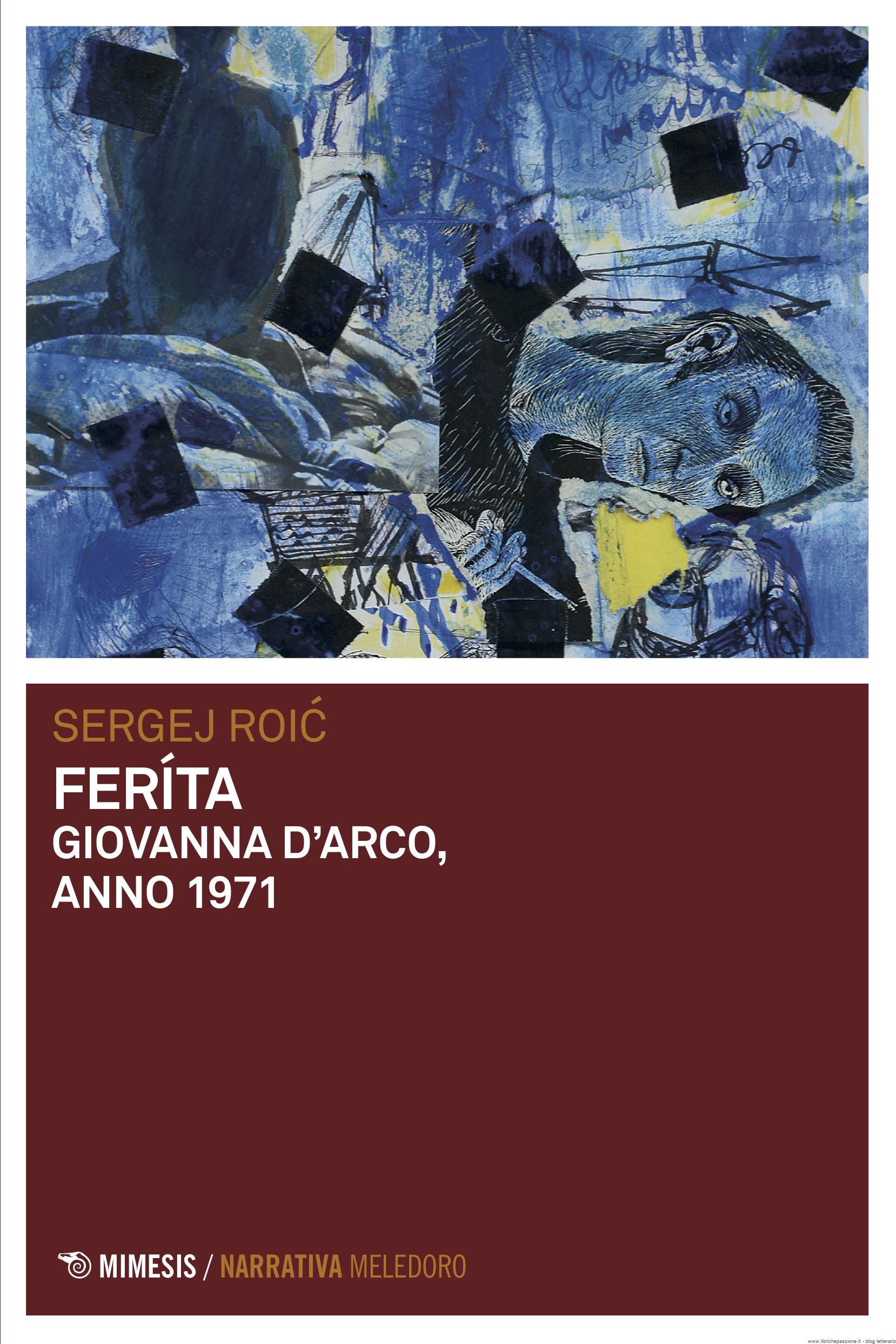Disponibile da domani


L’incanto del Giappone in compagnia di un indimenticabile micio
CJ ha trascorso la vita fuggendo dai problemi. Nessun luogo è mai riuscito a trattenerla troppo a lungo e per questo, quando si imbatte in una proposta di lavoro come insegnante in una scuola giapponese, accetta: si tratta solo di un breve periodo e potrebbe essere l’occasione giusta per mettere da parte un po’ di soldi in attesa di capire cosa fare del proprio futuro. Una volta arrivata, scopre che ad attenderla nell’appartamento messo a disposizione dalla scuola ci sono due tenerissime gatte di cui dovrà prendersi cura. La strana convivenza diventa ancora più bizzarra quando un nuovo ospite si aggiunge alla compagnia: un micetto randagio dal meraviglioso pelo color argento salvato dalla strada, che diventa un inseparabile compagno di viaggio nella scoperta del Giappone. Il Paese dei petali di ciliegio, infatti, sta esercitando un richiamo sempre più forte, e CJ si accorge che con il passare dei giorni qualcosa sta cambiando dentro di lei. Non sente più il desiderio di arrendersi di fronte alle prime difficoltà ed è pronta a trovare il suo scopo nella vita, il suo ikigai…
Quando arriverà il momento di ripartire sarà pronta a fare tesoro dell’antica filosofia giapponese per cercare la sua felicità?
Alla scoperta del paese dei petali di ciliegio tra divertenti imprevisti, incontri inaspettati e tanti gatti
Vincitore dell’International Book Awards
«Un libro delizioso, che piacerà moltissimo agli amanti dei viaggi e degli animali.»
«Ho avuto l’impressione di essere in Giappone e di poter ammirare i panorami pittoreschi descritti dall’autrice con i meravigliosi gatti che ha trovato – e amato.»
«È come una brezza leggera e gentile.»

Nuovi inizi
Pare che siano i gatti a scegliersi il padrone. Gershwin scelse me. Se non fosse stato per lui, la mia vita sarebbe andata in tutt’altro modo. E certamente non sarei rimasta in Giappone.
Chi mi avesse visto quando ci andai per la prima volta avrebbe usato un detto giapponese per descrivere l’espressione che avevo: neko ga cha o fuku you na, che potremmo tradurre all’incirca con «la faccia di un gatto che soffia sul tè per raffreddarlo».
Non che il Giappone non mi fosse piaciuto, al nostro primo incontro. Ma non lo trovavo all’altezza delle mie aspettative, o quantomeno delle aspettative che mi ero creata leggendo le patinate brochure dell’agenzia viaggi.
Nella frenetica Osaka, le bellissime casette di legno da samurai che avevo sognato non esistevano. Il mio appartamentino formato scatola da scarpe era letteralmente delle dimensioni di un bentō. Nemmeno per Marie Kondo sarebbe stato facile tenere in ordine uno spazio tanto angusto. Il lavoro che facevo al computer era arido, e l’assoluta estraneità di ciò che mi circondava mi riempiva di dubbi.
Quando misi piede fuori casa, quel primo mattino a Osaka, per percorrere un dedalo di viuzze e giungere al mio nuovo posto di lavoro, mi sentii sopraffatta e stranamente mogia, «come un gatto in prestito», secondo il detto giapponese. Arrancavo nel caldo soffocante, lungo strade sovraffollate, con la sensazione di essere una comparsa nel film Lost in Translation. Il fragore quotidiano di Osaka era quanto di più lontano dalla serenità che avevo immaginato. In una città che sembrava parlarti di continuo, la musica pulsante delle sale da pachinko e i semafori canterini che dicevano ai passanti quando attraversare la strada erano un abuso dei sensi.
Non mi piaceva affatto sentirmi come un gatto in prestito. Avrei senz’altro preferito prenderne in prestito uno. Tutto mi spingeva a cercare un gatto che potesse placare la mia ansia… o il più vicino Cat-Café.
Più di cent’anni prima, quando il famoso scrittore giapponese Natsume Soseki era arrivato a Londra, gli inglesi lo avevano fatto sentire sciatto e decisamente bizzarro, come «un povero cane in un branco di… gentiluomini». Per quanto mi riguardava, quella di Soseki era stata una lunga passeggiata nel parco in confronto a come mi sentivo io nelle strade di Osaka.
Possibile che avessimo davvero firmato un contratto di un anno? Io e Ryan, il mio compagno, avevamo tanto desiderato entrare a far parte della scuola di lingue più grande e famosa di tutto il Giappone.
Era stata proprio la possibilità di lavorare con gente di nazionalità diverse a convincermi a fare domanda in quella scuola, poiché vantava insegnanti di francese, spagnolo e mandarino. Ma in men che non si dica ero finita relegata al tavolo degli «anglo» senza poter parlare con i colleghi europei o cinesi… una vera delusione.
Col passare dei giorni compresi di essere andata in Giappone perché ero scappata da qualcosa. E siccome non volevo assolutamente tornare in Inghilterra, mi sforzai di trarre il meglio dalla situazione. Dopotutto in quella città c’erano anche cose che mi piacevano, come l’ordine e la pulizia. Diversamente da quanto accade nelle stazioni ferroviarie occidentali, in cui i pendolari devono farsi largo in un labirinto di sacchi dell’immondizia, riuscivo ad attraversare le stazioni della metropolitana senza preoccuparmi che il sacchetto di un fast-food gettato a terra mi si appiccicasse al tallone, o che un chewing gum masticato mi si attaccasse alla suola delle scarpe. Anche se nei vagoni le persone erano schiacciate come sardine e se ne stavano sull’attenti per occupare meno spazio possibile, i pendolari giapponesi facevano la fila ai tornelli metallici come si usava una volta, senza nemmeno l’ombra dell’esasperazione e degli spintoni a cui ero abituata in patria.
Ma non appena questi pensieri avevano iniziato a popolarmi la mente, avevano avuto inizio anche le mie giornate lavorative, riportandomi bruscamente alla realtà. Ero un’impiegata di una delle più grandi scuole di lingue del Giappone.
Le mie lezioni di quaranta minuti sembravano durare come i quaranta giorni e le quaranta notti della tradizione. Faticavo con il sistema di videoconferenza, senza capire perché dovessi insegnare dai locali della scuola mentre avrei potuto benissimo farlo dalla comodità di casa. Mi era piaciuta l’idea di avere un ufficio nel quartier generale del centro multimediale, ma non avevo capito che mi sarebbe sembrato di lavorare in un call center e non in un istituto educativo. Ogni quarantacinque minuti, tre nuove facce giapponesi comparivano sul mio schermo con la ciclica precisione del nastro trasportatore di un ristorante di sushi. Studenti sempre nuovi, tutti i giorni. Nessuna continuità. Non arrivavo mai a conoscerne uno.
Contavo sulle dita i modi in cui l’organizzazione si era impossessata di me. Uno, mi avevano scelto l’appartamento senza consultarmi. Due, mi avevano ordinato quale volo prendere. Tre, mi avevano imposto il tipo di cellulare da usare. Avevano programmato ogni
momento e ogni aspetto della mia vita, instradandomi verso una destinazione predeterminata. Tutte scelte che, fino a quel momento, avevo sempre fatto da sola. Mi sentivo come un’attrice che segue un copione, alla mercé di un telecomando nelle mani di qualcun altro.
La rigidità aziendale e l’insegnamento in stile catena di montaggio mi costrinsero a rimettere tutto in discussione. Ma se avessi lasciato quel lavoro sarei dovuta tornare in patria, e avevo le mie buone ragioni per non volerlo fare. Ragioni dolorose.
Alla fine, mentre masticavamo delle alghe croccanti, io e Ryan decidemmo che ne avevamo abbastanza.
Dopo una sola settimana a Osaka, preferivamo darci un taglio e tornare in Inghilterra.
Non gli dissi che quel continuo scappar via, in Australia, un anno prima, e poi in Giappone, cominciava a mettermi a disagio. Ma pensavo che forse avrei fatto meglio a tornare in Inghilterra per provare a crescere.
Eppure, il giorno in cui prenotammo il volo per tornare in patria, assistetti a una scena destinata ad avere un impatto decisivo su di me, anche se sul momento non lo sapevo ancora. Nel cuore della città, vidi una massa di pedoni che rallentavano tutti insieme, come accade quando c’è un incidente d’auto in strada. La cosa mi stupì, perché di solito niente può interferire con il flusso di una folla di giapponesi.
Un uomo calvo, in vestaglia, con i sandali ai piedi, passeggiava per strada seguito da un gatto tricolore, avanzando pianissimo in una metropoli in cui di solito la gente galoppa. Quel monaco buddista zen, che procedeva con un’andatura così rilassata e sprezzante, era una muta dichiarazione d’intenti contro la frenetica vita urbana.
Avrei voluto seguirlo, chiedergli come facesse a mantenere quella calma serafica mentre tutto attorno la città correva. Ma non osavo farmi avanti: così restai a fissare il suo chimono grigio che svoltava in una stradina laterale e svaniva con quel piccolo discepolo tricolore che gli marciava dietro in meditabondo silenzio.
Il giorno dopo io e Ryan facemmo gli ultimi preparativi per la partenza. Ma nel sottoscala della mia mente ero tormentata dal pensiero che forse, in fin dei conti, non era una buona idea. Forse quel monaco aveva voluto dirmi che, partendo, mi sarei persa non so quale profonda esperienza. Ma ormai ero incastrata, stavo tornando nella mia vecchia cara Inghilterra.
In quel momento non lo sapevo ancora. Ma solo un mese più tardi, sarei stata attirata di nuovo in Giappone da altri due gatti.
Capitolo 1
Come un gatto in prestito
/ Karite kita neko no you
Quando arrivammo per la seconda volta all’aeroporto internazionale Kansai di Osaka, una mattina di dicembre, ogni cosa era radicalmente diversa rispetto a un mese prima.
Tanto per cominciare, io e Ryan sapevamo cosa aspettarci. Niente più shock culturale. Niente sbalordimento. Niente frustrazione. Niente conflitto interno. Solo grandi masse di viaggiatori giapponesi, luci e colori esageratamente brillanti, continui annunci agli altoparlanti e il rombo dei motori dei jet.
Secondo, stavolta sapevamo che Osaka – l’immensa metropoli dai neon accecanti, dalle strade sovraffollate e dal frastuono assordante – non sarebbe stata la nostra destinazione finale. E, terzo, nessuno dei due aveva voglia di voltarsi indietro. Eravamo convinti che quella che stavamo facendo fosse la cosa giusta.
Ad accoglierci all’aeroporto sarebbe venuto un essere vivente in carne e ossa, in grado di parlare inglese, che si sarebbe detto lieto di conoscerci e disposto a farci da guida. E poi la cosa più importante di tutte: nell’appartamento che ci era stato assegnato c’erano due gatti. Ero cresciuta tra i gatti e sapevo che i felini riuscivano sempre a trasformare un luogo triste in qualcosa di più simile a una casa. Sarebbero stati in grado, quei gatti giapponesi, a farmi sentire un po’ più stabile nella nuova città?
Avevamo trovato quel lavoro frugando in vari siti web inglesi, ma la cosa ci era sembrata subito fin troppo bella per essere vera.
Keith – il grosso, allegro australiano proprietario della nostra nuova scuola – ci aspettava in un ristorante dell’aeroporto. Era molto più alto di quanto mi aspettassi, tanto che sembrava torreggiare su me e Ryan. Aveva una gran testa pelata, lucida e brillante, che rifletteva le luci dell’aeroporto, occhi di un azzurro metallico, profondamente incassati nelle orbite dietro agli occhiali dalla montatura sottile, il pizzetto e un sorriso radioso. Era vestito casual, con degli stivali di pelle nera e una maglietta bianca infilata nei jeans stinti. Non proprio il tipico proprietario di un’impresa commerciale, né il tipico educatore. Solo guardarlo mi fece sentire subito meglio.
Le prime parole che gli uscirono di bocca furono: «Di persona siete molto meglio che in foto». Ci strizzò l’occhio. In pratica era un abbraccio che camminava. Capii subito che mi sarebbe piaciuto.
Keith ci diede una mano a ficcare i bagagli nel retro del suo SUV compatto, poi io saltai sul sedile posteriore lasciando a Ryan quello anteriore.
Il nostro nuovo capo ci accompagnò nella nostra nuova casa. Si trovava nella remota cittadina di Hida-Takayama, prefettura di Gifu, sulle Alpi giapponesi, 312 chilometri a nord di Osaka, nella parte più occidentale dell’isola di Honshu. Una corsa di circa quattro ore per raggiungere i due gatti che avremmo ereditato insieme all’appartamento.
Anche se era fine dicembre, la massa d’aria gelida proveniente dalla Siberia non aveva ancora attraversato il Mare del Giappone, raccogliendo giganteschi quantitativi di umidità e scatenando giorni e settimane di incessanti burrasche di neve; quindi la strada era asciutta e, con mio grandissimo sollievo, assolutamente sicura, mentre ci arrampicavamo sui fianchi delle montagne. Purtroppo, nel momento in cui entrammo nella prefettura di Gifu, il jet lag ebbe la meglio su di me.
Mi sentivo sfinita e disorientata, e feci il possibile per non vomitare nella Toyota Rav 4 rosso granata di Keith.
Più di quattro ore dopo l’inizio del viaggio, circondati da alte montagne che sembravano toccare il cielo grigio, entrammo a Takayama.
Oh! Quello era il Giappone che avevo sognato quando io e Ryan avevamo cominciato a parlare di andare a insegnare in quel Paese. Bassi edifici in legno, sia residenziali che commerciali, costeggiavano le viuzze della città. Niente ingorghi d’auto, niente folle che correvano senza tregua su e giù per i marciapiedi. Tutto attorno a noi, solo silenzio e pace.
Keith parcheggiò accanto alla palazzina a due piani che ospitava la nostra nuova casa, e che era stata lo studio di proctologia del defunto marito della padrona. Per arrotondare, lei aveva trasformato parte del primo piano in un grande appartamento in affitto, a uso esclusivo degli insegnanti della nostra scuola.

Scrive e collabora anche con riviste giapponesi, tra cui il «Japan Times». Vive a Sydney.