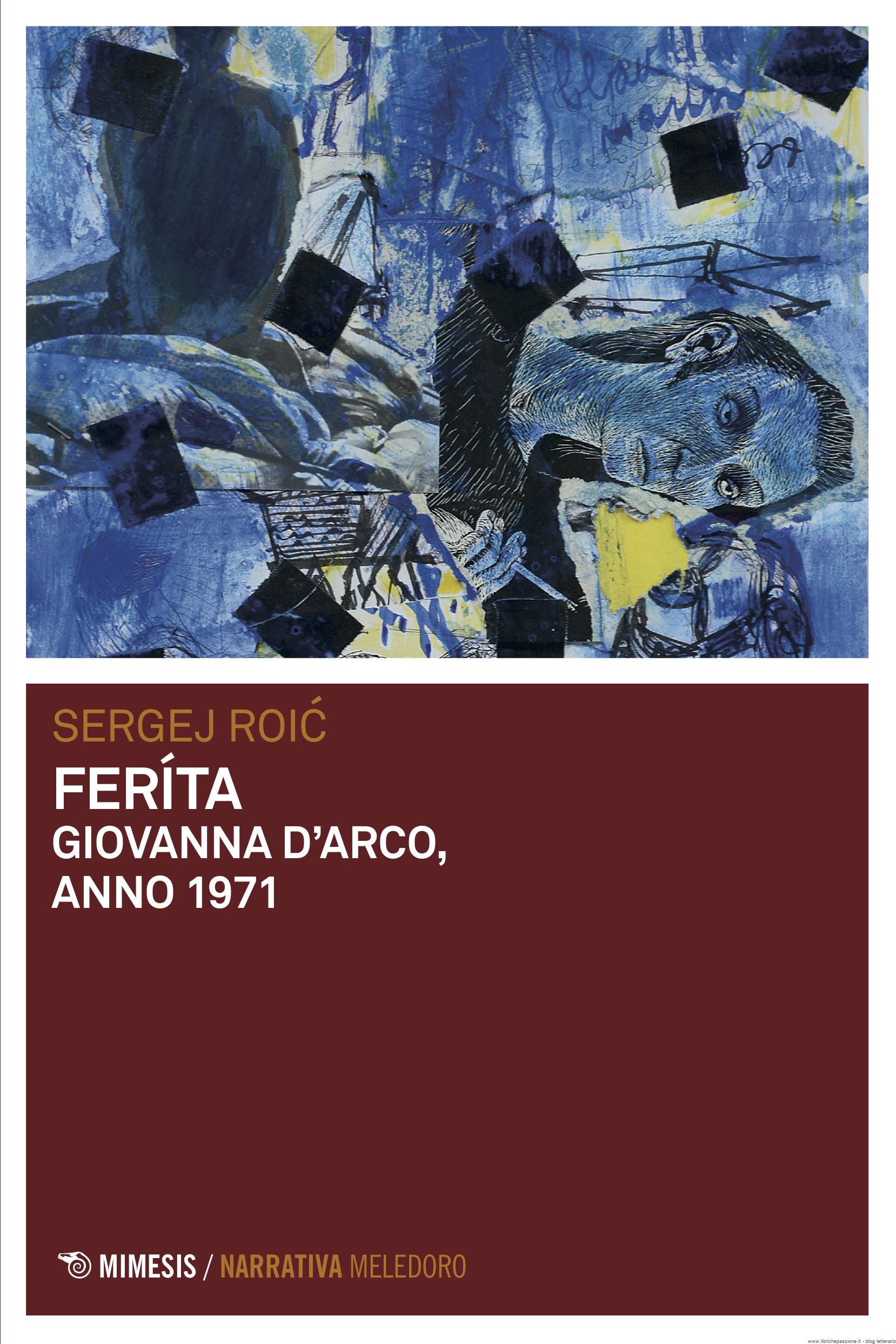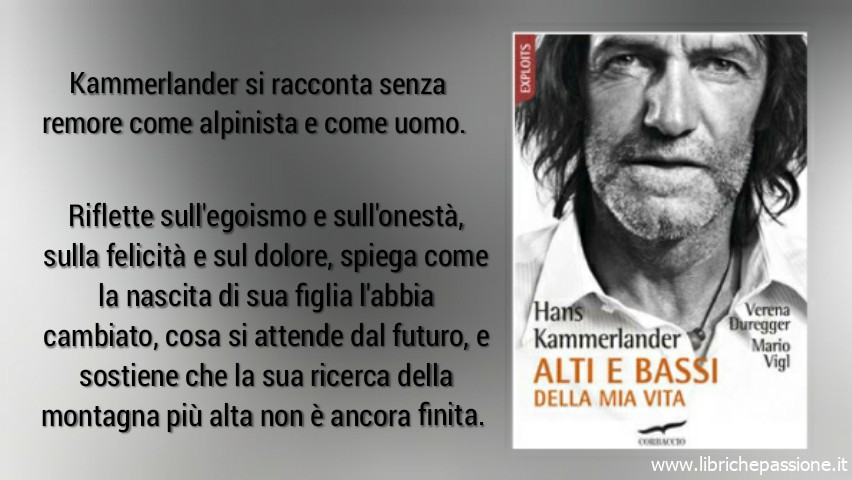
Ultimo di sei figli, Hans Kammerlander è nato ad Acereto, in Alto Adige e ha trascorso la sua infanzia nella fattoria di famiglia, senza minimamente sognare che un giorno avrebbe scalato le montagne più alte della Terra, che sarebbe sceso con gli sci dall’Everest e che avrebbe contribuito a scrivere la storia del Nanga Parbat. Né, tanto meno, immaginare che in un’esistenza al limite, fatta di record, competizioni e decisioni da prendere in situazioni estreme, avrebbe commesso l’errore peggiore della sua vita proprio nella sua valle. In questo libro, Hans Kammerlander rivela quella parte di se stesso che si cela dietro l’alpinista eccezionale, raccontando degli amici scomparsi in montagna e del pauroso incidente mortale di cui è stato responsabile. E riflette sulla differenza tra la felicità di raggiungere una cima e il successo per averla raggiunta, sulla disciplina e sul piacere. E sottolinea quanto sia importante, fra gli alti e i bassi della propria vita, portare a compimento la strada intrapresa.

Estratto
Per i nostri figli
Zara, Leni, Emilia, Josef e Konstantin
L’inizio
Se dovessi definire la mia vita in due parole, sceglierei «montagna» e «valle». Ricordo ancora il maestro delle elementari di Acereto che ci parlava della montagna più alta della Terra, o quando seguii per vari giorni, da casa, inchiodato davanti alla radio con mio fratello, la salita della Cima Grande di Lavaredo portata a termine da tre alpinisti della Sassonia. All’epoca mai mi sarei sognato che un giorno io stesso avrei raggiunto la cima dell’Everest e di tutte le altre montagne più alte della Terra. Per non parlare del fatto che anch’io avrei avuto l’onore di scrivere pagine di storia dell’alpinismo, prima come partner di cordata di Reinhold Messner, fino al suo quattordicesimo Ottomila, e in seguito come protagonista, grazie al mio record di salita dell’Everest, per le discese con gli sci del Nanga Parbat e dell’Everest, o per la mia «prima» allo Jasemba.
Record, velocità, spirito competitivo: tutto ciò ha influenzato a lungo la mia vita. Eppure allora non avrei mai ammesso che fosse in corso una sorta di gara alle vette più alte e che io ci fossi dentro, in pieno. La nascita di mia figlia Zara, dieci anni fa, ha chiuso in modo definitivo questa fase. D’altra parte, anche quando ho affrontato le Seven Second Summits ho avuto la sensazione che dall’esterno mi venisse imposta la competizione.
Per noi alpinisti l’agonismo è allo stesso tempo una benedizione e una maledizione. Troppi fra i miei partner di cordata hanno perso la vita in montagna, fra loro molti cari amici. Vedere con i propri occhi un compagno morire in montagna cambia molto la prospettiva. Oggi so che è preferibile tornare al più presto a una montagna legata al ricordo di una disgrazia. Eppure ci sono voluti più di venticinque anni prima che riuscissi a tornare al Manaslu, dopo la tragica spedizione del 1991. Il ritorno alla «montagna dello spirito», che per molto tempo per me ha rappresentato il male, mi ha aiutato ad accettare quella tragedia, quando Carlo Großrubatscher precipitò nei pressi della tenda per motivi inspiegabili, perdendo la vita, e poco dopo il mio miglior amico, Friedl Mutschlechner, fu colpito da un fulmine mentre era accanto a me. Col senno di poi, forse fu uno sbaglio non esserci ritirati prima. Per quanto sia triste ammetterlo, purtroppo gli errori fanno parte delle esperienze alpinistiche.
Eppure gli errori più gravi non li ho commessi in montagna, bensì a valle. Nel novembre del 2013 provocai un incidente automobilistico nel quale un giovane perse la vita. Le analisi dimostrarono che il mio tasso alcolico nel sangue era pari a 1,48 milligrammi per litro. Una sola cosa era evidente: la responsabilità era mia. Due anni dopo l’incidente, i giornalisti Verena Duregger e Mario Vigl mi contattarono chiedendomi un’intervista: fu la prima volta in cui mi sentii di parlare dell’accaduto. Conosco Verena e Mario da molti anni, ed ero sicuro che avrebbero riportato i fatti in modo equilibrato, mentre altrettanto non posso dire della stampa altoatesina. L’atmosfera positiva che si stabilì fra noi tre perdurò a lungo e ci portò a parlare anche di altri argomenti relativi alla mia vita. Questa autobiografia in forma di intervista è il risultato di molte ore trascorse nella mia Stube.
Quando in passato ho parlato delle mie esperienze in montagna, che si trattasse di libri o di conferenze, l’interesse è sempre stato rivolto innanzitutto a date e fatti precisi: a che altezza era il campo base? Per quale giorno era prevista la salita alla vetta? Che temperatura?
Questo libro racconta la mia vita in episodi che vanno ben al di là dei numeri. Ho acquisito una certa distanza e oggi vedo molte cose con occhi diversi. Sono un sopravvissuto, nonostante tutto.
La vita di ognuno è caratterizzata da alti e bassi. I miei si manifestano tutti fra la montagna e la valle.
È arrivato il momento di parlarne.
Hans Kammerlander
gennaio 2018
Dove sono nato
Se, sulla terrazza di casa sua, Hans Kammerlander compie un giro di 360 gradi, lasciando correre lo sguardo, è come se rivedesse davanti ai suoi occhi tutta la sua vita: monti e valli. Alti e bassi. Momenti, anni, decenni. Buoni e cattivi. Infanzia, partenza, presente, futuro. Tutto ciò si riflette in questo panorama.
La terrazza di pietra e il tavolo di legno grezzo sono orientati a sud. D’estate a mezzogiorno il sole può essere così cocente che si preferisce restare dentro. Hans vive ancora ad Acereto, dove è nato, un piccolo paese sul versante meridionale della valle Aurina, a più di 1300 metri di altezza, con una vista meravigliosa verso il fondovalle, da secoli coltivato dall’uomo. L’ampia area verde non è edificabile: la comunità di Campo Tures, insieme alle frazioni di Mühlen e Kematen, si è imposta da tempo di non costruire aree abitative, sportive e industriali nel fondovalle. Una presa di posizione coraggiosa, considerando i valori immobiliari in costante crescita negli ultimi anni, ma un atteggiamento che intende preservare e proteggere il carattere originario della valle.
In assoluto, è stato un bene che la zona si sia sviluppata all’ombra dei più mondani Meraner Land e Alta Badia. La valle di Tures è così rimasta indenne da certi eccessi turistici, interiormente come esteriormente. Si vive dei turisti, ma non solo, e soprattutto si vive con loro. Molte cose nella valle rimandano a relazioni di lunga data, sia nelle comunità locali sia con i frequentatori abituali.
Torniamo alla terrazza. Se si socchiudono gli occhi, rendendo un po’ sfuocate le costruzioni moderne, si può godere di un panorama che non dovrebbe essere troppo dissimile da quello di centinaia di anni fa: l’ampio fondovalle, i pendii boscosi che salgono ripidi, le vette scoscese. L’edificio più alto e rilevante è ancora, ieri come oggi, la chiesa di Santa Maria Assunta. Citata nel 1240 per la prima volta come «parrocchia», è definita ancora così dai locali ed è molto frequentata nelle festività maggiori. Qui non è facile incontrare Hans. La Ahr, da cui il nome tedesco Ahrntal, scorre lungo la vallata come un nastro luccicante. Anche sulle sue rive non si incontra spesso Hans Kammerlander, che notoriamente non è un nuotatore. Se di sport acquatici si deve trattare, meglio la neve!
Se osserviamo il panorama con gli occhi aperti, lo sguardo arriva a Brunico, sulla sinistra sfiora il Plan de Corones e sulla destra tocca la vetta dolomitica del Sass de Putia. Il primissimo luogo della memoria per il piccolo Hans, figlio di contadini, è una delle montagne più importanti per lui. L’altezza non è così impressionante, 2875 metri, ma le sue ripide pareti nord rappresentano ancora oggi un’autentica sfida per gli arrampicatori.
La montagna di Acereto, il Moosstock, è più alta, 3059 metri, ma è priva di pareti ripide, quindi non si scala, si sale camminando o correndo. In estate, lungo i pendii, lo scolaro Hans andava su e giù trasportando il fieno in una gerla che lui stesso aveva costruito, a volte dall’alba al tramonto. Durante l’inverno quegli stessi prati venivano affrontati sugli sci di legno, in discesa. E senza skilift, quindi non c’era discesa che non fosse preceduta da una salita a scaletta. Non c’era alternativa! Più avanti, per Hans la montagna si trasforma in una specie di percorso-salute, quando la corsa in salita diventa il suo hobby. Il papà allinea con orgoglio le coppe sullo scaffale. 1630 metri di dislivello da casa alla vetta in meno di un’ora e dieci minuti, costantemente al limite delle proprie possibilità, un programma brutale. Tutto ciò costituisce, in modo inconsapevole, la base per le imprese future, e rende elevata la sua soglia di sopportazione del dolore.
Ma il giovane Hans fissa anche altri paletti. Il comprensorio sciistico di Speikboden, a due chilometri in linea d’aria, fornisce lavoro al neobrevettato maestro (1976), nonché la possibilità di trascorrere molto tempo sugli amati sci. Kammerlander è sempre rimasto fedele allo «Speik», che, rispetto al circo della neve di Plan de Corones, è minuscolo ma affascinante. Anno dopo anno ha continuato a salire con la sua giacca a vento rossa da maestro, per insegnare il carving a bambini, olandesi e pensionati sulle piste «Seenock» e «Glück». Qui è per tutti «Hans», semplicemente. Sono in pochi a sapere che il loro maestro è stato il primo uomo a scendere dall’Everest con gli sci.
Questa è forse la cosa più sorprendente in assoluto: che un ragazzo cresciuto in una povera famiglia di contadini conquisti il mondo e salga le montagne di sette continenti. E le più alte, come se non bastasse. Un ragazzo che viene da un paesino al quale negli anni Sessanta non arrivava neppure una strada, da una valle i cui abitanti, nel profondo del cuore, conoscono solo due direzioni: fuori o dentro. Dentro significa «casa». Fuori è tutto ciò che sta oltre Brunico, che sia Bolzano, Monaco o Roma. Chissà se il ragazzino Hans immaginava già i suoi numerosi viaggi, quando vedeva passare in cielo gli aeroplani, allora assai meno frequenti di oggi.
Da un’eternità la valle è collegata dalla Tauferer Straße, ben visibile dalla terrazza. Hans Kammerlander l’ha percorsa un’infinità di volte: da neopatentato, da giovane guida alpina per andare a incontrare il grande Reinhold Messner, col cuore in gola, per affrontare arrampicate nelle Alpi, e per avviarsi, carico di bagagli, alle sue spedizioni. La via di casa, la via verso le origini. È anche la strada sulla quale, nel novembre del 2013, un incidente provocò la morte di un giovane. Quando pochi giorni dopo fu diffusa la notizia che Hans Kammerlander aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 1,48 milligrammi per litro, l’indignazione degli altoatesini lo investì in pieno. Le critiche durissime, i titoli dei media locali, l’odio della rete lo scossero nel profondo. Andarsene? All’improvviso, un’eventualità possibile.
Un ultimo sguardo dalla terrazza. Il sole sta tramontando lentamente dietro la Wasserfallspitze, nella valle i colori si spengono placidamente. Le pietre ne conserveranno il tepore ancora per un bel po’. Dietro casa si sente passare un trattore. Nel cielo grigio-azzurro un aereo traccia scie di condensa.
La gioventù
Hans, sei nato il 6 dicembre 1956, sesto figlio del ciabattino Anton Kammerlander, ad Acereto. Sei stato un figlio desiderato?
Come sesto figlio non ero certamente programmato, sono stato un figlio tardivo, un fuori programma, un incidente di percorso.
I tuoi fratelli sono molto più anziani di te?
Decisamente. La mia sorella maggiore, Ida, ha diciassette anni più di me, ha superato i settantacinque. Le altre sorelle, Berta e Sabine, sono oltre la settantina. Poi ci sono i due fratelli, Alois e Josef, e poi vengo io. Il vantaggio è che tutti si sono occupati di me. Perlomeno finché sono stati in casa. I miei fratelli se ne sono andati relativamente presto, la nostra cascina era troppo piccola perché tutti potessero lavorarci, era povera. Nei dintorni, i contadini avevano più bestiame di noi, fra i dieci e i venticinque capi. Noi avevamo tre o quattro animali in tutto. Perciò i più grandi, quando hanno compiuto quindici o sedici anni, sono usciti di casa e hanno cercato fortuna altrove. Questo è avvenuto – la cosa mi sorprende ancora oggi – piuttosto lontano da casa, per gli standard di allora.
Cioè?
Si sono mossi tutti in direzione del capoluogo, Bolzano. Oggi è un breve trasferimento, ma negli anni Sessanta arrivarci dalle nostre valli era un bel viaggio: cento chilometri in autobus, con fermate e tempi di attesa, molto più di oggi. Ci voleva quasi una giornata intera. Tutto è cominciato quando Ida è andata a Bolzano per lavorare a casa di un frutticoltore. Uno dopo l’altro ha trascinato gli altri fratelli. Il maggiore, Alois, d’estate lavorava come contadino, per la raccolta della frutta. Dopo qualche anno sono rimasti tutti lì fissi, di lavoro ce n’era sempre. Il frutticoltore aveva un fratello, ma non era sposato e aveva bisogno d’aiuto.
Quali sono i tuoi primi ricordi?
Quando ero piccolo trovavo monotona la vita della cascina. Eravamo autarchici, i miei giocattoli erano costituiti da qualche pigna, rametti, pezzi di legno, con i quali costruivamo case nel bosco. Non c’era la luce, non avevamo l’energia elettrica. La sera i miei genitori accendevano qualche candela o la lampada a petrolio. Noi bambini in genere andavamo a letto dopo il tramonto e ci alzavamo all’alba. Avevamo una cucina economica, l’acqua corrente era all’esterno. Distrazioni, poche. La cosa più divertente per me era quando i miei fratelli arrivavano da Bolzano in visita. Erano momenti speciali, persino meglio di Natale. Inoltre ci portavano sempre qualcosa, noi non ci muovevamo mai. Non c’era ancora la strada per Acereto. Per raggiungere la nostra fattoria si doveva camminare e superare un dislivello di 700 metri.
Ogni quanto tempo venivano i fratelli in visita?
Più o meno una volta al mese. Al faticoso viaggio in autobus si aggiungeva la salita da Campo Tures ad Acereto, come già detto, 700 metri di dislivello. Si fermavano uno o due giorni, per poi tornare al lavoro. Per me l’addio era sempre molto triste, perché significava il ritorno alla quotidianità, che era sempre molto umana e familiare, ma anche monotona.
Cosa ti portavano i tuoi fratelli?
Un gioco semplice, ad esempio una palla, qualche volta una camicia o un paio di pantaloni, comprati in un vero negozio. All’epoca era normale che indossassi i vestiti smessi dalla mamma o dalla più giovane delle mie sorelle. Oppure capitava che un paio di volte all’anno comprassimo da un ambulante della valle del Fèrsina un pezzo di stoffa e dei bottoni, con i quali la mamma ci confezionava qualcosa.
Che tipo di vestiti avevi all’epoca?
Un vestito da lavoro e uno per i giorni di festa, e basta. Un paio di pantaloni, una giacca e un pullover, d’inverno di loden caldo. Quando i pantaloni diventavano corti, la mamma ci attaccava un pezzo di stoffa. Quando venivano in visita i fratelli portavano sempre qualcosa che avevano acquistato in città. Eravamo contentissimi, e per noi questi regali erano sacri. A quel punto andavamo anche volentieri a messa, per poter indossare il capo nuovo.
Tuo padre faceva il calzolaio.
Per il suo lavoro vagava da una fattoria all’altra e sistemava tutto quello che era di cuoio. Scarpe, ovviamente, le faceva nuove per i contadini, ai braccianti invece più che altro le riparava. Realizzava anche le briglie, i finimenti per i cavalli. Per lui era indispensabile guadagnare così i suoi soldi, perché la fattoria era troppo piccola. Per questo motivo fin da bambini ci abituammo ad aiutare in casa, perché lui spesso non c’era. Inoltre la guerra lo aveva provato duramente. Da quando era tornato dal fronte aveva cominciato a soffrire di asma, ma non si perse mai d’animo e si dava parecchio da fare. Da lui abbiamo appreso, fin da bambini, tutti i lavori manuali. Ci ha insegnato a intagliare il legno, a costruire cesti e slitte. Era anche maestro ciabattino e formava altri artigiani. All’epoca funzionava così, uno restava un anno o due a lavorare da un artigiano e poi otteneva il diploma. Secondo me gli artigiani di allora erano dei veri artisti: era fantastico come riuscivano a realizzare il lavoro con le loro mani. Per noi bambini è stato un vero arricchimento. La mia gioventù è stata povera, ma anche bella.
Qual è stato il ruolo di tua mamma Maria?
Era una tipica contadina e mandava avanti la casa, oltre a lavorare nei campi e nella stalla. Allora le donne lavoravano dall’alba fino a notte. Quando noi e il papà eravamo già a letto da un po’, lei era ancora seduta all’arcolaio oppure lavorava a maglia. Non faceva altro che lavorare. Ma non ho molti ricordi di lei, è morta presto.
Quando è successo?
Avevo dieci anni. Per noi significò un cambiamento radicale, ma io ero ancora troppo piccolo per soffrirne in modo consapevole. Aveva solo cinquantadue anni quando si ammalò. Spesso la vedevo a letto, ma non riuscivo a darmene una spiegazione. Però ricordo il momento in cui se ne andò. La sistemarono su una slitta, come un carico di legna, e la portarono a Campo Tures. Morì in ospedale dieci giorni dopo.
Ricordi le sue ultime parole?
«Pfiat enk», «Arrivederci», ci disse salutando con la mano. Alla fine era debolissima. Non abbiamo mai saputo di cosa soffrisse. Penso si trattasse di cancro. Venne ipotizzato un intervento, ma i medici non arrivarono in tempo.
Non ci fu una diagnosi ufficiale?
Se ci fu, il papà non ne parlò con noi. I medici la portarono in sala operatoria, ma poi la richiusero. Probabilmente sarebbe stato tutto inutile. Del resto non si era mai rivolta a un dottore, purtroppo.
E per voi come sono andate poi le cose?
Mia sorella Sabine è subito intervenuta, si è accollata l’andamento della casa, preparando da mangiare per tutti. Provava compassione per me, credo. Mi trattava molto bene, voleva consolarmi. Perciò posso dire di avere avuto da lei più attenzioni che non dalla mamma, che era sempre molto severa. E questo mi ha aiutato a superare la perdita.
Per quanto tempo tua sorella ha svolto il ruolo di madre?
In fondo, potremmo dire fino a oggi. Sabine vive ancora alla fattoria, con mio fratello Josef. Che ha ristrutturato la cascina e se ne occupa pur essendo già in pensione. Esternamente ha mantenuto l’aspetto di sempre, ma all’interno è stata interamente rimodernata. Adesso è una piccola fattoria molto curata, con qualche animale. Mio fratello vince un premio dopo l’altro per le sue vacche pezzate. Ancora oggi Sabine viene a trovarmi regolarmente, cura il mio giardino o mi porta qualcosa di buono da mangiare. A volte ho la sensazione che mi tratti ancora come se fossi suo figlio. Si immischia, ma lo fa sempre con le migliori intenzioni.
Non ha una famiglia?
Non si è mai sposata e ha sempre vissuto sola. Dovendosi occupare dei fratelli, ha sacrificato una parte della sua vita personale.
Andavi volentieri a scuola?
Per niente. Per noi figli di contadini la scuola era un fastidio. Stavamo pigiati in una sola classe, a seconda del numero di iscritti all’inizio dell’anno scolastico. Vivevo la scuola solo ed esclusivamente come un puro dovere. Non mi interessava quello che ci veniva insegnato, del resto a casa nessuno se ne faceva un cruccio.
Da come parli, sembra quasi che tu potessi fare quel che volevi.
No, non è vero, semplicemente mio padre dava la priorità ad altre cose. Di sera dovevamo aiutare nella stalla; la mattina presto dovevamo andare in chiesa, ci teneva. Mio padre era sempre carino con noi, ma restava comunque severo, ed era anche molto religioso. In paese c’era la messa tutti i giorni, e io ci dovevo andare. Estate e inverno. Durava una mezz’oretta. Il prete la diceva in latino, noi non capivamo niente. Non mi piaceva affatto. Soprattutto d’inverno, perché la chiesa non era riscaldata e si gelava. Dopo la messa si andava a scuola, nell’edificio accanto. La maestra accendeva la stufa di ghisa e ci metteva la legna. Il tepore era piacevole, ma faceva venire sonno. O forse dipendeva dalle lezioni.
Cosa prevedeva il programma?
Era un insegnamento essenziale. Trovavo particolarmente fastidiosi italiano e religione. Mi parevano ore del tutto superflue e prive di senso. Nei primi anni, l’insegnante di religione era un sacerdote piuttosto anziano che indossava sempre un cappotto macchiato. Una volta mi mollò uno scapaccione così forte che credetti di svenire. Il prete teneva sempre in mano una biro di metallo. Quando era dietro di noi e si accorgeva di un errore sul quaderno, ci colpiva sulla nuca con violenza con la penna. E non serviva a nulla incassarsi nelle spalle. Era molto manesco.
È a causa di quel prete che la chiesa non ti ha mai particolarmente entusiasmato?
Fin da bambino mi sono reso conto che molte cose non quadravano. Il prete ti ammonisce, non devi mai fare del male ad animale o a essere umano, poi un attimo dopo ti molla uno scappellotto che ti fa vedere le stelle. E senza distinzione fra maschi e femmine. La sera, a casa, ci toccava il rosario, dai venti ai trenta minuti. Una costrizione pura.
Ma nessuno l’ha mai fermato, quel sacerdote?
Le punizioni terminarono quando morì. All’epoca ero in terza. Venne un altro parroco, più benevolo. E subito le lezioni divennero più interessanti. Finalmente capimmo quello che l’altro avrebbe dovuto insegnarci. Cantavamo molto, a scuola e in chiesa. Persino la messa all’improvviso diventò meno noiosa. All’intervallo il prete giocava con noi, a palla prigioniera o a calcio. Ci piaceva davvero molto, quel prete.
Come si svolgeva una giornata tipo?
Di solito a colazione mangiavamo una Brennsuppe, una minestra di farina abbrustolita, o una crema fatta di acqua e sale. La ciotola stava al centro del tavolo, e tutti ne prendevano con il cucchiaio. Ognuno aveva anche un pezzo di pane. Dopo colazione ognuno puliva il suo cucchiaio con la tovaglia e lo infilava in una custodia di cuoio, fino al giorno dopo. Tutti avevano il proprio cucchiaio personale. Le forchette non c’erano. Di pomeriggio in genere stavo con i miei fratelli oppure andavo dai miei genitori, che però erano impegnati. Programmi non ce n’erano. Nessuno badava a noi bambini, i nostri genitori non avevano il tempo di farlo. Stavamo nei prati oppure nell’officina di papà.
Durante l’inverno non c’era il lavoro dei campi. Come riempivi i tuoi pomeriggi?
Andavamo in slitta e a sciare. Gli inverni erano sempre molto belli. A cinque anni mi piaceva scivolare giù lungo il prato accanto alla fattoria. Nulla a che vedere con lo sci moderno. Usavamo dei pezzi di legno, sistemati alla bell’e meglio da noi. Non avevamo scarponi, o giacche a vento. Indossavamo le stesse cose che usavamo per i lavori nella stalla. Ma eravamo felici di pestare una pista con gli sci e poi scendere. Era più simile a una pista di bob che non di sci.
Ovviamente non c’erano skilift o seggiovie.
Ad Acereto no di certo, a cosa sarebbero serviti? Non era un posto da turisti. Solo molti anni dopo ho preso il mio primo impianto di risalita. Per noi una discesa di un minuto significava una risalita di dieci. Oggi non lo farebbe più nessuno. In basso mi fermavo sempre a una certa curva oppure volavo. Il nostro campo era adatto allo sci, era piuttosto ripido e uniforme. Dovevo sempre fare attenzione a una curva a destra, a sinistra c’erano gli alberi, e nel tempo questa cosa mi è rimasta. Ho sempre fatto meglio le curve a destra, a una velocità maggiore. A sinistra andavo peggio, mi mancava l’allenamento.
Chi ti ha insegnato a sciare veramente?
In effetti nessuno. Ho solo osservato gli altri.
E quando hai scoperto che ti piaceva l’alpinismo?
Non è stato un passo programmato, è successo e basta. Avevo otto anni e come tutti i giorni stavo andando a scuola. Incontrai due turisti tedeschi, marito e moglie, che mi chiesero come si faceva a raggiungere il Moosstock. Fra me e me pensai: Ma questi cosa pensano di fare sul Moosstock? I due poi hanno proseguito, ma al primo incrocio hanno preso la direzione sbagliata. Allora li ho seguiti.
L’autore
Hans Kammerlander, nato nel 1956 ad Acereto in Alto Adige, alpinista estremo, guida alpina e istruttore di sci, ha realizzato una cinquantina di prime e una sessantina di solitarie nelle Dolomiti e nelle Alpi, e ha salito dodici Ottomila. Ha scritto numerosi libri fra cui, oltre ad Alti e bassi della mia vita, Malato di montagna, Sopra e sotto, Appeso a un filo di seta e In lungo e in largo, pubblicati con successo da Corbaccio, e tiene conferenze nelle quali racconta le sue spedizioni.