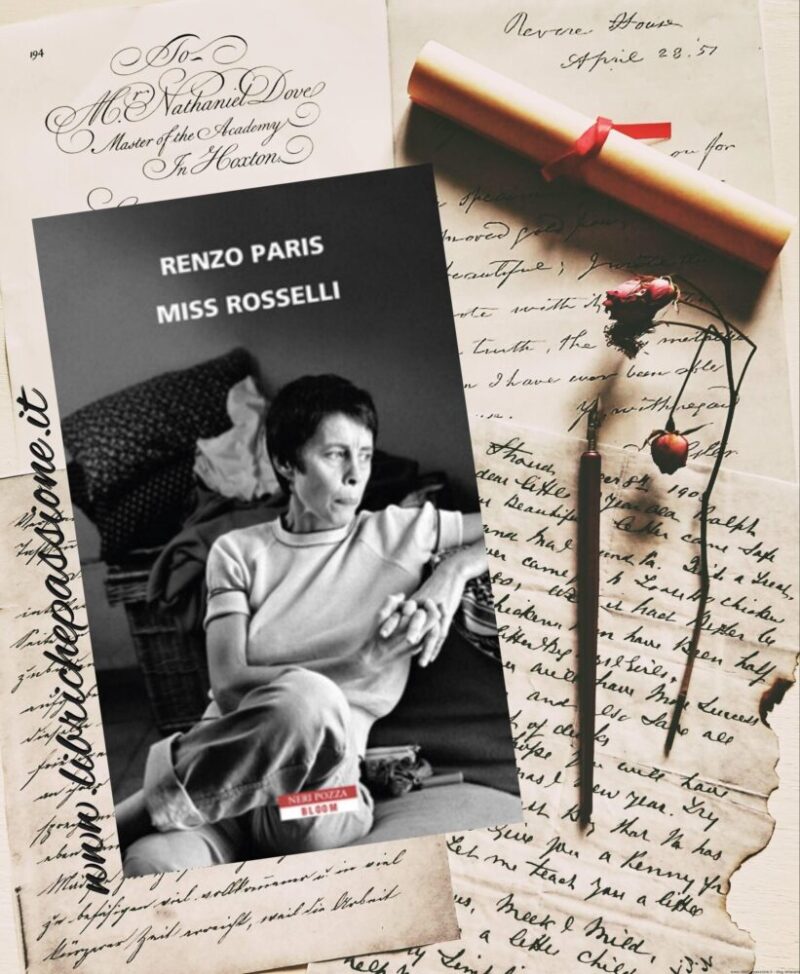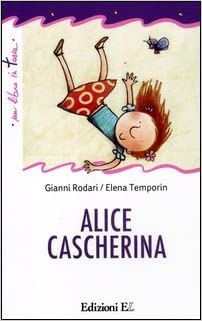Trama
Quando aveva poche ore di vita, Crow fu ritrovata in una vecchia barca che nella notte si era arenata sulla spiaggia: questa è la storia che le racconta Osh, il pittore, come una favola della buona notte. Per dodici anni Crow ha vissuto con lui su un’isoletta circondata dal mare e dal cielo, come sotto un incantesimo selvaggio e felice, accudita dal ruvido affetto della signorina Maggie. Ma le mani di Osh e della signorina Maggie sono le uniche che l’abbiano mai toccata: sembra che gli altri abitanti stiano alla larga da lei, come se ne avessero paura. Perché? Cosa si nasconde dietro le sue origini? Una notte in cui vede divampare un misterioso fuoco nell’isola di fronte, Crow decide di scoprirlo, cominciando una ricerca che la porterà su sentieri assai più pericolosi del previsto, che sfideranno la sua identità e il suo senso di appartenenza, ma che le riveleranno cos’è davvero una famiglia. Età di lettura: da 12 anni.
Estratto del libro
A mio padre, che mi portò in mare per la prima volta.
Isole Elizabeth,
al largo di Woods Hole, Massachusetts.
1925
Prologo
Mi chiamo Crow.
Quando ero appena nata, qualcuno mi mise su una vecchia barca e mi spinse in mare aperto.
La corrente mi depositò su un’isoletta, come un seme portato dalla marea.
Fu Osh a trovarmi e a prendermi con sé. Fu lui a insegnarmi a mettere radici e a crescere vigorosa con la pioggia o con il sole; a farmi capire cosa voglia dire sbocciare.
L’isola su cui le nostre strade si incrociarono era piccola ma solida, ancorata a un ammasso di roccia nera che dava rifugio alla nostra casetta, una costruzione sgangherata, tirata su con pezzi di navi naufragate, annidata in un letto di terra e residui marini, con accanto un orticello e la piccola barca a vela che ci portava dove non potevamo arrivare con i piedi.
Non avevamo bisogno d’altro. Non all’inizio, almeno.
Con la bassa marea potevamo andare facilmente a piedi all’isola vicina, Cuttyhunk, attraversando bassifondi disseminati di alghe filamentose e di pesciolini.
Con l’alta marea, la casetta era così vicina al mare da sembrare quasi una barca essa stessa.
Per molto tempo sono stata davvero felice quando l’acqua saliva, separandoci dal resto del mondo, e noi due soli decidevamo tutto quello che c’era da decidere.
Poi una notte, a dodici anni, vidi un fuoco acceso su Penikese, l’isola su cui nessuno andava mai, e decisi tra me e me che era ora di scoprire da dove venivo e perché mi avevano mandato via.
Ma non sapevo cosa stessi rischiando e non lo capii finché per un pelo non lo persi.
Capitolo 1
Non saprò mai con certezza quando sono nata. Non il giorno preciso.
La mattina che Osh mi trovò avevo solo poche ore, ma lui non aveva un calendario e non gli importava molto sapere che giorno fosse, così abbiamo sempre associato la mia nascita a qualsiasi giorno di piena estate ci sembrasse buono.
Lo stesso valeva per tutti gli altri eventi cruciali della mia vita: momenti che non avevano alcun legame con il calendario.
Come il giorno in cui Mouse comparve sulla nostra porta, e decidemmo che quella era anche casa sua. Come era capitato a me.
O la prima volta che Osh mi lasciò tenere il timone della nostra barca mentre lui, seduto a prua, si crogiolava il viso al sole per un po’ con la schiena appoggiata all’albero e gli spruzzi fini che gli tessevano arcobaleni intorno. O quando, con la bassa marea, un delfino si spiaggiò sulla nostra isola mentre Osh era via. Di ritorno da Cuttyhunk, lo trovai che si dimenava spaventato, piangendo come un bambino. Scavai con le mani nude la sabbia bagnata che lo bloccava e poi l’afferrai per la coda a mezzaluna trascinandolo un centimetro dopo l’altro finché l’acqua non lo sollevò quanto bastava, ed entrambi scivolammo di colpo in mare.
Prima di andarsene, il delfino mi passò accanto guardandomi negli occhi come per imprimersi nella memoria quella che ero in quel momento. Come per dirmi che anch’io avrei dovuto ricordarmelo, qualunque cosa fosse successa dopo.
Nessuno di questi eventi era abbinato a una data.
So però di aver vissuto otto anni su quell’isoletta prima di cominciare a provare qualcosa di più di una semplice curiosità sul mio nome. Il sogno che mi spinse a pormi nuovi interrogativi era pieno di stelle, di spruzzi di balene e di suoni del mare. Quando aprii gli occhi, rimasi distesa per un minuto buono a guardare Osh davanti alla stufa che preparava il porridge in una pentola incrostata.
Poi tirai su la schiena e mi fregai gli occhi per svegliarmi del tutto. «Perché mi chiamo Crow?» gli chiesi.
Quando Osh rimestava il porridge, il cucchiaio faceva un rumore simile a quello di una barca che veniva trascinata sulla spiaggia. «Te l’ho detto» mi fece. «Quando la corrente ti ha depositato qui, a forza di piangere eri diventata rauca e gracchiavi come un corvo. Per questo ti ho chiamato Crow».
Fino ad allora quella risposta mi era sempre bastata. Non spiegava tutto, però. E io cominciavo a volere tutto.
«In inglese?» gli chiesi.
Osh a volte parlava in una lingua che non conoscevo, e in quei momenti la sua voce pareva musica, specie quando pregava, ma anche quando dipingeva i suoi quadri raffiguranti le isole e il mare. La prima volta che gli chiesi di quella lingua, Osh mi disse che era una delle poche cose che aveva mantenuto della sua vita prima dell’isola. Prima di me.
Anche se non la parlava spesso, l’altra lingua coloriva il suo inglese, che era diverso rispetto a quello di tutti gli altri. La signorina Maggie lo chiamava ‘il suo accento’. Ma forse, pensavo, erano tutti gli
altri ad avere un accento.
«No, non in inglese, all’inizio» mi rispose. «Ma la gente qui parla inglese. E così è diventato Crow».
Mi alzai e mi stirai per togliermi la notte dalle ossa. Nella fioca luce del mattino, le mie braccia parevano sottili come ali.
Ma quando salii sullo sgabello davanti allo specchio – così piccolo da riflettere solo la faccia – vidi la somiglianza nella curva del naso. La voglia a forma di piccola piuma sulla guancia. I capelli, più neri di quelli di tutti gli altri. Gli occhi scuri. La pelle del colore che prendeva quella di Osh dopo sei mesi sotto il sole.
Abbassai lo sguardo sulle gambe secche, sui piedi ossuti.
C’erano un sacco di motivi per chiamarmi Crow, ‘corvo’, oltre al mio pianto rauco, quella volta.
Osh invece aveva tre nomi. Daniel, come lo chiamava la signorina Maggie. Il Pittore, come lo chiamavano i forestieri che arrivavano sulle isole in estate. Osh, come lo chiamavo io da quando avevo imparato a parlare.
Il suo vero nome era complicato. Troppo difficile per una bambina piccola. ‘Osh’ era il massimo che riuscissi a dire. E da allora in poi l’avevo sempre chiamato così.
«Vorrei sapere qual è il mio vero nome» dissi.
Osh rimase in silenzio per un lungo momento. «In che senso, vero?» chiese.
«Il mio vero nome. Quello che mi hanno dato i miei genitori».
Osh tacque di nuovo per un po’, e poi disse: «Quando sei arrivata qui, eri appena nata. Non so se avevi un altro nome». Versò del porridge in una scodella. «E anche se ce l’avevi, come facciamo a sapere qual era?»
Andai a prendere due cucchiai. «Qual è, vorrai dire».
Osh si strinse nelle spalle, e i capelli che gli arrivavano a quell’altezza si gonfiarono come onde notturne. «Era… è… sarà…» Riempì un’altra scodella. «Poco importa, visto che adesso sei qui, e un nome ce l’hai».
Il plop del porridge che cadeva nella terracotta e il toc del cucchiaio di legno che batteva sul bordo della scodella mi spinsero a chiedermi chi avesse dato un nome a quelle cose. E a tutte le altre cose del mondo. Me compresa.
Sentivo la curiosità farsi più intensa, come se ce l’avessi nelle ossa e crescesse insieme al mio corpo.
Ma più di quello – più della semplice curiosità – ero tormentata dal bisogno di sapere ciò che non sapevo.
Volevo sapere perché in alcune delle ostriche di Cuttyhunk c’era una perla e in altre no. Volevo sapere in che modo la luna trascinasse l’oceano su e giù da quella distanza, se non era in grado di mescolare il latte nel tè della signorina Maggie. Ma avevo bisogno di sapere, fra le altre cose, perché così tanti abitanti di Cuttyhunk mi stavano alla larga come se avessero paura di me, sebbene fossi più piccola di tutti loro.
Mi chiedevo se avesse qualcosa a che fare con il posto da cui ero arrivata, ma non aveva senso. Da dove venivo? E con cosa poteva avere a che fare? O con chi?
Qualcosa, sì. Ma non tutto.
E io avevo bisogno di sapere tutt’e tre le cose: dove, cosa e chi.
Osh invece no. Quando gli chiedevo delle perle o delle maree, si sforzava di rispondere alle mie domande. Ma quando gettavo lo sguardo oltre la nostra vita sulle isole, ecco che si trasformava nella luna, deciso a trascinarmi indietro, come se fossi fatta di mare anziché di sangue.
«Ho fatto un lungo viaggio per arrivare qui» disse un giorno quando gli domandai della sua vita prima di quella che ora condividevamo. «Il più lontano possibile da un posto in cui tutti – i miei stessi fratelli – si gettavano a capofitto in combattimenti così terribili che nessuno riusciva più a capire niente in quella bolgia. E per cosa? Per quale motivo?» Scosse la testa. «Niente per cui valesse la pena di combattere. Così mi rifiutai di essere uno di loro, ed eccomi qui. E qui resterò».
Mentre aspettavo che Osh portasse in tavola il porridge,cercai di pensare a un altro nome che andasse bene per me, ma non mi veniva in mente niente di meglio di Crow, quello che già avevo.
E mi piaceva l’idea di aver preso il nome da uno degli uccelli più intelligenti che ci fossero, più intelligente perfino di certe persone. Così diverso dai gabbiani e dai falchi pescatori che volteggiavano sopra le isole gettandosi in picchiata, al punto che sentivo una certa affinità con i grandi uccelli neri che arrivavano dal continente, trasportati dalle correnti, e venivano sballottati dal vento come aquiloni volati via, fino a posarsi rumorosamente sul carpino della signorina Maggie. Parevano fuori luogo,sulle isole, e a volte avevo la sensazione di esserlo anch’io. Ma eravamo ugualmente isolani, qualsiasi cosa uno potesse pensare.
Certe volte Osh mi chiamava con il nome di altri animali. Volpacchiotta. Gattina. Mulo, quando mi impuntavo. Scricciolo, quando ero brava.
Ogni tanto mi chiamava anche mooncusser,1 perché di notte mi piaceva perlustrare la spiaggia per vedere cosa avesse portato la marea, ma non inducevo le navi a fare naufragio al largo di Cuttyhunk, né ero una ladra timorosa di essere illuminata dalla luna mentre cercava tesori nascosti. Non l’avevo mai maledetta, la luna.
Ma per la maggior parte del tempo non avevamo bisogno di chiamarci per nome. Se eravamo lontani, eravamo molto lontani e non avremmo sentito. Se eravamo insieme parlavamo nel modo in cui si parla quando non c’è nessun altro intorno. I nomi non erano molto importanti.
Capitolo 2
Osh aveva costruito la nostra casetta con qualunque cosa fosse riuscito a strappare dai relitti che lentamente sprofondavano nel fondo marino, si sfasciavano durante le tempeste o scomparivano in altro modo, a poco a poco.
Il resto della casa era composto da rottami galleggianti trascinati a riva dalla marea – come era successo a me – nella nostra piccola baia oppure a Cuttyhunk, dove nessuno li voleva.
La struttura portante l’aveva costruita con lunghe travi; il tetto e le pareti con i rivestimenti dei ponti delle navi; il camino con il tubo di sfiato di un piroscafo naufragato; una finestra con un oblò. La porta era un pezzo di chiglia. Il focolare lo sportello di un boccaporto. Il tavolo una coffa capovolta.
Osh aveva recuperato anche molte cose che non avevano alcuna utilità pratica se non quella di esserci care. Le più pregiate, due polene – solenni figure di donne dai lunghi capelli fluenti – ci fissavano dai due lati del focolare senza mai battere le ciglia. Sopra alla porta si inarcavano un paio di costole di balena sbiancate dal sole, dalla cui sommità pendeva la campana ossidata di una nave.
E frugando tra i detriti sulla battigia avevo trovato anch’io la mia quota di gingilli. Pezzi di vetro levigati dal mare tra i borsellini delle sirene (sacche di uova vuote di alcune specie di grossi pesci) e i gusci delle patelle. Un fermaglio per banconote d’ottone tutto incrostato di verde con un elefante impresso. Un orologio a muro a forma di banjo che non avrebbe mai più scandito il tempo, ma provvisto di un piccolo armadietto in cui tenevo le altre carabattole che avevo scovato. Un’altra cosa che avevo in comune coi corvi: anch’io sapevo apprezzare i tesori più poveri.
Quando gli chiesi dove fosse finita la barca che mi aveva depositato a riva, Osh mi disse che ne aveva ricavato legna da ardere per tenermi al caldo durante il mio primo inverno. Per molto tempo, prima di saperne di più, mi chiesi come mai – di tutto il legno che aveva recuperato – proprio quello fosse finito nel fuoco anziché nella nostra casa.
Coi soldi che guadagnava pescando astici, estraendo blocchi di ghiaccio dal Wash Pond e vendendo i suoi dipinti ai forestieri in estate, Osh aveva comprato chiodi, un martello e tutte le altre cose che gli mancavano. Andava a prelevare argilla sul lato di Cuttyhunk che dava sullo stretto e la portava fino alla nostra baia con la barca, dopodiché la mescolava con cenere e sale e con quel composto sigillava la casa per proteggerla dalle correnti e dagli acquazzoni. Faceva tutto il possibile per renderla solida e confortevole.
Quando fui grande abbastanza, presi ad aiutarlo nella manutenzione.
Ma anche mentre lavoravamo insieme a questa casa che avevamo fatto con le nostre mani, non riuscivo a smettere di pensare a chi aveva fatto me. A chi mi aveva guardato quand’ero tenera e fresca come un fiore appena sbocciato e aveva deciso di affidarmi alla marea. E al motivo che l’aveva spinto a farlo.
Mi portavo dietro queste domande come un fardello che col passare degli anni diventava sempre più pesante, anche se ormai mi ero abituata all’idea. Anche se non ero infelice della vita che facevo.
Volevo solo sapere. Capire. Sgravarmi di quel fardello.
Alcune cose le sapevo bene.
Osh mi aveva raccontato molte volte – così tante che era diventata una favola della buonanotte – di quando mi aveva trovato in una vecchia barca che nella notte si era arenata sulla spiaggia. Se non mi avesse trovato quella mattina, la marea in arrivo mi avrebbe risucchiato, portandomi da qualche altra parte. Ma aveva voglia di mangiare pesce a colazione ed era andato in cerca di uno o due persici spigola.
La barca era a malapena in grado di galleggiare, ma era riuscita a raggiungere l’isola nonostante le violente correnti che facevano naufragare imbarcazioni molto più grandi.
Non so cosa pensasse di trovarci dentro, Osh, quando vi si avvicinò: di certo non una neonata legata al sedile con strisce di biancheria sporca appena pochi centimetri sopra il livello dell’acqua che aveva allagato lo scafo.
Quella volta, mi raccontava Osh, avevo smesso di colpo di gracchiare ed ero rimasta in silenzio come un topo quando scorge l’ombra di un falco sul terreno: lo guardavo con gli occhi sbarrati, e lui fissava me, sbalordito.
Pur vivendo in solitudine in un luogo difficile anche per un uomo adulto, mi portò in casa prima di decidere che cosa fare di me. E lì rimasi.
Mi raccontava spesso quanto era stata dura, per lui, nei giorni successivi al mio arrivo. Aveva barattato astici con latte al negozio di Cuttyhunk, l’aveva versato in una bottiglietta e fabbricato una tettarella di fortuna con il collo di un mollusco, fatto per schizzare fuori l’acqua marina. E da lì succhiavo latte salato, come se venisse direttamente dal mare. Osh mi fasciava in tela da vele
ammorbidita dal vento e mi lavava in una conca liscia nella roccia in cui si raccoglieva l’acqua piovana. Di notte mi portava nel suo letto, dove dormivo stretta a lui.
Quando la signorina Maggie e gli altri si accorsero della mia presenza, Osh aveva già deciso che ero sua, prima che qualcuno potesse fare obiezioni.
La signorina Maggie per un po’ ci provò. Non per portarmi via, diceva, ma solo per essere certa che nessuno mi stesse cercando. Forse, diceva, non era stata mia madre a mettermi su quella barca. Forse, diceva, mia madre girava le coste della Baia di Buzzards con il seno gonfio di latte.
Così la signorina Maggie aveva insistito perché il direttore dell’ufficio postale inviasse telegrammi a tutti i porti tra Narragansett e Chilmark, chiedendo se qualcuno stesse cercando una neonata come me.
E scriveva pure lettere che inviava nei posti troppo piccoli per avere un telegrafo.
Da alcuni di questi non ricevette risposta: da Onset, da Mattapoisett, e neppure da Penikese, benché fosse il più vicino.
E nessuno di quelli che risposero aveva notizia di una neonata scomparsa.
Ma non aveva importanza, in realtà.
Quando le risposte giunsero nelle mani della signorina Maggie, ormai ero diventata di Osh. E lui era diventato mio.
Era un mistero che la barca si fosse arenata sulla nostra isoletta e non su Cuttyhunk, dove si depositava la maggior parte dei tesori e dei rottami galleggianti. Ma ero felice che fosse andata così.
Non riuscivo a immaginare che uno degli altri isolani si sarebbe preso cura di me, se la corrente mi avesse portato sul suo pezzo di terra. Molto più probabilmente, pensavo, mi avrebbero spedito sul continente, in un posto senza tanto mare e cielo. E sarebbe stato un peccato. Io e Osh eravamo circondati da un mondo selvaggio. E io preferivo così.
Tuttavia c’erano alcune persone di Cuttyhunk che mi piacevano abbastanza. E che sembravano aver simpatia per me, a modo loro. Però non mi toccavano. Non mi venivano mai vicino. Sembravano volermi tenere a una certa distanza. Era stato così fin dall’inizio – li avevo sempre conosciuti così – per cui non mi facevo tante domande finché non divenni più grande e cominciai ad affrontare le questioni in sospeso della mia vita.
Quando le presi di petto e tutto cominciò a districarsi, uno spiraglio si aprì lasciando entrare un po’ di luce che mi aiutò a vedere la mia vita con maggiore chiarezza, facendomi però venire voglia anche di chiudere gli occhi, alle volte.
La signorina Maggie era l’unica a Cuttyhunk che non sembrava aver paura di me.
Da piccola ero spesso malata, e quando divenni più grandicella, mi ammalavo ancor più di frequente. La signorina Maggie era l’unica a venire sulla nostra isola a portarci pane, minestra e uno dei suoi decotti preparati con rosa canina e foglie d’ortica. Le sue erano le uniche mani che mi avessero mai toccato, non contando quelle di Osh o quelle che erano venute prima delle sue, anche se io le contavo sempre.
Malgrado tutto il duro lavoro che facevano, le mani della signorina Maggie erano lisce come l’interno di un guscio d’ostrica. Quando le chiesi come fosse possibile, lei aggrottò la fronte e mi disse che erano morbide per via della lanolina contenuta nella lana che tosava alle pecore del suo gregge – o strappava a quelle che morivano – e poi filava. «Ma questo non vuol dire che non siano forti» disse, come se l’avessi messo in dubbio.
Quando me le appoggiava sulla fronte calda, pensavo al limonio e al mese di aprile. Ma la signorina Maggie non sorrideva quasi mai, e quando mi parlava, nella sua voce mi sembrava di cogliere l’eco di un tuono, come un lieve rimprovero, qualunque cosa avessi o non avessi fatto.
«Mangerai questa minestra fino all’ultima cucchiaiata» borbottava. «Mi hai sentito?»
E io la mangiavo fino all’ultima cucchiaiata: nessun altro a Cuttyhunk faceva una minestra più buona di quella della signorina Maggie, con le verdure dell’orto più rigoglioso delle isole. Faceva germogliare i semi in letto caldo non appena il sole era più forte della neve e poi, alla fine del disgelo, trapiantava le piantine in un vasto orto, ricco di letame e di residui marini: patate, sedano, fagioli, cavoli, rafano, taccole, orzo, meloni, cipolle, pomodori e rape.
Se con me era brusca, alle sue mucche parlava teneramente. E anche se mangiavano la stessa avena di tutte le altre mucche di Cuttyhunk, le sue facevano il miglior latte dell’isola, e anche il suo burro era il più buono. E le sue galline, nutrite con orzo e calendula, erano così felici che deponevano uova a tutto spiano sfornando più pulcini di tutte le altre galline delle Isole Elizabeth. Con la farina e l’olio che riceveva in cambio delle uova, la signorina Maggie faceva un pane che mi faceva felice più di un dolce, benché mangiassi dolci solo in rare occasioni. Ero quasi contenta di essere malata, se ciò mi dava la possibilità di assaporare il suo pane e la sua minestra.
«La signorina Maggie fa davvero una buona minestra» diceva sempre Osh prima che arrivasse e dopo che se n’era andata. «Ma è solo una delle sue tante qualità».
Un’altra era il coraggio.
«Non ha paura di ammalarsi anche lei?» le chiedevo quando ero a letto col mal di testa.
«Sono già stata malata in passato» mi rispondeva. «E mi ammalerò ancora in futuro, con o senza il tuo aiuto».
Era una cosa che mi piaceva della signorina Maggie: lei faceva sembrare tutto facile.
 Foto presa dal web
Foto presa dal web
Lauren Wolk è scrittrice, poetessa, artista. Se le chiedono quando è diventata scrittrice risponde: il 28 ottobre 1959, la sua data di nascita. Di questo romanzo dice: «Scriverlo mi ha ricordato che la felicità è vivere dove vogliamo vivere – ed essere chi vogliamo essere». Vive con la famiglia a Cape Cod. Con Salani ha pubblicato L’anno in cui imparai a raccontare storie, bestseller pluripremiato dalla critica internazionale e vincitore del premio LiBer come miglior libro dell’anno.
Al di là del mare è il vincitore dello Scott O’Dell Award for Historical Fiction ed è stato premiato come libro dell’anno per: NPR, Booklist, BookPage, HornBook, Kirkus Reviews, School Library Journal e dalla New York Public Library.