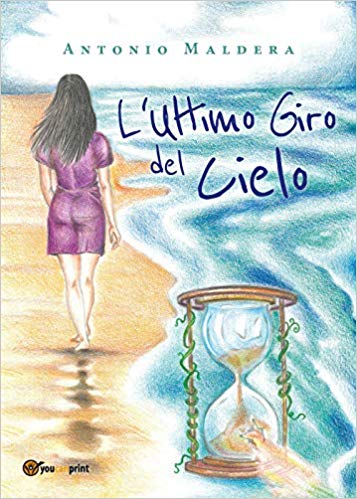1936. È un anno speciale per Pablo Picasso.
In fuga dai troppi amori e dalla troppa intensità di Parigi, cerca rifugio in Costa Azzurra, a Juan-Les-Pins, dove il cielo è incredibilmente blu e il mare pieno di sfumature smeraldo. Qui si stabilisce per un po’, in incognito, riprendendo finalmente a dipingere dopo una lunga pausa. E proprio in questo periodo, per la prima volta, una ragazza con i capelli neri fa capolino nei suoi quadri. Nessuno ha mai saputo chi fosse. Come nessuno ha mai indovinato cosa successe davvero a Picasso in quella breve e misteriosa parentesi della sua vita…
Ondine, folti capelli neri e la freschezza dei suoi diciassette anni, lavora nel Café Paradis, piccolo ristorantino gestito da sua madre, e la sua vita a Juan-Les-Pins è stata scossa finora da un solo terremoto: il primo amore. Quando un misterioso sconosciuto che viene da Parigi prende in affitto una delle ville della città, è lei la prescelta per portargli il pranzo a domicilio. E così che Ondine incontrerà il grande genio dell’arte, e grazie ai quadri, come al comune amore per la cucina, tra i due nascerà una particolarissima amicizia, che cambierà Ondine per sempre. Un’amicizia i cui effetti dureranno nel tempo, tanto che, due generazioni dopo, la sua nipote Céline, make-up artist a Los Angeles, deciderà di intraprendere un viaggio proprio nei luoghi dell’incontro tra la sua nonna Ondine e Picasso, alla scoperta del passato della sua famiglia, e di se stessa.
Intrecciando in modo irresistibile realtà e fantasia, Camille Aubray ricostruisce un pezzo della vita di Picasso, e immagina una storia trascinante, romantica e misteriosa, condita di deliziosa cucina francese, arte e joie de vivre.
Questo libro è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono frutto dell’immaginazione dell’autrice e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione. Qualsiasi somiglianza con eventi o luoghi o persone, vive o scomparse, è del tutto casuale.
A mia madre
Prologo
Céline a Port Vauban Costa Azzurra 2016
Quand’ero piccola, mia madre ripeteva spesso un proverbio provenzale. Lo recitava con un tono allegro e cantilenante, come fosse una filastrocca: L’eau trouble est le gain du pêcheur sage. Mi disse che significava questo: un pescatore saggio sa trarre vantaggio dal mare agitato. Ho sempre pensato che fosse un modo per rassicurarmi, per farmi capire che l’impegno viene sempre premiato, anche nei momenti più difficili.
Ma, come per gran parte delle cose dette da mia madre, in seguito ho scoperto che quella frase aveva anche un altro significato: quando regna il caos e tutti si lasciano distrarre dalla tempesta, puoi ottenere ciò che desideri senza che nessuno se ne accorga.
Il proverbio mi è tornato in mente proprio oggi, mentre leggevo la mail di un uomo che conosco appena. Attracco a Port Vauban alle tredici, ma solo per caricare rifornimenti. Ripartirò appena finito. Quindi, se sei ancora interessata, vieni subito. Allego il pass di autorizzazione per salire a bordo.
Ormai mi ero quasi rassegnata a non avere più sue notizie, perciò è stato un sollievo ricevere quel messaggio. Poi, però, ho guardato l’ora e il sollievo si è trasformato in panico: erano quasi le dodici. In fretta e furia ho informato i colleghi francesi dello studio cinematografico di Nizza che non avrei partecipato al party di fine riprese perché dovevo occuparmi di una questione personale ad Antibes. Loro hanno subito dato per scontato che si trattasse di un incontro romantico. «L’Americaine mystérieuse», hanno commentato, scambiandosi sorrisetti maliziosi mentre correvo alla macchina.
Guidare nel traffico di mezzogiorno significa fare i conti con pullman pieni di turisti, camion e auto dei residenti, tutti in preda alla frenesia di arrivare in tempo per il dejeuner. Ma a un certo punto, quando un ingorgo mi ha costretta a fermarmi, ho alzato lo sguardo e ritrovato il contegno.
Perché, a prescindere da quante volte l’abbia visto, mi toglie sempre il respiro il modo in cui il sole intenso e mite della Costa Azzurra fa risaltare alla perfezione ogni sfumatura cromatica. Le tegole rosso-melagrana delle casette color pastello, addossate l’una all’altra sui terrazzamenti delle colline; il verde scuro della macchia mediterranea che ricopre il litorale e le dorsali delle montagne; e soprattutto i blu… quello cobalto del cielo e il turchese delle onde lungo la costa, che arrivano a confondersi all’orizzonte in un abbraccio indaco, sfumato come un acquarello.
Arrivata a Port Vauban, senza fiato per il timore che la barca sia già salpata, mi infilo nel primo parcheggio libero e proseguo a piedi. Le suole di corda delle mie espadrillas non fanno alcun rumore mentre attraverso in tutta fretta un parco pubblico, dove gruppetti di anziani giocano a carte, seduti ai tavoli da picnic nella luce calda emanata dalla fortezza di pietra i cui bastioni vigilano da secoli sulla cittadina, proteggendola dagli invasori. All’estremità opposta del porto trovo il “molo dei miliardari”.
Molti dei più grandi yacht del mondo sono attraccati in questa enclave esclusiva, alcuni hanno talmente tanti ponti e un’architettura così complessa da assomigliare più a delle navicelle spaziali che a dei natanti. Strizzo gli occhi per decifrare i nomi verniciati in una grafia arzigogolata sulle poppe delle imbarcazioni. I loro proprietari sono noti a tutti nella zona: un principe arabo con la sua schiera di eredi, uno schivo magnate americano del software, un chiassoso petroliere russo. Sembra di sentire nell’aria l’odore di soldi e potere. L’eliporto sulla punta del molo è trafficato, e un velivolo atterra proprio davanti ai miei occhi, preciso e leggero come una libellula.
Finalmente trovo lo yacht che cercavo: Le troubadour, un tre ponti con lo scafo blu e i corrimano dorati, lucidati a specchio. È così grande e imponente che ho quasi paura ad avvicinarmi. Il personale, impettito nella sua divisa elegante, mi guarda sospettoso quando mi avvicino con cautela alla passerella. La pedana oscilla appena mentre sotto di me sfilano lentamente le anatre, le oche e qualche cigno. I gabbiani volano in cerchio sopra la mia testa, pronti a scendere in picchiata al primo baluginio di scaglie sotto il pelo dell’acqua.
Tendo il cellulare a un membro dell’equipaggio, per mostrargli il pass sul display. Nel prendere il telefonino lui abbassa gli occhi sulla mia mano e aggrotta la fronte. Seguendo il suo sguardo, noto i residui neri e blu del mascara waterproof che mi sono rimasti sulle unghie e le ostinate striature di rosa, bianco e rosso sul palmo. Sono il risultato della mattinata passata in camerino a truccare i volti impazienti degli attori, dando agli attempati un aspetto più giovanile, ai giovani un’aria più sofisticata, ai belli un tocco extra di glamour.
Posso solo immaginare cosa pensi di una donna come me – alta e trafelata, con la treccia ramata lunga fino ai fianchi e un semplice tailleur nero giacca e pantalone –, quando la maggior parte degli ospiti qui si presenta con abiti griffati e la classica abbronzatura targata Saint-Tropez: un perfetto rosa albicocca.
Osserva con attenzione il mio pass e si fa da parte, mormorando: «Merci, madame. Entrez, s’il vous plaît». Il tono è deferente, ma ho comunque l’impressione di trovarmi circondata da un branco di bestie feroci che non si sarebbe fatto il minimo scrupolo a scaraventarmi in mare se i miei documenti non fossero stati perfettamente in regola.
Vengo affidata al capitano, un francese impeccabile nella sua uniforme bianca con i galloni d’oro. Mi rivolge un cenno impercettibile e poi, con fredda formalità, mi fa strada lungo il ponte di teak fino a una scala a chiocciola. Sottocoperta si ferma davanti a una porta di mogano, prende dalla tasca un piccolo mazzo di chiavi, ne infila una nella serratura e mi cede il passo. Appena entrata, sento alle mie spalle lo scatto smorzato della porta e della serratura. Mi ha chiusa dentro.
Be’, almeno fin qui ci sono arrivata. Inspiro a fondo e mi guardo intorno. Mi trovo in una sorta di biblioteca arredata come un gentlemen’s club, con poltrone rivestite di pelle e seta, tappeti persiani e scaffali di ciliegio con le vetrinette sigillate per proteggere il contenuto dagli effetti deleteri dell’aria salmastra. Guardando meglio mi accorgo che non è soltanto la cabina a essere dotata di un sistema di controllo della temperatura: ogni cristalliera ha un proprio complicato termostato con indicatore dell’umidità, in modo che nulla possa guastare i sigari di importazione allineati nell’humidor o i fragili tesori custoditi in questa Wunderkammer galleggiante. Un sommesso ronzio metallico rivela le videocamere di sorveglianza montate ai quattro angoli del soffitto. Attivati dai sensori di movimento, gli obiettivi si spostano di continuo, tenendomi d’occhio con il loro sguardo rapace, mentre io riesco appena a trattenere l’impulso di rispondere con una boccaccia.
Nel silenzio assoluto che mi circonda, sento il mio battito ancora accelerato dalla corsa e dal nervosismo. Tanta fatica per arrivare in tempo e adesso mi ritrovo costretta ad aspettare i comodi di un uomo con le buone maniere di un gangster.
Comunque ormai sono qui e non intendo andarmene finché non sarò arrivata fino in fondo. La strada è stata lunga, e oggi scoprirò se ho scelto quella giusta. A giudicare dall’ambiente si direbbe di no. Non mi fido di quest’uomo, e le precauzioni che ha preso sono il segno che nemmeno lui si fida di me.
L’illuminazione soffusa e minimale di questo curioso santuario, così rigorosamente schermato dalla luce naturale, mi fa pensare che questi luoghi forse hanno davvero un lato oscuro. Ho sentito spesso racconti sulla misteriosa scomparsa di aristocratici facoltosi o frivole ereditiere, spariti da vie trafficate senza lasciare traccia, o sulla sorte imprevedibile toccata ai giocatori d’azzardo, divenuti famosi o finiti sul lastrico con una sola puntata al casinò, e provo un brivido nel ricordare la definizione che lo scrittore Somerset Maugham ha dato della Costa Azzurra: «Un posto soleggiato per persone ombrose».
Prima di approdare a questi lidi non mi ero mai considerata una persona ombrosa, ma qui – come in un ritratto cubista – tutti hanno mille sfaccettature. E quando sono arrivata – due anni fa, poco dopo il mio trentesimo compleanno – anche nella mia anima è emersa una vena corsara.
Mentre i miei occhi si adattano alla penombra, tenendo ben a mente che di sicuro qualcuno sta spiando ogni mio passo, mi avvicino a una panca di legno di noce, incassata nella parete per resistere al rollio e al beccheggio della barca. Ricorda così tanto il banco di una chiesa che nel sedermi assumo di riflesso l’atteggiamento umile e contemplativo di una signora provenzale, entrata a passi felpati in una cappella vuota per chinare la testa sul rosario e chiedere una grazia ai suoi santi, pregare per i suoi cari, ascoltare i consigli dei suoi numi tutelari. In un certo senso anche la mia presenza qui è una forma di omaggio ai miei avi.
Perciò mentre aspetto ripenso a mia mamma, una donna tanto timida eppure così piena di segreti. In fondo è stata lei a instradarmi verso questa strana avventura, passandomi il testimone che a suo tempo aveva ricevuto da sua madre. Sono riuscita a realizzare le speranze che entrambe hanno coltivato tanto a lungo, oppure le ho tradite?
Ancora non ho smesso di farmi domande e cercare conferme, indizi, piste. Mi serve un’ancora cui aggrapparmi in questo mare di incertezze, così chiudo gli occhi e per l’ennesima volta mi trovo a comunicare con mia nonna Ondine che da ragazza, tanti anni fa, viveva in una modesta casetta color miele, sopra una trattoria dall’aspetto apparentemente ordinario, in un paesino di mare non lontano da qui.
Capitolo 1
Ondine al Café Paradis, primavera 1936
Dal Mediterraneo si era levato un libeccio caldo e salmastro che, prima di insinuarsi nel giardino del Café Paradis, dove Ondine era intenta a pulire le verdure, aveva sospinto con solennità quasi araldica le onde crestate di bianco sugli scogli e sballottato i pescherecci nel porticciolo di Juan-les-Pins.
Era una bella mattinata d’aprile e la giovane si era rifugiata a lavorare all’aperto perché la cucina della trattoria era già un forno. Il piccolo patio del cortiletto, invece, poteva contare sull’ombra di un maestoso pino d’Aleppo, e Ondine sedeva sul muretto di pietra che circondava l’albero. Brandendo con sicurezza il suo coltello, sgranava e mondava le primizie provenzali: pisellini, carote e carciofi talmente teneri che si servivano anche crudi, in fettine sottili accompagnate da spicchi di limone così dolci che si mangiava anche la scorza.
La ragazza lavorava di buona lena e il velo di sudore sulla fronte la avvertì del vento in arrivo, che d’un tratto fece stormire i rami del pino. Poiché le avevano insegnato a credere nei presagi fausti e infausti della natura, Ondine posò il coltello, chiuse gli occhi e alzò il capo, inspirando a fondo la brezza che le accarezzava il volto e le riempiva le narici del profumo inebriante del mare.
Non le capitava spesso di avere un momento di quiete da dedicare ai suoi pensieri. Perciò, quando la vaga premonizione di un futuro più emozionante in serbo per lei cominciò a prendere forma nella sua mente, la giovane si sforzò di afferrarla, come tendendo le dita per catturare una lucciola.
«Ondine!» risuonò la voce della madre dall’interno della cucina. «Ma dove si è cacciata? On-di-ne!»
Il suo nome riverberò sulle pareti di pietra intonacata, facendola sobbalzare, e nel voltarsi la ragazza vide sua madre, incorniciata dal telaio della finestra come una temibile imperatrice che scruta i sudditi dal suo ritratto. Avevano già finito di servire la prima colazione e mancava ancora molto all’ora di pranzo, ma gli standard della trattoria erano altissimi, perciò in cucina il lavoro non mancava mai.
Al Café Paradis ciascuno aveva un compito ben preciso, persino il gatto tigrato, incaricato di balzare sul primo topo abbastanza incauto da avvicinarsi alla dispensa, e il bulldog, che montava la guardia contro i vagabondi che si aggiravano in cerca di avanzi o di una finestra lasciata aperta. Quanto a Ondine, che aveva compiuto diciassette anni, le sue incombenze comprendevano qualsiasi cosa sua madre le ordinasse di fare.
Sporgendosi dalla finestra, Madame Belange la individuò sotto l’albero. «Cosa pensi di fare, seduta in giardino come un pascià?»
«Ho appena finito con la verdura, maman!» rispose la ragazza, alzandosi e raggiungendo sua madre con la cesta appoggiata al fianco.
Il vento proseguì la corsa senza di lei. Appena varcata la soglia della cucina, i profumi del giardino lasciarono il posto agli odori consueti dell’olio di frittura, del carburante e della legna bruciata. Eppure quel giorno c’era qualcosa di speciale nell’aria. Era tutta la mattina che i suoi genitori si comportavano in modo insolito, parlottando tra loro con aria complice.
Da vera intenditrice, Ondine riconobbe al volo i piatti del giorno dal loro profumo: la pissaladière – una focaccia di cipolle e olive nere –, lo stufato di maiale aromatizzato con mirto e vino rosso, e la portata di pesce… Possibile che fosse davvero…?
Con un impeto di entusiasmo, la ragazza si avvicinò alla vecchia stufa di ghisa nera che scoppiettava in un angolo. La fragranza che filtrava dalla grossa pentola sul fuoco era inequivocabile.
«Bouillabaisse!» esclamò la ragazza, domandandosi come mai sua madre avesse scelto di cucinare quella zuppa invece della bourride, ben più semplice e meno costosa. Sollevò il coperchio e inspirò a fondo. Sedano, cipolla, aglio, pomodoro, finocchio, pepe, prezzemolo, timo, alloro e la scorza d’arancia tipica delle ricette del Sud della Francia; e un ultimo ingrediente, raro e prezioso, che dava al brodo il colore dell’oro.
«Hai usato lo zafferano di Père Jacques?» domandò con stupore.
Per un istante sua madre distolse lo sguardo dal suo lavoro. «Sì» rispose. Poi, tendendo una mano, prese una minuscola ampolla di vetro e la sollevò controluce, scrutandola con aria reverenziale. «Purtroppo è finito. È rimasto un ultimo pistillo che non ho avuto il coraggio di usare.» Madre e figlia si scambiarono uno sguardo sgomento, poi tornarono a contemplare il filamento rosso di zafferano che, come diceva l’anziano monaco, conferiva alle pietanze il sapore misterioso «dell’erba appena falciata unito alla dolcezza del miele di castagno».
Quando la giovane si era diplomata nel collegio cattolico sulle colline nei pressi di Nizza, Père Jacques le aveva regalato una scorta di zafferano del suo orto. Incaricato di dirigere la cucina del convento, quell’uomo pacato e meditativo era uno dei pochi adulti che non si spazientivano delle domande di Ondine, ma anzi ne assecondavano la curiosità. Sapendo che la famiglia della ragazza aveva una trattoria, l’aveva esentata dai lavori domestici tipicamente assegnati alle allieve per assumerla come sua assistente nella cura dei giardini del convento e insegnarle gli antichi segreti della sua cucina.
Diceva con orgoglio che non esisteva niente di paragonabile allo zafferano francese mentre le mostrava i filari di crochi color malva che coltivava con pazienza, in attesa dell’effimera fioritura d’ottobre. In quei pochi giorni tutti i monaci si riunivano a raccogliere i delicati pistilli rossi – soltanto tre per ogni fiore – che poi, una volta essiccati, Père Jacques conservava gelosamente nelle ampolle di vetro. Ondine e sua madre avevano usato la loro piccola scorta con parsimonia, riservandola soltanto alle pietanze delle grandi occasioni, come le creme e i macarons di Natale.
«Ma perché proprio oggi?» chiese Ondine, incuriosita.
«A pranzo avremo un nuovo cliente importante» rispose distrattamente sua madre.
Ondine prese un cucchiaio e assaggiò la bouillabaisse. «Mmm… è squisita! Però manca un po’ di peperoncino.»
Madame Belange scosse la testa. «No» ribatté. «Va benissimo così com’è. Oggi preferisco andarci cauta.»
Ondine provò un moto di affetto per sua madre che, a differenza di Père Jacques, viveva sempre sul filo del rasoio, impegnata in una lotta snervante contro il tempo, i fornitori, le spese, senza mai un centesimo o un minuto da perdere. Forse era stata quell’esistenza a renderla così scontrosa. Persino adesso che aveva chiesto il suo aiuto, continuava a urtarla con i fianchi, come per dimostrarle che in quella cucina non c’era spazio per due donne adulte.
«Vite, vite! Al lavoro!» la incalzò, scostandosi una ciocca di capelli dalla fronte con il polso imbiancato di farina. «Fa’ attenzione!» gridò dopo un istante. Il fattorino del lattaio aveva di colpo spalancato la porta di servizio, spingendola con una cassetta di legno carica di uova, formaggio e panna. Ondine si scansò appena in tempo.
Mentre sua madre pagava la consegna, la ragazza cominciò a togliere le merci fresche dalla cassetta per riporle sul tavolo al centro della stanza. Si era alzata al sorgere del sole, il suo primo compito era stato preparare la cioccolata calda che ogni mattina beveva in fretta insieme ai genitori, poi aveva servito le brioche e il caffè ai clienti. Dopodiché aveva messo a cuocere un pentolone di verdure per il brodo e infine era uscita in cortile a sbucciarne altre. In genere il suo incarico successivo erano i contorni per il servizio dell’ora di pranzo.
Quel giorno, invece, sua madre le assegnò un compito diverso.
«Prepara un’insalata sola, per il nostro nuovo patron. E che sia perfetta. Poi annota tutti gli ingredienti che abbiamo usato per il suo pranzo.» Richiuse un cassetto con un colpo del fianco. «Il patron diventerà un nostro cliente abituale, quindi dobbiamo evitare di servirgli sempre le stesse pietanze. Forza, prendi un quaderno, tout de suite. Gli anni passati a studiare in quella scuola saranno pur serviti a qualcosa!»
I quaderni cui si riferiva sua madre erano allineati su uno scaffale: volumi rilegati in marocchino, omaggio di un cartolaio che pranzava alla trattoria tre volte alla settimana. Ondine ne prese uno nuovo e lo aprì al frontespizio, decorato con una greca di viticci e grappoli d’uva, all’interno della quale c’era una riga vuota con la designazione: NOM.
«Come si chiama il nuovo patron?» chiese. Come minimo doveva trattarsi di un banchiere o un avvocato.
Madame Belange agitò un mestolo con aria distratta. «E chi lo sa? È ricco, il resto non conta.»
Così Ondine scrisse soltanto la «P» di patron. Poi all’inizio della prima pagina bianca annotò la data – 2 APRILE 1936 – e trascrisse tutti gli ingredienti e le ricette del giorno. Sua madre teneva un registro solo per i clienti più importanti o per gli eventi speciali, come i banchetti serviti alle feste o ai ricevimenti di nozze. Sotto ogni ricetta aggiungeva annotazioni specifiche sulle preferenze del patron o il modo migliore di adeguare una pietanza ai suoi gusti.
Ora, alzando lo sguardo dai fornelli, ordinò in tono deciso: «Adesso metti via il registro e impacchettiamo tutto».
«Lo impacchettiamo?» ripeté Ondine sorpresa.
Sua madre assunse un’espressione solenne. «Il patron ha affittato una delle ville in collina. Ecco l’indirizzo.» Prese un foglietto dalla tasca del grembiule e lo tese alla figlia. «Ogni giorno andrai in bicicletta a portargli il pranzo.»
«E cosa sono, un mulo?» ribatté la ragazza. «Da quando facciamo consegne a domicilio? Perché non si scomoda lui e viene a pranzare in trattoria come tutti gli altri?»
«È un personaggio molto famoso a Parigi» spiegò sua madre. «Parla francese, ma pare sia originario della Spagna. Al collegio hai studiato spagnolo, no?»
«Un pochino» rispose Ondine sulla difensiva.
«Be’, finalmente ti tornerà utile.» Commentò la donna guardandosi attorno con aria risoluta. «Prendi la caraffa a strisce per il vino.»
«Ma è la tua preferita!» obiettò.
In realtà a preoccuparla era il fatto che quella caraffa – alta e decorata a mano, con righe rosa e azzurre – le era stata promessa come parte della dote, sempre ammesso che Ondine fosse arrivata all’altare. Rassegnata, la giovane mormorò a mezza voce: «Spero almeno che questo riccone spagnolo la apprezzi».
Il tempo stringeva, perciò doveva sbrigarsi. Insieme a sua madre avvolse ogni piatto in uno strofinaccio a quadretti rossi e bianchi, poi li ripose in un cesto da picnic con il rivestimento interno di metallo per trattenere il calore. Infine scese in cantina, avvicinò un otre al rubinetto di una botte e lo riempì con il vino bianco della casa. Madame Belange ordinò a uno dei camerieri di portare fuori il cesto e di assicurarlo al portapacchi della bicicletta.
«Allora, ascoltami bene» disse, scrutando la figlia con occhi severi. «Il patron ti ha lasciato la porta di servizio aperta. Entra da lì, vai dritta in cucina, scalda le pietanze e apparecchia. Dopodiché torna subito qui. Non aspettare che lui scenda in sala da pranzo.» Le assestò un pizzicotto sul braccio. «Mi hai sentita, Ondine?»
«Ahi!» protestò lei. Aveva ascoltato le istruzioni con la massima attenzione, non si meritava quel trattamento. Ma Madame Belange pensava che un gesto valesse più di mille parole, e se qualcuno indugiava o faceva troppe domande sottolineava l’urgenza dei suoi ordini con uno scappellotto. Da bambina era stata educata a obbedire senza chiedere spiegazioni, perciò a sua volta aveva cresciuto la figlia come una brava chioccia con il suo pulcino: nutrendola, insegnandole a cavarsela da sola e beccandola quando si allontanava dal seminato.
Snocciolò di nuovo le istruzioni: «Entra, prepara le pietanze, apparecchia ed esci subito. Non chiamarlo e non fare rumore. Più tardi andrai a recuperare le stoviglie, ma sempre facendo ben attenzione a non disturbare».
A Ondine veniva da ridere al pensiero di introdursi come una ladra in casa di uno sconosciuto, ma si trattenne. A giudicare dall’espressione seria di sua madre, la questione era della massima importanza.
«D’accordo, maman» rispose, soffocando la curiosità insieme alla risata.
«Prendi il mazzo di narcisi dalla sala da pranzo» proseguì Madame Belange. «Al ritorno ti fermerai al mercato a comprare nuovi fiori per la trattoria» aggiunse poi, a bassa voce, mentre con una mano si frugava la tasca in cerca di spiccioli. «Tieni.» Poi la spronò con una gomitata. «E adesso fila!»
Ondine obbedì, superando la porta a battente che conduceva alla sala da pranzo, riservata al servizio serale. Colazione e pranzo venivano sempre serviti in veranda, protetta in caso di maltempo da un robusto tendone a strisce bianche e grigie.
Il Café Paradis occupava il pianterreno di un edificio di pietra calcarea, bruna e dorata come una pralina al miele. La famiglia abitava l’appartamento al primo piano, che comprendeva la stanza matrimoniale dei signori Belange e un’altra più piccola che di tanto in tanto veniva affittata ai clienti di passaggio. Un tempo quella camera era appartenuta ai due figli maschi, ma entrambi erano caduti nella Grande Guerra e ora riposavano nel cimitero del paese accanto ai loro fratellini morti di scarlattina, prima ancora della nascita di Ondine. Quanto a lei, occupava una stanzetta all’ultimo piano, una specie di solaio con il tetto mansardato, in passato riservato alla servitù.
La giovane attraversò la sala da pranzo deserta, con il parquet lucidato, la boiserie scura, le sedie e i tavoli di mogano. Da un lato c’era il bancone del bar e sulla parete di fronte erano appesi uno specchio con la cornice dorata e una copia della Ragazza alla finestra, il capolavoro dipinto da Rembrandt nel 1645.
«Bonjour» disse alla fanciulla del ritratto, che considerava il suo portafortuna fin da quand’era piccola.
La giovane nel dipinto era misteriosa quanto la Monna Lisa e molti esperti d’arte – compresi alcuni clienti della trattoria – discutevano ancora della sua identità. Era un’aristocratica, come suggerivano il doppio filo di perle che portava al collo e il ricamo
sull’orlo della camicia? Oppure una domestica, con le guance arrossate e le maniche rimboccate? O magari una prostituta che si sporgeva dalla finestra con i gomiti appoggiati al davanzale per mettere in mostra la scollatura?
Ondine aveva sempre amato quel quadro, perché gli occhi tondi e luminosi della ragazza sembravano seguirla con lo sguardo, come se, passandole davanti, avesse attirato la sua attenzione. Adesso, però, le sembrava di leggere tutt’altro in quelle iridi scure. «So cosa sogni» parevano dirle quegli occhi. «Credi davvero di avere ciò che serve per conquistare il mondo là fuori?»
Di riflesso Ondine si guardò allo specchio. Non aveva di certo un fascino misterioso, tuttavia il caldo color nocciola dei suoi occhi spiccava sulla carnagione appena abbronzata e il lavoro mattutino le aveva imporporato gli zigomi e le labbra. Il suo tratto distintivo era la chioma scura, folta e mossa.
Una volta un ragazzo le aveva detto che quei riccioli magnifici erano i punti interrogativi di tutte le domande intelligenti e vivaci che le frullavano nella testa.
Quel giovane si chiamava Luc ed era stato il suo primo amore, un sentimento dolcissimo e ricambiato. Rimasto orfano a quattordici anni, Luc aveva dovuto lasciare la scuola per mettersi a lavorare come garzone in una pescheria. Quando si presentava alla porta di servizio del Café Paradis per consegnare una cassetta di pesci argentati e allineati con cura, spesso teneva in serbo anche un regalino per lei: una conchiglia, una piantina di fragole selvatiche o una collana di perline di legno colorate comprata da un marinaio venuto da chissà quale paese esotico e remoto.
In cambio Ondine gli offriva di nascosto qualcosa da mangiare, in genere una fettina di tartelette o qualsiasi boccone di carne e verdura nutriente riuscisse a sgraffignare. Luc era sempre affamato, eppure dimostrava la sua gratitudine gustando quei manicaretti senza fretta, quasi con reverenza. Per Ondine era un piacere posare una prelibatezza sul palmo di quelle mani forti e decise, e poi guardarlo mentre se la portava alla bocca.
Monsieur Belange, però, era convinto che un uomo prima di sposarsi doveva essere in grado di mantenere la moglie, così il dolce Luc si era imbarcato su uno dei mercantili che salpavano di continuo dal porto di Antibes…
camille  foto presa dal web
foto presa dal web
Camille Aubray ha scritto per la tv e insegnato alla New York University. Questo è il suo primo romanzo, frutto dei suoi viaggi in Costa Azzurra e del suo amore per l’arte.
A proposito, mentre il libro racconta un pezzo della vita di Picasso intrecciando realtà e fantasia, tutti i quadri citati sono reali. Tranne uno.