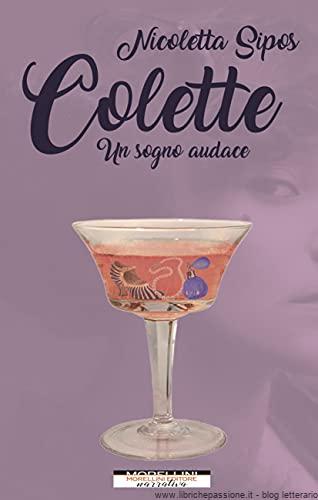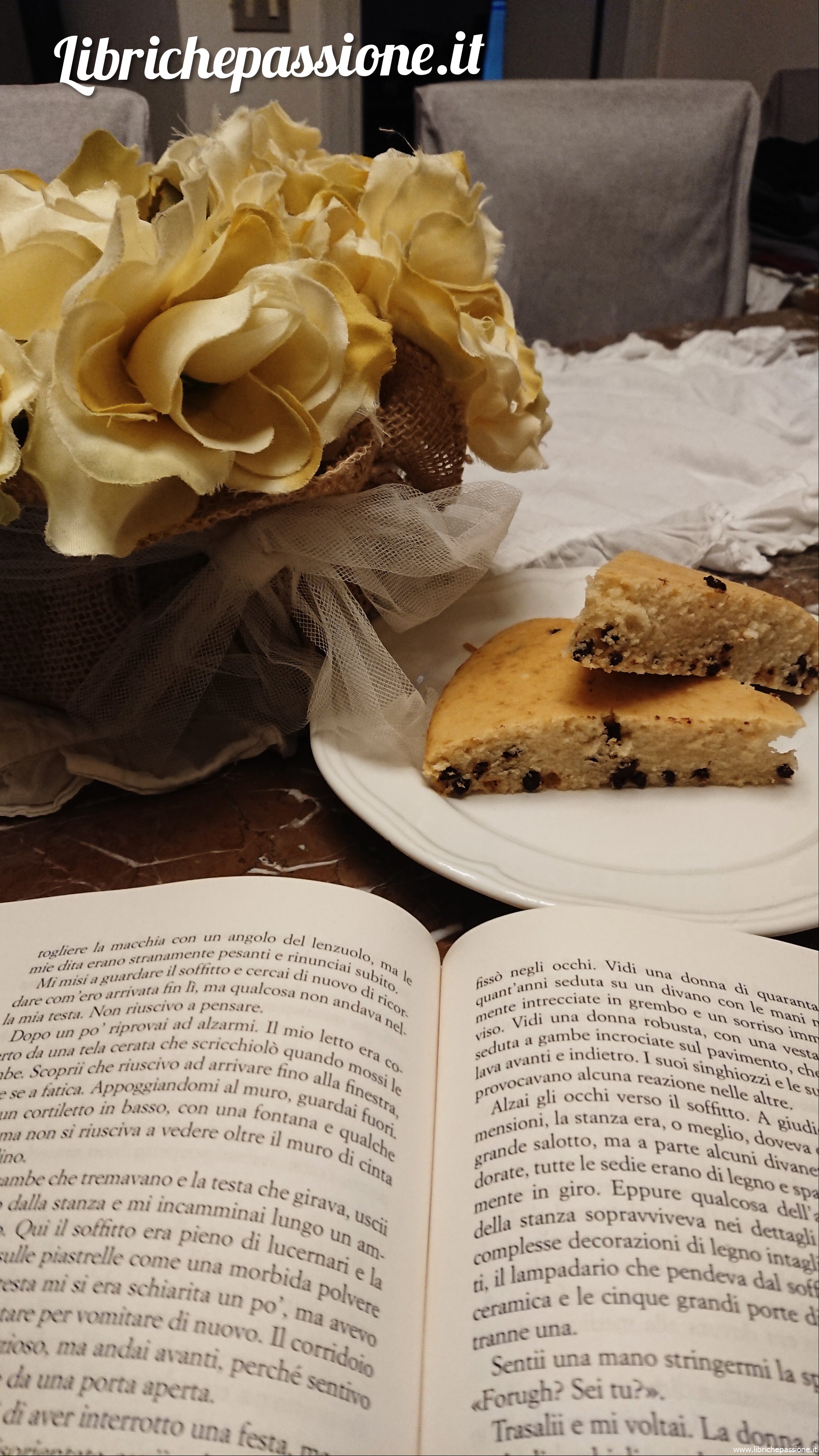Trama
La saga della famiglia Casadio
La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all’incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all’inizio dell’Ottocento, qualcosa cambia per sempre: Giacomo Casadio s’innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l’eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che emana un dolce profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra l’irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in fondo, non importa se dettata dall’amore o dalla ribellione, dalla sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto a onta della terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta…
La saga di una famiglia che si dipana attraverso due secoli di Storia, percorrendo gli eventi che hanno segnato l’Italia: dai moti rivoluzionari che portarono all’Unità fino agli Anni di Piombo. Una storia epica e intima insieme, un romanzo in cui immergersi per recuperare la magia dei sogni e ritrovare tutto ciò che ci rende davvero vivi.
Estratto
A Guido
Prologo
«Anno Christi MCCCCXII. A dì 18 de luglio venne in Bologna uno ducha d’Ezitto, lo quale havea nome el ducha Andrea, et venne cum donne, putti et omini de suo paese; et si possevano essere ben da cento persone.»
Da Cronica gestorum ac factorum memorabilium
civitatis Bononie, edita a fratre Hyeronimo de Bursellis
(ab urbe condita ad a. 1497) (in LUDOVICO ANTONIO
MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores,
Tomo XXIII, 1733)
«Noi siamo fatti della stessa materia dei sogni
e la nostra breve vita
si completa in un sonno.»
WILLIAM SHAKESPEARE,
La tempesta (atto IV, scena I)
«Èper colpa di una zingara se la famiglia si è imbastardita.» Me lo ripeteva spesso mia nonna, grembiule bianco e maniche rimboccate fino ai gomiti, mentre si apprestava a tirare la sfoglia. Cominciava a raccontare la nostra storia partendo da quell’antenata gitana e intanto lasciava cadere le uova nel vulcano di farina. Un leggero movimento del polso, crac, partiva un uovo; un altro movimento, crac, partiva il secondo. Lavorava la pasta e intanto parlava, e piangeva, e rideva. Era certa che fosse per colpa del matrimonio di un nostro avo con quella zingara, avvenuto due secoli prima, se metà dei nostri parenti aveva la pelle chiara e gli occhi azzurri, mentre l’altra metà nasceva con i capelli corvini e gli occhi neri.
Non erano solo vaneggiamenti dovuti all’età. L’arrivo degli zingari nel paesino di Stellata, il luogo che ha dato i natali alla mia famiglia, è testimoniato da un documento vecchio di secoli che giace negli archivi storici della Biblioteca Ariostea di Ferrara.
La carovana di gitani era apparsa in paese in una giornata di pioggia apocalittica. Era novembre e ormai diluviava da settimane. I campi erano scomparsi sotto una spanna d’acqua; quindi erano spariti i sentieri, le strade, i cortili e infine la piazza. Per potersi muovere, la gente aveva cominciato a usare le barche. Stellata aveva finito per trasformarsi in una sorta di piccola Venezia, ma una sua versione misera, senza i palazzi e le gondole, con case malandate, imbarcazioni marce e le acque salmastre del fiume.
I carrozzoni si erano trascinati cigolando sul ponte di barche del Po, quindi avevano proseguito lungo lo stradone sull’argine. L’acqua batteva e le zampe delle bestie sprofondavano nella melma. Le ruote si erano incagliate, il legno scricchiolava, e i carrozzoni avevano finito per bloccarsi nel fango. Gli uomini avevano lavorato fino a tarda notte, cercando di liberarli, ma per cinque carrozzoni non c’era stato nulla da fare, e gli zingari si erano dovuti fermare in paese in attesa di un tempo migliore.
Quando la pioggia era cessata, i carrozzoni erano stati liberati e le ruote sostituite, ma una serie di eventi aveva fatto sì che la partenza dei forestieri venisse rimandata più volte: prima si era dovuto attendere l’esito di un parto difficile, poi qualcuno si era ammalato di dissenteria, infine un loro cavallo era morto. Quando gli zingari erano stati finalmente pronti a riprendere il cammino, era sopraggiunto uno degli inverni più rigidi del secolo e il paese era sprofondato nel gelo. Mettersi in viaggio era sembrata a tutti un’idea insensata.
Per rompere la monotonia del lungo inverno, qualche zingaro si tenne occupato ferrando i cavalli; altri iniziarono a vendere al mercato cesti di giunco, briglie, setacci e tamburelli; altri ancora cominciarono a suonare ai battesimi e ai matrimoni. Arrivò e finì la primavera; in estate, scoppiò il tifo e il paese venne isolato. Con il passare delle stagioni, la vita di quegli zingari venne irrimediabilmente segnata dal vizio della quotidianità.
Senza che gli abitanti di Stellata quasi se ne rendessero conto, il loro astio verso i nuovi arrivati si trasformò in abitudine. I vecchi morivano, i bambini nascevano e i giovani s’innamoravano senza badare troppo alle differenze. Fatto sta che, in poche generazioni, un terzo degli abitanti di Stellata si ritrovò nelle vene sangue zingaro.
È qui che entra in scena il mio trisavolo, Giacomo Casadio. A Stellata era conosciuto come un tipo solitario, dal temperamento malinconico. La natura lo aveva però dotato di una grande immaginazione e ben presto si era manifestato in lui l’estro del visionario. Il suo sogno era costruire barche, ma non le solite, modeste imbarcazioni che si vedevano passare lungo le rive del Po. Lui aveva in mente vascelli con stive capaci di contenere non solo grano, legname, canapa e animali da cortile, ma anche vacche e cavalli. In poche parole: Giacomo Casadio progettava qualcosa di molto simile all’Arca di Noè.
L’idea gli era venuta da piccolo, in canonica. Sfogliando una Bibbia, si era imbattuto in un’immagine dell’arca pronta a salpare. Era bellissima, con la pancia tonda, le teste di leoni e giraffe che uscivano dalle finestrelle, e più sotto le file di anatre, di galli e di galline, e poi le coppie di capre, dromedari, pecore e asinelli. Una barca capace di sfidare il Diluvio Universale e di salvare tutti gli esseri viventi della Terra! Quell’immagine biblica aveva gettato il seme della sua ossessione. Una volta cresciuto, Giacomo aveva cominciato a costruire arche nel cortile di casa. Ci aveva pensato a lungo: il fiume era da sempre la via di trasporto più veloce per il continuo via vai di persone, carri e bestie; e c’erano i pescatori, i ranari, i sabbiaroli… Stellata, dove il Po era ampio e profondo, poteva trasformarsi in un grande porto fluviale.
Gli ci erano voluti tre anni per terminare il progetto. Quando l’arca fu pronta, Giacomo attese il 4 dicembre, giorno dedicato a santa Barbara, protettrice dei marinai, per vararla.
Quel mattino in paese c’era grande agitazione. L’intero borgo era sull’argine per godersi lo spettacolo. Arrivò anche il prete con il crocifisso, i chierichetti e l’acqua santa. Un enorme carro tirato da dodici buoi spinse l’imbarcazione sino al fiume. Giunti alle sue sponde melmose, gli uomini più forti iniziarono a trascinare l’arca, spostando l’uno dopo l’altro i tronchi su cui poggiava per farla scivolare prima giù dal carro, poi lungo la riva. Ci furono grida di stupore, incitazioni, parecchi traballamenti e trepidanti momenti d’attesa, ma alla fine l’arca fece il suo ingresso nel Po. Un fragore di esclamazioni e applausi si levò tutt’intorno.
Con il suo lungo passo dinoccolato e l’aria trionfante, Giacomo salì a bordo. Salutava la folla radunata lungo la riva con gli occhi azzurri che luccicavano, il petto gonfio d’emozione. Mai nella sua vita aveva provato una simile felicità.
Purtroppo l’arca non andò lontano; in meno di un’ora, scese a picco sul fondale.
L’uomo cadde in un profondo stato di abbattimento, che durò tutto l’inverno. I suoi erano così allarmati che alla fine il padre gli suggerì di riprovare. «At ghè ’na testa fina. La prósima volta la to barca at’la porti fin al mar!» disse con convinzione.
Spinto da quell’incoraggiamento, Giacomo superò lo sconforto e iniziò a costruire una seconda arca, ma non ebbe miglior fortuna. Arrivò a fabbricarne una mezza dozzina, e l’una dopo l’altra finirono tutte per affondare. A onor del vero, un paio stettero a galla per giorni. Con la sesta, poi, Giacomo raggiunse addirittura Comacchio e il delta del Po ma, proprio quando pensava di essere riuscito nella sua impresa, l’imbarcazione iniziò a riempirsi d’acqua e in poche ore colò a picco. In quel punto, il livello del fiume era basso e si racconta che per generazioni i pescatori di anguille furono in grado di scorgere l’albero maestro che spuntava dalle acque.
Tra un fallimento e l’altro, Giacomo viveva lunghi mesi di prostrazione, talmente debilitanti che non riusciva nemmeno a lavorare nei campi. Poi, d’improvviso, subentravano periodi di euforia e il sogno di costruire un’arca tornava a ossessionarlo. Giunse però il momento in cui anche il padre perse la pazienza. «Adès basta! At zsé sta bon ad fundáran sié. Tuti zo in d’al Po com ad li predi!»
Ma, nonostante le sei barche affondate nel Po come pietre, il sogno di Giacomo era grande, e i suoi sapevano che costruire arche era l’unica cosa che portasse un poco di felicità nella vita di quel figlio, malinconico fin da quando stava nel ventre di sua madre. Così, nel giro di qualche mese, il cortile tornava a trasformarsi in un cantiere navale con impalcature, pile di assi, secchi di chiodi, funi, tenaglie, seghe e rotoli di cime multicolori. E, in mezzo a tutto quel groviglio di legname e utensili, c’era Giacomo che piallava, inchiodava e incollava giunture. Ogni volta che terminava una barca, attendeva giudiziosamente il giorno di Santa Barbara per vararla, ma la protettrice dei marinai non gli fu mai d’aiuto e le imbarcazioni finirono tutte per affondare.
Quando non lavorava nei campi, o non era preso dalla costruzione di una nuova arca, Giacomo passava il tempo da solo. Aveva pochi amici e un autentico terrore delle donne, tanto che giunse all’età di quarantacinque anni senza aver mai avuto una fidanzata. Poi, durante una festa di paese, una zingara incrociò il suo cammino. Lui l’aveva già notata da tempo: era alta, con un corpo flessuoso e una massa di capelli neri che le arrivava fino alla vita. Se ne andava in giro per Stellata con fare spavaldo, i sottanoni colorati, una moltitudine di penne di fagiano tra i capelli, vistosi anelli alle dita e numerose collane sul petto. Giacomo l’aveva sempre evitata, intimidito dalla sua baldanza; in più provava diffidenza per quella strana gente. Però quel giorno la zingara gli andò vicino e lo fissò dritto negli occhi. Quando gli rivolse la parola, lui trasalì e cercò di svignarsela, ma la ragazza lo afferrò per un braccio. «Dove vai? Mica ti mangio. Voglio solo leggerti il futuro.»
«Lasa pèrdar. Il mio destino lo conosco senza che me lo vieni a dire te.»
Voleva scappar via, ma lei non si diede per vinta e gli prese le mani. «Fammi vedere. Viollca non sbaglia mai.»
Non gli lesse il futuro. Gli osservò solo i palmi, poi gli strinse le mani nelle sue, sgranò gli occhi e annunciò: «Sei arrivato, finalmente! Erano anni che ti aspettavo».
Pochi mesi dopo, Viollca era incinta e, contro la volontà di entrambe le famiglie, i due si sposarono.
1800
Era un borgo di poche centinaia di abitanti, raccolto tra la strada e il fiume; un paese povero, ma con un nome tanto bello da non sembrare vero. A parte quello, però, di poetico a Stellata non c’era granché: una piazza con i portici, un’umile chiesa del XIV secolo, due fontane per l’acqua e i ruderi di un antico forte accanto al fiume. Pochi sapevano delle sue origini gloriose. Fin dal Medioevo, Stellata era stata un punto di difesa strategico contro i tentativi di conquista di Venezia e Milano, situata com’era sul Po e nel punto d’incontro tra gli attuali Veneto, Lombardia ed Emilia. Lucrezia Borgia ci era passata più volte nei suoi viaggi verso Mantova, e a Stellata aveva vissuto anche il figlio dell’Ariosto. Ma solo don Mario, il parroco, ne era a conoscenza, anche perché metà del paese era analfabeta e per l’altra metà restava comunque un mistero il fatto che il poeta avesse nominato quel misero villaggio nel canto XLIII dell’Orlando Furioso.
Restò Melara nel lito mancino;
nel lito destro Sermide restosse;
Figarolo e Stellata il legno passa,
ove le corna il Po iracondo abbassa.
Agli inizi del XIX secolo, il passaggio di legno fra Ficarolo e Stellata c’era ancora. Si trattava di un ponte galleggiante formato da vecchie barche di legno, legate l’una all’altra con grosse funi, probabilmente non molto diverso da quello citato dall’Ariosto secoli prima. Della fortezza invece rimanevano soltanto travi marce, tetti sfondati e cacche di pecora disseminate ovunque.
I Casadio vivevano appena fuori del paese, nella località detta «La Fossa» per via del canale che, nel bel mezzo della loro terra, segnava il confine tra le province di Ferrara e di Mantova. La loro casa era una costruzione di mattoni tipica della pianura padana, con il portico ad archi, le stanze ariose e i soffitti alti. C’erano un fienile, la stalla, il cortile di terra battuta, un porcile e la vigna. I muri erano senza intonaco e aveva finestre piccole, con le persiane tenute chiuse da maggio a ottobre per evitare le mosche e il caldo.
Viollca vi si trasferì dopo il matrimonio con Giacomo. I suoceri faticarono non poco ad abituarsi alle strane usanze della nuova arrivata. Da parte sua, la zingara non scese mai a compromessi: continuò a vestirsi con i suoi sottanoni multicolori e a ornarsi i capelli con penne di fagiano. La mattina, appariva reggendo un vecchio mortaio e passava ore a preparare infusi con erbe e strane radici.
Si dedicava anche a elaborati rituali di pulizia che dovevano eliminare ogni contaminazione.
«Non possiamo vivere tranquilli finché qui ci sarà qualcosa marhime», ripeteva.
«Mari… che?» le chiedeva la suocera, turbata.
Ciò che fosse o non fosse marhime, cioè «contaminato» in lingua romaní, era sancito dalla divisione tra l’interno e l’esterno della casa. Viollca si occupava di mantenere le stanze meticolosamente pulite e in ordine, mentre le stalle e l’aia erano responsabilità di altri membri della famiglia. Per lei, infatti, toccare i rifiuti o gli escrementi degli animali costituiva una delle più gravi forme di contaminazione. Non andò mai a lavorare nei campi, perché per la sua gente coltivare la terra era un tabù; riservava invece molta cura al modo di cucinare i cibi, anche se, secondo lei, solo alcuni animali potevano essere mangiati o addirittura toccati. Odiava cani e gatti perché si leccavano e per questo erano impuri. Di tutte le carni, la sua preferita era quella del porcospino, animale considerato tra i più puliti proprio perché, dati gli aculei, non poteva leccarsi.
Un’altra strana abitudine di Viollca era mettere ogni sera una ciotola di latte sul gradino appena fuori dalla porta.
«Cosa fai?» le chiese Giacomo la prima volta che la vide compiere quel rito.
«È per il serpente buono», rispose lei con fare tranquillo.
Gli zingari credevano che, nelle fondamenta di ogni casa, vivesse un serpente buono, dalla pancia bianca e con i denti senza veleno. E pensavano che ogni notte questo serpente strisciasse sulle persone che dormivano, per proteggerle e portar loro fortuna. Se però il serpente fosse stato ammazzato, qualcuno della famiglia sarebbe morto e su tutti gli altri si sarebbe abbattuta una serie di disgrazie. Per questo Viollca metteva sempre un po’ di latte fuori dalla porta: per ringraziare il serpente e nutrirlo durante le sue escursioni notturne.
«C’la sigagna l’è tuta mata! Quella zingara è pazza!» si lamentavano i suoceri. Allo stesso tempo, però, osservavano compiaciuti la trasformazione che la giovane donna aveva portato nella vita di Giacomo. Quel figlio, da sempre malinconico, ora cantava ogni mattina facendosi la barba, e la notte scandalizzava la famiglia per i gorgheggi inequivocabili che uscivano dalla sua stanza da letto. Fu per amore di Giacomo che i suoi impararono a convivere con le stranezze della nuora. E dovettero pure ammettere che i misteriosi intrugli di Viollca funzionavano.
«Sono una drabarno e ogni drabarno sa come curare», assicurava la zingara. «Per i cavalli so cosa fare, e per gli uomini è uguale. Se a un cavallo prende il dolore alla pancia, allora ci vuole qualcuno che ha le dita così, vedi? Che indice e mignolo si toccano dalla parte di sopra senza sforzarli. Prendi la paglia che sta sotto il cavallo, e con quelle dita così ce la butti sopra. La getti via, poi la riprendi e la metti ancora sopra la bestia. Per tre volte, e il cavallo è guarito. Però per gli uomini ci vuole anche una testa di volpe, solo le ossa, e berci dentro questo infuso. Ecco, tenete», diceva al suocero. «Da questa testa di volpe hanno bevuto anche i bambini e non c’è mai stato bisogno di nessun dottore. Adesso masticate questo.»
«Cus a ghè déntar?» chiedeva lui.
«Ci metto la polvere di mostarda e il succo di certe radici che so io. Ci faccio delle palline e voi le dovete inghiottire prima e dopo il sonno. È per togliervi il fuoco dai polmoni. Adesso ripetete: ’Gesù è stato colpito, gli ebrei si sono seduti sul suo petto, Dio li ha scacciati. Un demonio è seduto sul mio petto. Donne bianche, allontanatelo e mettete su di lui una grossa pietra!’»
«Dio non esiste!» ribatteva il vecchio, battendo il pugno sul tavolo.
«Non m’importa se ci credete o no, basta che adesso mandate giù», commentava lei senza scomporsi.
Il giorno 18 del terzo mese del nuovo secolo, nacque l’unico figlio di Giacomo e Viollca Casadio: un maschio di quattro chili, con i capelli corvini e lo stesso sguardo selvatico della madre. Ancora sporco di parto, il bambino aprì gli occhi e si guardò intorno con un fare inquisitorio che spaventò la levatrice.
«Maria santissima… Al gà du oc cal par un vec! Ha due occhi che pare un vecchio!» esclamò la donna.
Il neonato nemmeno piangeva. Girava la testa a destra e a sinistra, scrutando il mondo, assorbito da tutte le novità che di colpo gli si erano aperte davanti.
Viollca mise da parte un pezzo del cordone ombelicale e spiegò: «Una volta seccato, lo cucio in un sacchetto e glielo appendo al collo. Gli porterà fortuna».
Non appena il bambino fu lavato, lo allattò al seno destro, lato che simboleggiava la verità, la fortuna e il bene. Quando poi giunse il momento di scegliere il nome, lei annunciò: «Lo chiameremo Dollaro».
«Che nome è?» chiese Giacomo.
«Mi hanno detto che è una moneta. Se lo chiamiamo così, non soffrirà mai la fame.»
Anche don Mario mostrò lo stesso scetticismo, non potendo prevedere che, con quel battesimo, iniziava una secolare, inutile guerra della parrocchia contro gli stravaganti nomi che i Casadio avrebbero scelto per i nuovi nati.
«Il denaro è lo sterco di Satana. Nessun ’Dollaro’ riceverà mai il battesimo nella mia chiesa!» tuonò il prete. «Ci vuole il nome di un santo che protegga la creatura e sia di buon auspicio, altrimenti non se ne fa niente.»
Diede a Giacomo e a sua moglie un libro che conteneva i nomi di tutti i santi riconosciuti dalla Chiesa, con il giorno a loro dedicato e con tanto di elenco dei miracoli attribuiti a ognuno di essi.
La coppia non andò oltre le prime righe. Dopo Abbondio, Abramo e Abruncolo, Viollca si soffermò su sant’Acario: patrono dei caratteri difficili, invocato contro la follia, ottimo per evitare matrimoni infelici e prevenire la rabbia. Le sembrò un bel santo e i suoi miracoli erano spettacolari, così alla fine diede il suo consenso. Il bambino fu dunque battezzato con il nome di Acario ma, durante la sua lunga vita, tutti lo conobbero solo come «Dollaro».
Il figlio di Viollca non avrebbe suscitato solo la perplessità della comare che lo aveva tirato fuori dalla pancia della madre. In breve tempo, i Casadio si resero conto che, del loro sangue, aveva preso poco: forse il corpo magro, il modo di camminare trascinando le gambe e quell’essere sempre
sovrappensiero. Per tutto il resto, il bambino era l’erede del misterioso universo della madre. Imparò a parlare prima ancora di reggersi in piedi e da subito dimostrò di possedere una chiacchiera inarrestabile. La parola per Dollaro non era una necessità, ma una vocazione. Nel momento stesso in cui apriva gli occhi, iniziava a conversare con chiunque. Se non c’era nessuno, parlava da solo.
Anche Viollca aveva cominciato a parlare prima di compiere un anno; per quello, nel clan dov’era nata, dicevano fosse posseduta dal demonio e avevano paura di lei. Nessuno pensò mai che Dollaro fosse indemoniato, nemmeno il prete che in verità si affezionò al bambino e, negli anni, pure lui finì per chiamarlo con quel nome blasfemo. Indemoniato, no. Però, strano, Dollaro lo era di sicuro. Poteva comunicare con le bestie e, tale e quale la madre, se sparivano cose o animali, aveva il dono di ritrovarli. Non era raro che qualche vicino bussasse alla porta dei Casadio in cerca d’aiuto.
«Viollca, a m’è sparì al cavál.»
Lei allora portava Dollaro sulla riva del Po, lo sollevava sopra la corrente e recitava: «Oh, Nivaseya, per gli occhi neri di questo bambino, per il suo sangue di zingaro, dov’è il cavallo? Puro è il bambino, puro come il sole, come l’acqua e la luna e il latte più fresco. Dimmi, Nivaseya, per gli occhi neri di mio figlio: dov’è il cavallo?»
Prima di sera, di sicuro l’animale tornava a casa, o il padrone se lo ritrovava sul cammino.
Quello che nemmeno sua madre sapeva era che Dollaro poteva sentire le voci dei morti. Già verso i cinque anni, quando andava al cimitero, il bambino aspettava che i visitatori uscissero, poi si sedeva fra le tombe ad ascoltare le anime che parlavano tra loro. Mai si rivolgevano a lui, né sembravano accorgersi della sua presenza. Un pomeriggio, però, l’anima di una bambina aveva risposto alle sue chiacchiere. Si chiamava Susanna e gli aveva detto che stava sotto la terra da molto prima che lui nascesse. Da quel giorno, Dollaro aveva preso l’abitudine di andare a trovarla.
«Susanna, come stai? Senti freddo lì sotto?» le chiedeva.
«Quando piove, l’acqua mi gocciola negli occhi, ma non importa, tanto non ci accorgiamo più del freddo né del caldo. Però mi manca il sole.»
«Non ti viene mai fame?»
«No, mai. Ma tu, cosa stai mangiando?»
«Ho raccolto delle more.»
«Ah, che buone! Dimmi di cosa sanno.»
«Sanno… sanno di more. Ecco, prova.»
Stringeva il pugno e lasciava cadere il succo dei piccoli frutti dentro la terra. Susanna rideva, anche se la sua bocca non poteva più gustarne la dolcezza. Ma non tutti i morti erano come lei. A volte, sopra il camposanto, passava l’anima di una pazza. Di colpo i rami degli alberi si piegavano e si alzava un vento tanto forte da flettere i cipressi fin quasi a terra e fare volar via foglie di pioppo, fiori, scaglie di legno, semi dei campi.
«Ma perché urla in quel modo?» chiedeva Dollaro.
«È la Virginia. Sta chiamando il suo bambino morto. Si è ammazzata il giorno del funerale e da allora lo sta ancora cercando.»
Quando l’anima di Virginia passava là vicino, le sue grida si confondevano con il fragore dei tuoni e la furia del vento che ogni volta seguivano i suoi lamenti.
«Odio questa pioggia! Senti come graffia! I fiori sono tutti morti e il mio bambino piange… Dov’è adesso? Lo sentite?… Ha fame del mio latte… Dov’è? Dove? Dove?…»
Infine quella voce tremenda si allontanava. Il vento cessava, gli alberi tornavano immobili. Dollaro rimaneva muto, le gambe che tremavano. Poi chiamava Susanna per farsi coraggio, ma la sua amica raramente rispondeva; forse si era addormentata. Allora lui guardava in alto: il cielo era di nuovo azzurro. Poi una moltitudine di farfalle cadeva ai suoi piedi. Le loro ali coprivano le tombe con i loro colori…
L’ Autrice
Daniela Raimondi è nata in provincia di Mantova e ha trascorso la maggior parte della sua vita in Inghilterra. Ora si divide tra Londra e la Sardegna.
Ha pubblicato dieci libri di poesia che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nazionali. Suoi racconti sono presenti in antologie e riviste letterarie. La casa sull’argine è il suo primo romanzo.