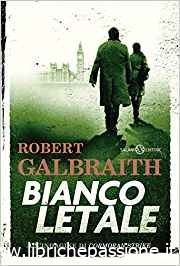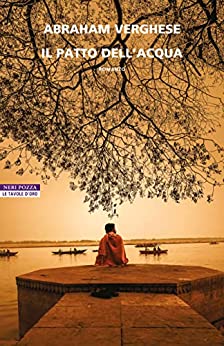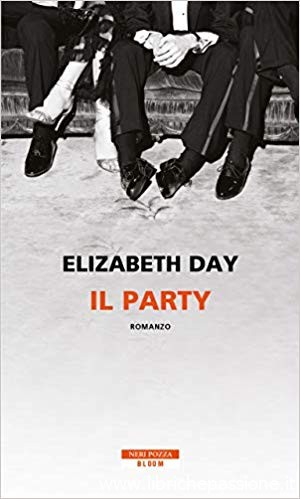Trama
Apparso per la prima volta nel 1977, questo libro, che affronta la disgregazione della vita familiare nella società contemporanea, fu accolto dalle recensioni entusiastiche della stampa di destra e dalla disapprovazione aperta degli ambienti della sinistra radicale, dai quali Christopher Lasch pure proveniva. Per i primi, l’opera costituiva «una vivace difesa dei valori tradizionali» che, una volta fatta astrazione dalle «sciocchezze marxiste» che la puntellavano, ne faceva un «libro meravigliosamente reazionario». Per i secondi, l’opera mirava semplicemente a restaurare «la famiglia borghese», responsabile per eccellenza delle ingiustizie inflitte alle donne. Nell’introduzione all’edizione tascabile del volume, apparsa nel 1978, Lasch non mancò di sottolineare l’assoluta incomprensione del testo che è alla base di simili interpretazioni, mostrando in primo luogo come la cosiddetta controcultura degli anni Sessanta fosse soltanto «un’immagine speculare del capitalismo consumistico» e come le legittime istanze del movimento femminista dovessero essere sostenute da una prospettiva, assai più radicale, di critica dell’organizzazione contemporanea del lavoro. La confutazione di queste interpretazioni è, tuttavia, contenuta nella maniera più chiara nello svolgimento dell’opera, dove destra e sinistra radicale appaiono soltanto in apparenza su posizioni opposte nell’interpretazione dell’origine della disgregazione della famiglia. Per entrambe sono gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso gli anni decisivi: magnifici i primi e catastrofici i secondi per la destra conservatrice, esattamente l’opposto per la sinistra radicale. Lasch ha buon gioco nel mostrare come la lenta dissoluzione della famiglia abbia invece una storia più che secolare. La crisi dei divorzi, il femminismo e la rivoluzione giovanile iniziarono non con la fine dei «gloriosi» anni Cinquanta e l’avvento della cosiddetta «rivoluzione sessuale» nei Sessanta, ma… nell’Ottocento, con l’estensione della produzione industriale e del modello della «fabbrica» che si impadronirono di «attività un tempo delegate all’individuo o alla famiglia». Postfazione di Goffredo Fofi.
«Di questi, strani, tempi, non conosco modo migliore per raccomandare un libro».
Jean-Claude Michéa
«Appassionato, avvincente, provocatorio».
New York Times
«Uno studio affascinante, allarmante e profondo… Un libro su cui riflettere negli anni a venire».
Chronicle of Higher Education
Estratto
A Betsy
Una donna intelligente è un tesoro,
una donna bella e intelligente è una potenza.
Meredith, Diana of the Crossways
Introduzione
Di fronte al progressivo imbarbarimento della politica, della diplomazia e del mondo degli affari, l’uomo si rifugia nella vita privata, negli affetti e soprattutto nella famiglia, l’ultimo asilo di amore e gentilezza. Ma la vita familiare sembra ormai incapace di soddisfare questi bisogni; di qui il tono preoccupato che percorre la sterminata letteratura sulla condizione della famiglia.
Si tenta di dimostrare che pur cambiando forma e struttura, la famiglia assolve importanti funzioni e quindi ha una lunga vita davanti a sé. Eppure, i divorzi continuano ad aumentare, i conflitti generazionali si inaspriscono e il pensiero progressista vede nella famiglia una forma di repressione anacronistica. Siamo semplicemente di fronte alle difficoltà di adattamento della famiglia al mutare delle condizioni sociali oppure tutto ciò lascia presagire un indebolimento del tessuto sociale e un generale disordine istituzionale? La famiglia è ancora un rifugio in un mondo crudele? La tempesta da cui nasce questo bisogno di protezione non minaccia di travolgere anche la famiglia?
Poiché sono convinto che molto dipenda dal tipo di risposta a queste domande, la qualità del dibattito pubblico mi lascia particolarmente insoddisfatto. Le opinioni sulla situazione della famiglia pretendono di imporsi alla generale attenzione, ma troppo spesso si tratta di vaghe congetture o di sciocche dichiarazioni sullo «shock del futuro»; quando non si tratta di critiche che seguono la moda corrente, apparentemente radicali nel condannare lo status quo, ma in realtà dettate dal semplice desiderio di soddisfare il bisogno di novità. La migliore critica sociale, al pari della peggiore, risente dell’ostentato disprezzo per i tradizionali metodi di indagine; così si presenta sotto forma di intuizioni isolate che rifulgono per un istante per poi dissolversi alla luce delle critiche più recenti. Nella cultura americana raramente ci si preoccupa di padroneggiare la materia o la disciplina che si vuole «rivedere». Perfino i sociologi più originali e acuti hanno avuto il culto dell’eccentricità. Scegliendo di lavorare isolati non solo dai movimenti sociali e politici ma anche dagli altri studiosi, le loro idee prendevano la forma di giudizi personali sulla situazione sociale. Così si spiega «il dissenso e perfino la confusione sui bersagli polemici nella società attuale e sulle possibili contromisure»1.
Occorre capire, anzitutto, che la crisi attuale della famiglia ha avuto una lunga incubazione. Neofemministe, paladini della «controcultura», sociologi di sinistra, profeti della «nuova storia sociale», e i giornalisti che divulgano le idee di questi intellettuali credono di avere personalmente scoperto la difficile situazione della famiglia; come se la «rivoluzione sessuale», il movimento delle donne e il declino dell’autorità paterna fossero una novità di questi ultimi quindici anni. I loro ricordi partono dalla fine degli anni cinquanta, un periodo che nella cultura popolare passa per la stagione più fortunata della famiglia «tradizionale».
In realtà, la lenta dissoluzione della famiglia ha una storia più che secolare. La crisi dei divorzi, il femminismo e la rivoluzione giovanile iniziarono nell’Ottocento, e da allora sono oggetto di discussione. I dibattiti in pubblico, a loro volta, diedero origine a una tradizione di studi sociologici, che tuttora delimita i problemi su cui verte gran parte della letteratura contemporanea sulla famiglia. In questo libro ho inteso descrivere e criticare questa tradizione, mostrando come rispecchiasse e influenzasse, a un tempo, la politica sociale e analizzando le rovinose conseguenze delle «professioni assistenziali» sulla famiglia. Nel mio studio si intrecciano teoria, ideologia e pratica sociale. Esaminando i mutui rapporti tra questi fattori, sottolineando l’importanza delle idee, inserite nel loro contesto storico, e rifiutando il concetto di una «evoluzione» automatica della storia, spero di convincere il lettore che la famiglia contemporanea non è il prodotto di astratte «forze» sociali bensì dell’attività umana.
Per un certo aspetto, la storia della società moderna coincide con l’imposizione di controlli sociali su attività un tempo delegate all’individuo o alla famiglia. Durante il primo stadio della rivoluzione industriale, i capitalisti scorporarono dalla famiglia la produzione, e nella fabbrica, sotto il loro controllo, la resero collettiva. Il passo successivo fu appropriarsi della perizia e del sapere tecnico dei lavoratori, grazie alla «direzione scientifica», e unificare queste abilità alle dipendenze di un ferreo apparato organizzativo. E infine, estesero il loro potere sulla vita privata dei lavoratori, quando medici, psicologi, insegnanti, puericultori, funzionari dei tribunali minorili e altri professionisti cominciarono a vigilare sull’educazione del fanciullo, un tempo di competenza della famiglia.
La socializzazione della produzione, a cui fece seguito la socializzazione della riproduzione, ha avuto due effetti contraddittori. Se questi cambiamenti hanno posto la base materiale di una nuova forma di società, in cui sono i bisogni collettivi anziché il profitto privato a determinare la forma di contenuto della produzione, d’altra parte hanno reso la gente dipendente dai ceti manageriali e professionali – dalla grande industria e dallo stato – minando così la capacità di fare da sé e cancellando ogni inventiva. Proprio quando il capitalismo è ormai storicamente inutile e ha creato le condizioni del suo superamento, si sono atrofizzate la volontà e la capacità di sostituirlo. Siamo così arrivati a un punto morto, a conferma che il cambiamento sociale non avviene automaticamente ma postula un intervento attivo dell’uomo. Gli uomini fanno la storia, anche se in condizioni estranee alla loro volontà e talvolta con risultati opposti a quelli voluti.
Chiunque insista sull’importanza storica della prassi umana e veda nella storia non un «processo» sociale astratto ma il prodotto di una concreta lotta per il potere, si ritrova al di fuori della corrente principale delle scienze sociali, secondo cui, invece, la società funziona secondo leggi sue proprie. La pretesa scoperta di queste leggi è l’inganno massimo della scienza sociale, che ha con le ultime fasi della rivoluzione industriale lo stesso rapporto che l’economia politica aveva con le prime. Nel Settecento e nell’Ottocento, gli economisti classici non si limitarono a interpretare il capitalismo industriale ma ne elaborarono una minuziosa apologia, che spacciò i rapporti sociali tipici del capitalismo per universali principi dell’economia. Mentre questi rapporti sociali rappresentavano il prodotto terminale di una particolare linea di sviluppo storico dell’Europa occidentale, l’economia politica li scambiò per leggi naturali, camuffando lo sfruttamento come ordine naturale delle cose e conferendo così al dominio classista un alone d’inevitabilità. Nella prassi capitalista come nella teoria in cui si rispecchiava, i rapporti tra gli uomini assunsero ora «la forma fantasmagorica», nelle parole di Marx, «di un rapporto fra cose».
Alla fine dell’Ottocento e nel Novecento, l’espansione dell’apparato organizzativo e lo sviluppo della burocrazia diedero vita a una nuova branca del sapere, la scienza sociale, tesa a gettar luce sulla trama, sempre più fitta e opaca, dei rapporti interpersonali tipici di una società avanzata. Se è vero che la smentita della banale illusione dell’autonomia individuale rappresentò indubbiamente un progresso intellettuale, è anche vero che l’insistenza nel dire che l’uomo è totalmente il prodotto della società inficiò ogni progresso e generò una nuova confusione. Secondo la scienza sociale, il principio dell’«interdipendenza» governa ogni aspetto della società moderna. Ogni parte della società è collegata a ogni altra; ogni parte è comprensibile in relazione alle altre; i rapporti tra gli uomini formano un tessuto senza smagliature che sfugge a spiegazioni «monistiche» e spesso sembra del tutto inspiegabile2. Se l’economia politica non volle vedere nei rapporti mercantili della società moderna il risultato di uno specifico processo storico (attraverso cui contadini e artigiani persero il controllo dei mezzi di produzione diventando lavoratori salariati), la scienza sociale non riesce a vedere che l’«interdipendenza» è il semplice riflesso di una forma diversa del dominio di classe: l’estensione e il consolidamento del controllo capitalistico tramite il management, la burocrazia e il professionalismo3. Di qui la rappresentazione distorta della socializzazione della riproduzione – l’espropriazione dell’educazione infantile da parte dello stato e delle professioni mediche e assistenziali – sotto forma di processo sociale astratto e impersonale, di volta in volta etichettato come il «declino della famiglia estesa», il «trasferimento di funzioni», la «differenziazione» strutturale e funzionale. Il ferreo condizionamento esercitato da queste concezioni ha reso inanimati e noiosi gli studi storici e sociologici sulla famiglia. Quasi tutti gli studi sulla famiglia trascurano di dire proprio quanto vorremmo soprattutto sapere. Perché la vita familiare è diventata così irritante, il matrimonio così fragile, e il rapporto tra genitori e figli così ostile e carico di acrimonia?
Di recente numerosi studi storici hanno arricchito la nostra conoscenza della «seconda rivoluzione industriale» del XX secolo. Mars and Minerva di Carol Gruber, Captains of Consciousness di Stuart Ewen, Labor and Monopoly Capital di Harry Braverman, Social Amnesia di Russel Jacoby, America by Design di David F. Noble hanno analizzato le trasformazioni sociali implicite nella rivoluzione tecnologica, la trasformazione della cultura americana da parte della pubblicità, l’interdipendenza di industria e istruzione superiore, e il ruolo della «psicologia conformista» nel fornire un avallo ideologico al sistema vigente di rapporti sociali. Questi studi sono, in parte, interpretabili come una critica della scienza sociale e della ricerca storica condotta sotto la sua influenza – una critica diventata oggi non meno indispensabile alla chiarezza intellettuale della critica dell’economia politica nell’Ottocento. Ma se questi studi e altri hanno chiarito la socializzazione della produzione, la socializzazione della riproduzione continua a rimanere oscura. La «nuova storia sociale», che ha il monopolio della ricerca storica sulla famiglia, ha attinto i propri principi informatori dalle scienze sociali, di cui invidia il prestigio accademico e di cui cerca di emulare il presunto rigore. Con il risultato di perpetuare gli equivoci sulla famiglia che da tempo fioriscono tra i sociologi, gli antropologi e gli psichiatri.
Quasi tutta la letteratura sulla famiglia moderna dà per scontato l’isolamento della famiglia nucleare non solo dal sistema parentale ma anche dal mondo lavorativo. Isolamento che renderebbe la famiglia indifferente a ogni influenza esterna. In realtà, il mondo moderno ne viola continuamente l’intimità e ne cancella la privacy. L’inviolabilità della famiglia è un’ipocrisia in un mondo dominato dalle grandi società per azioni e dall’apparato della produzione di serie. La società borghese ha sempre agitato la promessa che la riduzione del lavoro a routine sarà compensata dalle soddisfazioni della vita privata, ma, organizzando il tempo libero su scala industriale, incrina questo compromesso. Le stesse forze che hanno impoverito il lavoro e la vita civile infrangono sempre più la sfera privata penetrando nella sua ultima roccaforte, la famiglia. Si affievolisce la tensione tra la famiglia e il sistema economico-politico, che agli albori della società borghese sottraeva fanciulli e adolescenti all’influenza del mercato capitalistico. La famiglia, svuotata dell’intensità affettiva che un tempo caratterizzava i rapporti familiari, avvezza i giovani all’atmosfera scialba e apatica che predomina anche nel mondo esterno.
Mentre un tempo la famiglia tramandava i valori dominanti ma faceva comunque intravedere al bambino un mondo che li trascendeva, cristallizzato nel ricco repertorio di immagini dell’amore materno, il capitalismo nella sua fase matura ha eliminato o perlomeno stemperato questa contraddizione, riducendo al minimo il conflitto tra la società e la famiglia nel momento in cui inaspriva quasi ogni altra forma di conflitto. Il mondo diventa sempre più minaccioso e, non riuscendo la famiglia a offrire protezione dai pericoli esterni, tutte le
forme di lealtà diventano sempre più tenui. All’etica del lavoro, coltivata nella famiglia nucleare, si sostituisce un’etica della sopravvivenza e della gratificazione immediata. In un mondo in cui ci si batte per la sopravvivenza anziché per il successo, il narcisista prende il posto dell’arrampicatore sociale, il tipo di personalità ormai obsolescente che quasi tutti gli scienziati sociali continuano a scambiare per il tipo ancora dominante.
La satira della «fuga» nel privato, tanto di moda nella critica sociale odierna, è fuori bersaglio. Quegli stessi sviluppi storici che costrinsero a rifugiarsi nella vita privata e, in particolare, nella famiglia per sfuggire alla crudeltà della politica e del lavoro, hanno invaso questo santuario di affetti piegandolo al controllo esterno. La fuga nel privato non serve più a puntellare valori altrove minacciati di estinzione. Gli americani sapranno difendere la loro cultura soltanto a patto di mutare le condizioni stesse della vita pubblica. Resta da vedere se hanno l’energia e l’immaginazione per avviare questo cambiamento.
1
I patologi sociali e la socializzazione della riproduzione
La formazione della famiglia moderna
La famiglia, la principale agenzia di socializzazione, riproduce i modelli culturali a livello individuale. Non soltanto impartisce i precetti etici, fornendo al bambino i primi rudimenti delle norme sociali vigenti, ma ne modella profondamente il carattere, senza che egli ne sia neppure cosciente. La famiglia infonde modi di agire e di pensare che diventano abituali e, grazie alla sua enorme influenza affettiva, orienta tutta la successiva esperienza del bambino.
L’unione di amore e disciplina nelle stesse persone, la madre e il padre, crea un’atmosfera fortemente emotiva in cui il bambino impara lezioni che l’accompagneranno per tutta la vita e che non coincidono necessariamente con le lezioni esplicite che i genitori vogliono inculcargli. Il bambino si predispone inconsciamente ad agire in un certo modo e a riprodurre nella vita successiva, nei rapporti con l’altro sesso e con le autorità, le sue prime esperienze. Innanzitutto, i genitori incarnano l’amore e il potere, e ognuna delle loro azioni, al di là delle intenzioni, comunica al bambino le ingiunzioni e le costrizioni con cui la società cerca di organizzare l’esperienza. Se la trasmissione della cultura si riducesse a una questione di disciplina e d’istruzione formale, la scuola potrebbe bastare. Ma è anche necessario che la cultura pervada la personalità. La socializzazione spinge l’individuo a voler fare ciò che deve fare, e la famiglia è l’agenzia a cui la società affida questo compito complesso e delicato.
La famiglia è l’istituzione più refrattaria al cambiamento. Tuttavia, per la sua importanza, i mutamenti che ne investono la grandezza e la struttura, l’organizzazione degli affetti e i rapporti con il mondo esterno, non possono che influenzare enormemente lo sviluppo della personalità. I cambiamenti della struttura caratteriale, a loro volta, accompagnano le trasformazioni della vita economica e politica o ne costituiscono il fondamento. Lo sviluppo del capitalismo e la nascita dello stato si riverberano nell’interiorità dell’individuo. Dacché Max Weber mise in luce i legami tra protestantesimo e capitalismo, dimostrando anche come tali legami si stabilissero al livello non della dottrina religiosa formale ma delle «sanzioni psicologiche», è stato chiaro che la civiltà moderna richiede, tra l’altro, una profonda trasformazione della personalità. Il concetto protestante di «vocazione» non si limitava a nobilitare la vita terrena, sottolineando il valore etico del lavoro e legittimando prudenza, calcolo e lungimiranza, ma affermava anche la dignità spirituale del matrimonio e della vita domestica. Il rifiuto delle virtù monastiche della povertà e della castità, l’eccellenza del matrimonio e l’emergere di un nuovo concetto di matrimonio fondato sulla prudenza e sulla previdenza andavano di pari passo con il nuovo valore attribuito all’accumulazione capitalistica. Per il pensiero borghese, i bambini erano una garanzia per il futuro; di qui l’attenzione senza precedenti che si dedicava alla loro educazione. Il nuovo stile di vita familiare creò le condizioni psicologiche favorevoli all’emergere di un nuovo tipo di personalità autonoma e fiduciosa nelle sue possibilità, che rappresentò il contributo più profondo della famiglia ai bisogni di una società mercantile i cui fondamenti erano la concorrenza, l’individualismo, il differimento delle gratificazioni, il calcolo razionale e l’accumulazione di beni terreni.
Alla fine del Settecento, le principali caratteristiche del sistema familiare borghese erano ormai consolidate nell’Europa occidentale e negli Stati Uniti. Non è difficile enunciare le caratteristiche distintive di questo sistema, seppure a prezzo di un certo schematismo.
Rispetto ai costumi di quasi tutte le altre società, il matrimonio avveniva tardi e molti non si sposavano affatto. Come questo dato demografico suggerisce, erano i diretti interessati, anziché i genitori e gli anziani, a combinare il matrimonio; al più, gli anziani avevano facoltà di veto. Questi permettevano alle giovani coppie di corteggiarsi senza intromissioni, dando per inteso che il loro autocontrollo avrebbe surrogato la sorveglianza degli adulti – un’aspettativa non del tutto irragionevole dal momento che le coppie di innamorati erano giovani adulti; inoltre, le giovani donne avevano imparato fin dalla più tenera età ad accettare gli approcci amorosi dell’altro sesso senza compromettere la propria reputazione.
D’altro canto, uomini e donne difficilmente si spogliavano nel matrimonio delle inibizioni acquisite durante il corteggiamento. Fu così che il sistema matrimoniale borghese diede origine a gravi forme di tensione e disadattamento sessuale, ancora più avvertite che in altre circostanze perché idealmente il matrimonio si fondava sull’amore e sull’intimità. Il ripudio del matrimonio «combinato» avvenne in nome dell’amore romantico e di una nuova concezione della famiglia intesa come rifugio dal mondo ferocemente competitivo e spesso brutale del commercio e dell’industria. Secondo questa ideologia, marito e moglie dovevano trovare consolazione e conforto spirituale nella reciproca compagnia. La donna, in particolare, si doveva prestare a essere, secondo un’abusata espressione ottocentesca, «l’angelo del focolare».
La sua missione misericordiosa toccava anche la prole, che sempre più era messa al centro della vita familiare borghese. Una nuova idea di infanzia contribuì a far decantare la nuova idea di famiglia. Non più considerato un semplice piccolo adulto, il bambino diventò una persona con attributi peculiari – impressionabilità, vulnerabilità, innocenza – che richiedevano un prolungato periodo formativo prodigo di affetti e protezione. Mentre in precedenza i bambini avevano frequentato liberamente la società degli adulti, ora i genitori cercavano di isolarli da ogni contatto prematuro con i domestici o con altre influenze corruttrici. Intanto, educatori e moralisti cominciarono a sottolineare i bisogni ludici del fanciullo, la necessità di amore, comprensione e di uno sviluppo graduale e senza scosse. Di conseguenza, l’educazione diventò più impegnativa e i legami affettivi tra genitori e figli crebbero di intensità nel momento stesso in cui si affievolivano i legami con i parenti all’esterno della famiglia nucleare. Di qui un’altra fonte di continua tensione nella famiglia borghese: l’eccessivo peso del legame affettivo tra genitori e figli.
Un’ulteriore fonte di tensione fu il cambiamento della condizione femminile richiesto dal nuovo sistema familiare. La famiglia borghese degradava e contemporaneamente esaltava la donna. Da un lato, la privava di molte occupazioni tradizionali, cessando la famiglia di essere un centro produttivo e dedicandosi, invece, all’educazione della prole. Dall’altro, i nuovi impegni educativi, in un momento in cui i particolari bisogni del bambino erano al centro dell’attenzione, imponevano la necessità di educare le donne ai loro compiti domestici. Una migliore educazione significava anche rendere la donna più confacente alla compagnia del marito. Il nuovo culto della famiglia comportò un’integrale riforma e un arricchimento dell’educazione femminile, come comprese Mary Wollstonecraft, la prima femminista moderna, quando insisteva che se le donne dovevano diventare «mogli affezionate e madri ragionevoli», non si poteva ridurre la loro educazione allo sviluppo delle «doti» capaci di renderle attraenti ai futuri corteggiatori1. Uno dei primi capisaldi dell’ideologia repubblicana era che le donne dovevano diventare utili e non soltanto decorative. Nelle categorie immortalate da Jane Austen, le donne dovevano rinunciare alla sensibilità a favore del senno. Fu così che la vita domestica borghese diede origine alla sua antitesi, il femminismo. La «domesticazione» della donna causò una diffusa irrequietezza, incoraggiandola a coltivare aspirazioni che il matrimonio e la famiglia non erano in grado di appagare. Queste aspirazioni furono uno degli elementi decisivi della crisi dell’istituto matrimoniale che cominciò a manifestarsi alla fine dell’Ottocento.
Il sistema familiare borghese, che conobbe la sua massima fioritura nel secolo scorso e che oggi sembra in lento declino, si fondava, quindi, su quattro elementi: il cosiddetto companionate marriage*; la centralità della prole nella famiglia; l’emancipazione o quasi delle donne; e l’isolamento strutturale della famiglia nucleare dal sistema parentale e dalla società in genere. La famiglia trovava avallo e giustificazione ideologica nella concezione della vita domestica come rifugio in una società arida e competitiva. Il concetto della famiglia rifugio in un mondo crudele dava per scontata una radicale separazione tra lavoro e tempo libero e tra vita pubblica e privata. Se l’emergere della famiglia nucleare come principale forma di vita familiare era il riflesso del grande valore che la società moderna annetteva alla privacy, l’esaltazione dell’intimità rifletteva, a sua volta, la svalutazione del lavoro. Mentre la produzione diventava sempre più complessa ed efficiente, aumentava la specializzazione e la parcellizzazione del lavoro, ormai ridotto a routine. Perciò, si finì per considerare il lavoro un semplice mezzo per un fine, che per la maggioranza era la pura sopravvivenza fisica e per altri, più fortunati, era una vita personale ricca di soddisfazioni. Non essendo più ritenuto un’occupazione soddisfacente in sé e per sé, si dovette procedere a una ridefinizione del lavoro come mezzo in vista di soddisfazioni o consolazioni esterne al lavoro. In questa prospettiva, la produzione è interessante e importante soltanto perché ci consente di assaporare le gioie del consumo. A un livello più profondo di mistificazione, il lavoro sociale (l’autorealizzazione collettiva dell’umanità attraverso la trasformazione della natura) si presenta soltanto sotto forma di soddisfazione di bisogni privati.
La meccanizzazione e l’introduzione della routine svilirono l’atto lavorativo in un senso ancor più profondo. I prodotti dell’attività umana, specialmente i prodotti più nobili come l’ordine sociale stesso, finirono per sembrare qualcosa di esterno ed estraneo all’umanità. Il mondo creato dall’uomo, in cui era sempre più difficile riconoscere l’inventiva umana, appariva come una serie di oggetti indipendenti dall’intervento e dal controllo dell’uomo. Reificatosi nel proprio lavoro, l’uomo non vi si riconosceva più. Pertanto, gli economisti classici descrivevano l’economia capitalistica, la creazione collettiva dell’ingegno e del lavoro umani, come una macchina che seguiva leggi immutabili sue proprie, analoghe alle leggi di natura. E questi principi, posto che esistessero nella realtà (e non soltanto nel cervello di Adam Smith e Ricardo), erano inaccessibili all’osservazione quotidiana, sicché per il profano l’economia di mercato sfuggiva non solo a ogni possibilità di controllo, ma perfino alla comprensione umana, apparendo come una complessa trama di astrazioni, impenetrabile e oscura. John Adams una volta mostrò una perfetta padronanza del sistema bancario e creditizio moderno rammaricandosi che «ogni dollaro di un assegno bancario emesso oltre la quantità di oro e argento nei forzieri non rappresenta nulla e perciò è un imbroglio»2. Dello stesso avviso erano Jefferson e Jackson. E se le classi dirigenti si dibattevano in questa confusione, non è difficile immaginare il disorientamento dell’uomo della strada, che viveva in un mondo di astrazioni dove i rapporti tra gli uomini, come osservava Marx, assumevano la forma fantasmagorica di un rapporto tra cose. Così, la forza-lavoro diventò una merce, misurabile in astratti termini monetari e oggetto di compravendita nel mercato come ogni altra merce.
In fondo, l’esaltazione della vita privata e della famiglia rappresentava il contraltare della percezione della società borghese come un’entità estranea, impersonale, remota e astratta – un mondo da cui pietà e tenerezza erano fuggite terrorizzate. Ci si doveva ripagare in privato delle deprivazioni patite in pubblico. Ma erano le condizioni stesse alla base di questo bisogno di privacy e di un rifugio dal mondo esterno a rendere sempre più difficile il compito della famiglia in questa veste.
La crisi della famiglia alla fine dell’Ottocento
Verso la fine dell’Ottocento, i giornali e le riviste americani dibattevano accanitamente la crisi del matrimonio e della famiglia. Quattro fattori crearono un sempre più diffuso allarme sociale: la percentuale crescente di divorzi, il declino della natalità nelle classi agiate, la mutata posizione della donna e la rivoluzione del costume.
Tra il 1870 e il 1920, il numero dei divorzi aumentò di quindici volte. Nel 1924, un matrimonio su sette finiva con un divorzio e tutto lasciava credere che si trattasse di una tendenza ormai irreversibile3.
Intanto, «la diminuzione della natalità negli alti ranghi», secondo un’espressione di Theodore Roosevelt, faceva temere che le classi superiori sarebbero state presto superate di numero dai loro subalterni che si moltiplicavano senza preoccuparsi minimamente dell’avvenire della loro prole4. I ricchi, invece, sembravano troppo attenti non solo al futuro ma al proprio momentaneo benessere. Secondo i tradizionalisti, la classe borghese si era adagiata nel suo egoismo, specialmente le donne che preferivano la mondanità ai più seri piaceri della maternità. Brooks Adams, portavoce della feroce reazione aristocratica, definiva la donna «nuova» «il massimo prodotto di una civiltà imputridita prima di maturare»5. Anche i progressisti si mostravano preoccupati della diminuita natalità, però la imputavano all’alto costo della vita e alla ricerca sempre più affannosa del benessere, che spingevano i giovani a evitare il matrimonio o a procrastinarlo il più possibile. Che senso ha incolpare le donne del «suicidio della razza»? – si chiedeva una delle principali riviste femminili. La «causa vera» era «il costo della vita che costringeva le masse all’indigenza». Non a torto, l’americano medio «era spaventato da una famiglia numerosa»6.
Il mutamento della condizione femminile era uno dei segni rivelatori dei tempi che colpiva anche l’osservatore più distratto. Le donne in numero sempre maggiore frequentavano l’università, aderivano a circoli e organizzazioni di ogni tipo ed entravano nel mondo del lavoro. Come spiegare tutto questo attivismo, e quale significato aveva per il futuro della famiglia? Le femministe davano una semplice risposta, almeno alla prima domanda: le donne si limitano a «trasferire il loro lavoro fuori della famiglia». L’industria aveva invaso la famiglia, privandola delle sue funzioni produttive. Il lavoro un tempo svolto tra le mura domestiche ora si poteva svolgere più efficientemente nella fabbrica. Perfino lo svago e l’educazione della prole venivano sottratti alla famiglia dall’esterno, il primo dalla sala da ballo e dal teatro, la seconda dalla scuola. Alle donne non rimaneva altro che «lavorare o morire di fame», negli affetti, perlomeno, se non alla lettera. Relegate in famiglia, le donne sarebbero diventate «parassiti», «consumatori improduttivi a carico dello stato», come si espresse nel 1910 una scrittrice femminista7.
Di fronte alla condanna dello svago come forma di parassitismo, gli avversari del femminismo avrebbero potuto sottolineare il valore positivo del tempo libero, senza il quale
erano impensabili l’arte, la cultura e le forme più alte di pensiero, propugnando di estenderne i benefici all’uomo d’affari. Ma un attacco al femminismo lanciato da un punto di vista essenzialmente aristocratico – un attacco che vedesse proprio nel femminismo un’espressione del moralismo e del filisteismo borghese – era pericoloso per chi voleva soprattutto salvaguardare la santità della famiglia. I critici americani del femminismo preferirono fondare la loro tesi sull’affermazione che l’utilità sociale della donna e la sua autogratificazione nel lavoro coincidevano esattamente con i sacri doveri di moglie e madre. Si accettava così la principale premessa del femminismo – che le donne dovessero essere utili, non decorative – pur rifiutando inflessibilmente le conclusioni che le femministe traevano da questa premessa e che, secondo loro, ne erano la logica conseguenza.
Per questa stessa ragione, i critici dovettero evitare una condanna senza appello del movimento femminista. Perfino la denuncia del nuovo «egoismo» femminile presentava dei rischi. Alla metà dell’Ottocento, i difensori della famiglia si erano ripetutamente appellati al dovere femminile di sacrificarsi per il bene altrui, ma all’inizio del Novecento questo genere di retorica, anche nella variante progressista del «servizio», cominciava ormai a sembrare superata. L’opinione che la donna viva pienamente vivendo per gli altri cedette il passo all’opinione che anche la donna abbia il diritto di autorealizzarsi – un diritto che, però, si poteva realizzare pienamente soltanto nella famiglia. In breve, i critici del femminismo cominciarono a sostenere che la maternità e il lavoro di massaia costituiscono «carriere» di per sé gratificanti, che richiedono uno specifico tirocinio «scientifico» nell’«amministrazione della casa» o in «economia domestica». L’invenzione di questi termini rivelava il tentativo di nobilitare il lavoro domestico equiparandolo a una professione. Razionalizzando il governo della casa e la cura della prole, alcuni avversari del femminismo probabilmente speravano anche che la famiglia sostenesse più efficacemente la concorrenza delle agenzie esterne che ne rilevavano le funzioni. Per ironia, la razionalizzazione del lavoro domestico faceva dipendere più di prima la massaia dall’aiuto di esperti esterni.
Se il femminismo turbava i partigiani della vita domestica perché ne criticava l’inefficienza e tentava di incanalare al di fuori della famiglia l’irrequietezza della donna moderna, il movimento di liberazione della sessualità dai vincoli tradizionali li infastidiva ancora di più. Se non altro, il femminismo era compatibile con il progressismo e con la visione di una missione purificatrice della donna nella società; anzi, il successo con cui si identificava con i temi dominanti della cultura borghese costringeva gli avversari del femminismo a evitare un attacco frontale. La «nuova moralità», invece, metteva direttamente in discussione l’etica sessuale corrente. Decantava le gioie del corpo, difendeva il divorzio e il controllo delle nascite, metteva in cattiva luce la monogamia e condannava ogni interferenza dello stato o della comunità nella vita sessuale.
Ma anche in questo caso, i difensori della famiglia si resero presto conto che una condanna senza appello non era certo la strategia migliore. Anziché cercare di distruggere la nuova moralità, la edulcorarono, inneggiando a una sessualità più libera e cosciente nel matrimonio mentre svuotavano di ogni contenuto l’ideologia dell’emancipazione sessuale che minacciava la monogamia. Per inciso, questa operazione affidava alla massaia un altro ruolo a integrazione del suo nuovo ruolo di consumatore per eccellenza: il ruolo poliedrico di partner sessuale, convivente, compagna di giochi e terapeuta.
Ma i sostenitori della nuova sessualità non si accontentarono di auspicare una rivoluzione del costume, asserendo, anzi, che era già in corso. Citavano indagini statistiche che sembravano indicare una tendenza sempre più diffusa all’adulterio e ai rapporti prematrimoniali8. Di fronte a questi dati inoppugnabili, i paladini del matrimonio, alle strette, attuarono ancora una volta una ritirata strategica, sostenendo che le statistiche mostravano che gli uomini e le donne americani rifiutavano non il matrimonio ma soltanto «l’ideale di un monopolio sessuale» con cui il matrimonio si era identificato senza alcuna necessità. Dato che nel sesso l’esclusivismo e la possessività avevano un «effetto deleterio», si poteva tranquillamente farne a meno. Così, la società moderna poteva rinunciare al
«dogma della verginità» – il dovere della donna di giungere vergine al matrimonio. L’esclusività nel sesso doveva considerarsi un ideale da perseguire, e non un criterio da imporsi a ognuno dall’esterno. Ogni uomo e ogni donna dovevano decidere autonomamente se ritenere l’infedeltà una dimostrazione di slealtà9.
Un’altra parte del bagaglio ideologico che andava eliminata era l’idea che il matrimonio dovesse essere privo di conflitti e tensioni. Secondo un’autorevole corrente di opinione sul matrimonio (e i portavoce di soluzioni come il «matrimonio aperto»), le liti coniugali andavano considerate avvenimenti normali da prendersi con calma e perfino da sfruttare. Se opportunamente «inscenati» e conclusi con «arte consumata», i bisticci potevano anche avere un effetto benefico10.
I difensori del matrimonio si trovarono alleati ai suoi critici in un attacco frontale all’amore romantico. L’amore romantico, così si pensava, stabiliva regole di devozione e lealtà estremamente impegnative a cui il matrimonio non era più in grado di uniformarsi. Mettendo in crisi la «sobrietà e il realismo della vita quotidiana», il romanticismo aveva effetti deleteri non meno gravi della verecondia, il suo contraltare11. Nel pensiero progressista e tradizionalista, l’amore romantico era sinonimo di illusioni, pericolose fantasticherie e sofferenze; di pallide eroine, eroi che si consumavano nella febbre del desiderio, addii strazianti; della musica malsana e convulsa di Wagner, Strauss e Puccini…
Christopher Lasch (1932-1994) è stato uno dei maggiori storici delle idee del Novecento. Tra le sue numerose opere ricordiamo: La cultura del narcisismo (Bompiani, 1981), Il paradiso in terra. Il progresso e la sua critica (Neri Pozza, 2016), La rivolta delle élite (Neri Pozza, 2017) e L’io minimo (Neri Pozza, 2018).