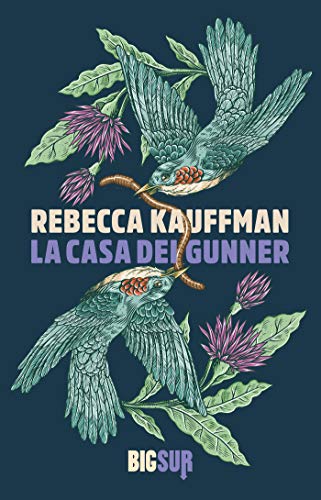
Trama
Alice, Jimmy, Lynn, Mikey, Sam e Sally: da bambini erano inseparabili. Avevano trovato scampo alla solitudine e alla noia di una periferia depressa nel nord dello stato di New York – e spesso da difficili situazioni familiari – prendendo possesso di una casa abbandonata e facendone il quartier generale delle loro avventure. A sedici anni, però, di colpo e senza spiegazioni, Sally ha tagliato i ponti col resto del gruppo, che di lì a poco si è sfaldato. Più di dieci anni dopo, gli altri cinque amici si ritrovano proprio al funerale di Sally, a interrogarsi sul motivo del suo suicidio, a fare i conti con i segreti del passato, a riannodare i fili dell’affetto fortissimo che ancora li unisce, al di là delle differenze di indole e della propria storia personale.Un romanzo corale sull’amicizia popolato da personaggi di vibrante umanità (su tutti, il timido Mikey e l’esuberante Alice, profondamente legati per quanto caratterialmente agli antipodi), che l’autrice riesce a tratteggiare grazie alla vivacità dei dialoghi e a una cura delicatissima per i dettagli; una storia punteggiata di rivelazioni e sottili colpi di scena che tiene in pugno il lettore, lo diverte e lo commuove, e gli resta nel cuore a lungo anche dopo l’ultima pagina.
Estratto
Conviviamo con queste vestigia dell’infanzia che si assemblano e riecheggiano durante tutta la nostra vita, proprio come in un caleidoscopio i frammenti di vetro assumono nuove forme e sono simili a canzoni nei loro ritornelli e nei loro ritmi, dando vita a un unico monologo. Viviamo perennemente nel ricordo delle nostre storie, quali che siano le vicende che raccontiamo.
Michael Ondaatje, Divisadero
1.
Quando aveva sei anni, Mikey Callahan scoprì una cosa su sé stesso.
Lui e i compagni di prima elementare vennero chiamati fuori dall’aula a uno a uno e portati in palestra per un controllo medico di routine. La donna che urlò il suo nome (chiamandolo però Michael, non Mikey, come lo conoscevano i suoi compagni di classe) lo accompagnò lungo il corridoio tenendolo per mano, e aveva le dita ruvide e fredde come gusci. In palestra c’erano tavoli rettangolari, paraventi, blocchi per appunti, adulti vestiti di bianco. Un uomo con i baffi color ruggine gli infilò una punta di gomma gelida nelle orecchie, le esaminò e poi fece fare a Mikey una serie di semplici esercizi: gli disse di chiudere gli occhi e ripetere le parole che gli sussurrava, poi di ascoltare due suoni registrati e dirgli quale gli sembrava più forte.
Mikey passò alla postazione successiva, dove gli fecero di nuovo chiudere gli occhi; stavolta doveva dire «Ora» quando si sentiva toccare sul viso o sul braccio con la punta di una penna. Facile. Per Mikey era meglio che stare seduto in classe, e poi gli piaceva essere sfiorato in quel modo. Un tocco delicato, clinico.
Nell’ultima postazione, su un cavalletto alla fine di un lungo tavolo, c’era un foglio bianco con una piramide di lettere nere disegnate.
Una donna in piedi accanto al cavalletto indicava le lettere a una a una e Mikey doveva leggerle ad alta voce. Le lettere si rimpicciolivano via via che si scendeva lungo la pagina e Mikey fece fatica a leggere le ultime due righe. La donna scrisse qualcosa sul blocco che aveva in mano; poi gli passò un cucchiaio di plastica nero e gli chiese di coprirsi l’occhio sinistro. Sostituì la serie di lettere con una nuova e gli fece ripetere l’esercizio, con risultati simili.
Poi disse: «Adesso copriti l’altro occhio», e girò un’altra pagina sul cavalletto.
Mikey non si portò il cucchiaio al viso. Sentì che il calore del sangue gli arrossava le guance. «Ma è l’occhio buono», obiettò.
«Come dici, tesoro?», gli chiese la donna.
«Non posso coprirmi questo qui». Mikey si indicò l’occhio destro, confuso dalla richiesta. «È quello che funziona».
La donna si avvicinò e s’inginocchiò davanti a lui. Gli guardò il viso ed esclamò: «Oh, Signore».
Mikey non capiva.
Lei gli spiegò che normalmente funzionavano entrambi gli occhi; la maggior parte della gente aveva due occhi buoni.
Mikey annuì lentamente, assimilando la notizia. Gli veniva sempre da annuire quando doveva incamerare delle informazioni spiacevoli.
«Per favore, non lo diciamo a papà», la implorò.
Quando Mikey tornò da scuola, quel giorno, suo padre gli fissò l’occhio sinistro, quello che non funzionava, con leggero ribrezzo; poi fece fare a Mikey una serie di test di sua invenzione, come se la scuola avesse ingigantito il problema. Gli fece chiudere l’occhio destro e gli domandò quante dita gli stesse mostrando. Mikey cercò di rispondere correttamente, aprendo ogni tanto l’occhio destro per sbirciare. Supplicò il padre di non fargli indossare una benda da pirata, ma lui rispose: «A che diavolo servirebbe?»
Il padre gli disse che in quel preciso istante doveva decidere se rivelare a tutti la verità sul suo occhio sinistro o mantenere il segreto; sembrò sollevato quando Mikey rispose subito che sarebbe rimasto un segreto. Come se quel difetto potesse riflettersi negativamente su entrambi se altri l’avessero scoperto. Non ne parlarono più.
Il padre di Mikey lavorava al mattatoio di Eden, a diversi chilometri di distanza. Odorava sempre di sangue e aveva gli angoli delle unghie rossi che trasmettevano un senso di violenza e forza bruta. Aveva il viso pieno di bitorzoli, come se fosse stato imbottito di ovatta, e le palpebre cascanti. Per tutta l’infanzia Mikey aveva vissuto con lui al piano terra di una casetta a schiera di Ingram Street, a Lackawanna, un sobborgo depresso nella zona sud di Buffalo. Soltanto metà delle case del loro isolato erano abitate. Le altre avevano assi di legno al posto delle finestre, bottiglie di liquore in frantumi sulla veranda anteriore e gatti randagi che defecavano in mezzo all’erba mai tagliata. Gli inquilini del piano di sopra andavano a fare la spesa in pantofole ed emanavano sempre un vago odore di zolfo; ogni mese litigavano a gran voce con il proprietario per i ritardi sull’affitto e le minacce di sfratto. Il padre di Mikey pagava sempre l’affitto puntualmente, ma a volte si dimenticava delle bollette e un tizio in completo blu veniva a riscuotere la somma in contanti, dicendo che se non potevano pagare gli avrebbe staccato la corrente, e allora come avrebbero fatto a vederci di notte? Cos’avrebbero mangiato?
Il padre di Mikey si nutriva di quattro cose: cereali, mele, biscotti Chips Ahoy! e panini con gli affettati. Mikey non conobbe altri cibi finché non glieli offrirono i suoi amici dal cestino per il pranzo, o le mamme dei suoi amici, a casa loro.
Mikey non aveva una madre; dato che il padre si rifiutava di fornirgli informazioni in proposito, si era messo a perlustrare la casa da solo, a caccia di indizi. Cercava le cose che aveva visto a casa dei suoi amici e che appartenevano alle loro madri: un paio di collant appallottolati, una scarpa con il tacco a spillo, lunghi elenchi scritti in corsivo, un cestino di plastica pieno di smalti per le unghie o una confezione di Tampax sotto il lavandino, un grembiule con ricami di galletti o renne. Non trovò nemmeno una prova concreta in casa propria.
Una volta, però, Mikey scovò un unico oggetto che stonava in casa sua. Si trattava di una piccola valigia riposta nell’angolo dell’armadio di suo padre, sotto una pila di maglioni in vari toni di grigio, tutti ben piegati. Era pacchiana e colorata ed era l’unica cosa in tutta casa che Mikey non riusciva a immaginare che suo padre potesse aver comprato. Quando la aprì, l’odore della fodera blu cobalto gli risvegliò un ricordo, debole, lontano e indistinto, come uno sbuffo di fumo. Forse il ricordo di un ricordo. Comunque Mikey prese a chiedersi se, invece di essere nato dal buco della pipì di una donna (come i suoi amici), non fosse semplicemente arrivato dentro quella valigia, che era della dimensione ideale per contenere un neonato e come forma ricordava vagamente un grembo materno. Non aveva prove che fosse stata la valigia a generarlo, ma durante l’infanzia questa fu la teoria a cui si aggrappò con più forza; gli piaceva aprire la valigia, accarezzarne lo strano pelo sintetico e immaginare che la sua vita avesse avuto inizio in quel morbido luogo blu.
Il padre di Mikey era un uomo dalle emozioni oscure e inespresse. Di rado i rapporti tra lui e Mikey erano cattivi, o almeno non lo erano nel senso più comune del termine: non erano violenti o invivibili, ma neppure facili. Il padre di Mikey aveva le ginocchia malandate e frequenti malumori, un carattere ombroso. Beveva troppo spesso (tutti i giorni), ma quasi mai troppo in una botta sola: Mikey non l’aveva mai visto barcollare, farfugliare o addormentarsi sulla sedia. Quando Mikey era piccolo, il padre manifestava i suoi malumori attraverso critiche pungenti su cose senza importanza o insidiose serate casalinghe di silenzio assoluto durante le quali, senza alcun motivo, vietava al figlio di uscire a giocare con gli altri ragazzini del vicinato. In quelle sere Mikey andava a letto presto pur di non stare con il padre. Chiudeva la finestra di camera sua per non sentire le voci lontane degli amici, che lo facevano soffrire.
Alice, Sally, Lynn, Jimmy e Sam avevano fatto amicizia con Mikey da piccoli, quando abitavano tutti nella stessa strada e cercavano tutti dei compagni di giochi e una scusa per allontanarsi da casa per un po’. I bambini avevano preso possesso di uno degli stabili abbandonati di Ingram Street e ne avevano fatto il loro punto d’incontro ufficiale; la cassetta delle lettere arrugginita, fissata sulla porta principale, recava la scritta THE GUNNERS in adesivi dorati Mylar. La casa se la ricordavano vuota da sempre, e non conoscevano nessuna famiglia Gunner nel quartiere, perciò si erano appropriati del posto e anche del nome. Avevano arredato la stanza principale di Casa Gunner con oggetti trovati per strada: materassi ammuffiti, cuscini decorativi con macchie di sigarette, sedie da giardino con tre gambe, bambolotti senza occhi e un albero di Natale sintetico così aggrovigliato che ci erano voluti diversi giorni per sistemarlo. Avevano appeso una torcia elettrica al centro del soffitto di quella stanza, ed era lì che si ritrovavano a inventare barzellette, giochi e linguaggi segreti, a fare progetti, combinare guai, parlar male dei loro genitori, giocare a carte, scommettere, raccontare storie, complottare contro i bulli, bisticciare, fare pace, crogiolarsi nella noia e sognare la vita che un giorno avrebbero vissuto lontano da Lackawanna.
Da bambini, i Gunners non potevano immaginare che, raggiunti i sedici anni, una di loro avrebbe voltato le spalle agli altri e che il gruppo sarebbe rimasto talmente spaccato da quella perdita, da quell’improvvisa e inspiegabile assenza, che nel giro di poche settimane anche le altre amicizie si sarebbero sciolte, gettando ciascuno dei membri in una solitudine buia e confusa. Mikey Callahan divenne una sorta di buco nero; dentro di lui tutto si allentò e infine collassò su sé stesso.
2.
Era primavera, aprile; un mese prima di finire il terzo anno delle superiori, Sally Forrest tagliò i ponti con gli altri Gunners. Smise di parlare con loro a scuola e non mise più piede a Casa Gunner. Quando la chiamavano nel corridoio, oppure quando tentavano di avvicinarla su Ingram Street, non rispondeva. Affrettava il passo, abbassava gli occhi e cambiava strada. Si faceva negare al telefono. Alla fine gli altri del gruppo andarono a cercarla direttamente a casa, ma Corinne, la madre, disse che Sally non stava bene e non li fece entrare.
A scuola Sally non rimpiazzò il gruppo con altri amici; sembrava non avere alcun interesse per la compagnia degli altri e si portava il pranzo in cortile oppure in qualche aula vuota. In classe non alzava mai la mano. I suoi occhi chiari diventarono freddi e la postura rigida.
Gli altri si scervellarono per diverse settimane sull’accaduto, ripetendo tra loro le ultime conversazioni, elaborando teorie, formulando frasi di scuse vaghe e incerte, ma comunque sincere. Non riuscendo però ad arrivare a nessuna conclusione sul motivo per cui Sally si fosse rivoltata contro di loro, cominciarono a rivoltarsi l’uno contro l’altro, con accuse e supposizioni, risentimento e sospetti. Negli ultimi mesi delle superiori, nei corridoi della scuola o per le vie di Lackawanna, i Gunners si ritrovarono a comportarsi tra loro come degli estranei.
Mikey era un anno indietro rispetto agli altri e fu l’unico che rimase in città, a parte Sally.
Dopo il diploma, Mikey se ne andò da casa del padre e si trasferì in una casetta bassa venti chilometri più a nord, in modo che il tragitto fino alla General Mills, dove lavorava nel reparto manutenzione, fosse di soli dieci minuti invece che di mezz’ora. L’abitazione che aveva affittato era di proprietà di una signora in là con gli anni di nome Louise, appena trasferitasi in una comunità per anziani. Louise spiegò a Mikey che le sue figlie avevano sposato dei tizi viscidissimi e che non aveva alcuna intenzione di lasciare la casa a loro, per cui Mikey poteva fare quello che gli pareva per quanto riguardava la tinteggiatura, le piante e gli animali da compagnia. Mikey diede più luce alle pareti, coprendo il grigio-rosa sbiadito con un più caldo color crema, e piantò un cespuglio di forsizia sul davanti. Un venerdì adottò un gattino nero, che chiamò appunto Venerdì.
Dopo il trasloco, Mikey continuò ad andare a trovare suo padre tutte le domeniche. Il padre gli offriva una birra e guardava la tv con lui per alcune ore, in un silenzio teso, poi si alzava per andare a pisciare e diceva: «Quando esci, chiuditi dietro la porta», al che Mikey provava un gran sollievo.
Mikey non lasciò mai quella zona, né il lavoro alla General Mills; ricevette però due promozioni nel corso di una decina d’anni. Non lasciò nemmeno la casetta; con sua grande sorpresa, scoprì che Louise nel testamento gli aveva effettivamente lasciato l’abitazione e tutto quello che conteneva. Non si era reso conto che dicesse sul serio a proposito dei tizi viscidi.












