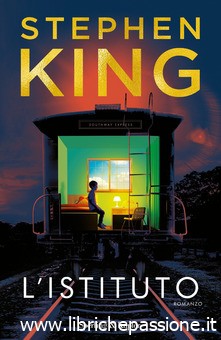Trama
Appoggiata ai bordi del bosco, sulla via che dal paese va verso le montagne, c’è una piccola casa solitaria: è qui che vivono le ricamatrici. Ora è rimasta Eufrasia a praticare l’arte di famiglia, tesse, cuce, ricama leggendo in ogni persona che le si rivolge i desideri più inconsci. Accanto a lei come prima alla bisnonna, alla nonna e alla madre, da sempre, il telaio di ciliegio, rocchetti, stoffe, spole e spilli. Eufrasia ha settant’anni e ha quasi smesso di lavorare, le mani curvate dall’artrite e la modernità in cui tutto è fatto in fretta le avevano fatto pensare di non servire più a nessuno.
Ed è in quel momento che arriva Filomela, una ragazza giovane con il riso negli occhi oltre che sulle labbra, che le chiede di prepararle il corredo e di insegnarle a ricamare. Eccola, l’ultima occasione di fare ciò che Eufrasia più ama: rendere felice qualcuno, raccontargli la vita che verrà intrecciando trama e ordito. Le parole che ha risparmiato per tutta l’esistenza ora sgorgano come fiumi in primavera. Racconta di una giovane vedova di guerra gentile ed esperta nel taglio e cucito, di una splendida e coraggiosa ragazza troppo bella per non attirare le malelingue di paese, di un amore delicato come il filo di lino e tanto sfortunato, e di un ricamo tessuto da generazioni, in cui ognuna di loro ha scritto un pezzo della propria esistenza, una scintilla luminosa nel buio del mondo.
Elena Pigozzi in questo romanzo, ordito sapientemente come il ricamo più pregiato, ci fa vivere cento anni di storia in un battito di ciglia, a volte vento leggero e luminoso, altre cupo e foriero di sventura. Tante vite si intrecciano in queste righe, tanti amori, ma soprattutto l’amore per la vita stessa e per un’arte millenaria che sono la vera eredità dell’ultima ricamatrice.
Estratto
A Mario, che rende veri i miei sogni
Confeziono abiti su misura. Cerimonie, feste, banchetti. Per ciascuno ritaglio l’abito adatto all’occasione. Ho mani d’oro, dicono in paese, e io mi difendo con un sorriso, schivo lo sguardo e afferro gli spilli.
L’arte mia è sistemare con l’ago, aggiustare, cucire ma non solo le stoffe. L’arte mia ricama parole, le taglia a misura perfetta del cliente che viene da me, per chiedermi il vestito con cui figurare. “Figurare”, mi dice, perché sentirà addosso gli sguardi degli altri. Me lo ripete più volte. Da quando gli prendo le misure a quando gli adatto le prove di stoffa imbastita. E parla, mi racconta di sé, di lui che era ragazzo e voleva un completo bianco, come quello dei padroni dei campi. E lui, contadino, le gambe arcuate di chi è cresciuto poco, il ventre solido, i palmi ruvidi di calli e le rughe orizzontali che gli tagliano il viso, ha messo da parte i risparmi e ora al matrimonio del nipote non può andarci senza l’abito adatto. Allora ricamo le frasi, le seguo con refe di seta e aggiusto la storia che quest’uomo si porta addosso. La sistemo in forma di abito bianco e do alla giacca il taglio che serve a sostenere l’eleganza di una vita.
Il mio laboratorio è al centro della casa, che è una fettuccia di raso da sposa, una stanza a fianco all’altra, infilata di seguito. La mia è nel mezzo, la finestra che scoperchia un angolo di bosco e il profilo delle montagne poco oltre. Vivo qui da cinquant’anni, e da cinquant’anni mi alzo appena prima dell’alba, aspetto che la luce scrosti il nero colloso della notte, apro bene le imposte e comincio il mio lavoro.
Ho un telaio che è regalo di nonna Clelia, una struttura in legno di ciliegio, con cui scriveva arazzi, oltre a tessere stoffe di broccato, di damasco, di seta e velluto. Anche mia madre Miriam è stata tessitrice, ma per campare faceva la sarta.
Clelia è stata maestra mia e di Miriam. Tesseva, cuciva, ricamava. I suoi tessuti erano una miniera di bellezza. Miriam raccoglieva brandelli di stoffa che avanzavano, orli aggiustati, bordi di arazzi. Raccoglieva quegli scampoli come conchiglie sulla sabbia e li custodiva in una scatola di latta, un tempo colma di biscotti alla cannella. La scatola è diventata il paradiso dei miei giochi.
L’ultimo lavoro porta il nome di una ragazza, Filomela. Ha bisogno del corredo da sposa. Abito, tovaglioli, tende e lenzuola. «Il necessario per abitare una nuova casa con il mio sposo» mi ha detto con una voce che è frullo d’usignolo. Erano anni che non mi chiedevano un corredo. Oggi, che è secolo pieno di zeri, la gente preferisce entrare in un magazzino e comprare roba già bellechepronta.
Ho guardato Filomela per capire chi fosse quella ragazza che nel Duemila fa richieste così strane.
Non l’avevo mai vista. Il paese è un piccolo borgo ormai quasi disabitato, siamo rimasti in un pugno di famiglie che possiamo contarci con le mani. «A me piace questo posto» mi ha detto modulando le parole con dolcezza. E mi ha raccontato che lei e Teodoro, il futuro sposo, hanno deciso di lasciare la città con il carico di frenesia e traffico.
«Amiamo la natura e gli animali» ha proseguito socchiudendo gli occhi che paiono mezzelune dorate. «Abbiamo comprato una casa nel borgo del forno» ha spiegato con una lentezza che è scegliere con cura le parole prima di pronunciarle. «Ne faremo un agriturismo e chissà cos’altro.» Ha guardato verso il corridoio, curiosa forse di conoscere la casa a striscia di budello, che serpeggia sul colle tra il verde della piana.
Sapevo di alcuni ragazzi arrivati dalla metropoli che hanno acquistato le case diroccate del borgo.
I loro genitori correvano in città spinti dal sogno di un futuro migliore, ho pensato, e i figli si riprendono ciò che i padri hanno abbandonato.
«Vorrei imparare il mestiere» mi ha detto. «Cucire, tessere, ricamare. Le darei una mano con il corredo.»
L’ho guardata senza dire una parola, finché si è fatta rossa in viso. «Può anche dirmi di no» ha aggiunto rapida.
Perché?, mi sono chiesta. Mio figlio chissà in quale angolo di mondo è finito, io sono vecchia, gli anni mi affaticano le gambe.
«Sì» le ho risposto. «Ma solo per qualche ora al giorno. Il mio tempo è poco.»
Filomela mi ha sorriso e allungato la mano.
«A domani» le ho detto guardandola negli occhi.
«A domani» mi ha risposto abbassando il capo, come a difendersi dal mio sguardo. Mi ha voltato le spalle ed è uscita.
L’ho osservata seguire la strada bianca che scivola tra la collina e fiancheggia il monte, quindi sbuca nel borgo.
Ci sono presentimenti che senti pulsare dentro di te e che cacci come una mosca che ti ronza intorno.
Mi dicevo che si sarebbe fermata e si sarebbe girata nella mia direzione.
Poco prima che la stradina segua il prato, si è voltata e ha alzato la mano. Poi ha proseguito con quel suo passo a ritmo di danza.
Filomela è arrivata che l’alba era srotolata in un drappo rosa e copriva ogni traccia di buio rimasto nel cielo. Aveva raccolto i capelli in una treccia morbida, sul viso nemmeno un poco di trucco, e reggeva una cesta di vimini.
«Ho portato ago, ditale, forbici e spolette» mi ha detto, con un trillo di fiato.
Mi piace la puntualità, che è rispetto del tempo dell’altro. Che è dire avevo voglia di stare con te, spero di non darti disturbo, è così breve il tempo che abbiamo per noi, che, se lo sciupiamo, è sprecare ciò che c’è di più prezioso.
Lei non è di tante parole, sembra tenerle in una custodia, ne ha cura come oggetti rari e le sceglie al momento propizio, quando incrocia il mio sguardo che le chiede qualcosa.
In silenzio siamo entrate nel laboratorio, le ho mostrato il telaio, i manichini, la scatola di latta e i modelli da ricamo e le ho indicato dove sedersi.
“C’è qualcosa di lei che mi appartiene”, ho avvertito in uno spazio tra il diaframma e il costato. Quando ho osservato come afferra l’ago, prepara il canestro, passa il cotone nella cruna e affonda la punta su tela di lino. Un qualcosa che mi appartiene e che è delle donne prima di me.
«Mi racconti la sua vita» mi ha chiesto sollevando il viso, la mano che tirava il filo e io che sentivo il calore di un fuoco accendersi nel fiato.
«C’è poco da dire» le ho risposto. E ho iniziato il ricamo.
Lavoro di ago e filo da più di sessant’anni. Ho viaggiato poco, se viaggiare è spostarsi da un luogo all’altro, cambiare paese, gente, città. Se questo è viaggiare, il mio è stato uno spostarsi da un paese a quello vicino per fare subito ritorno nel luogo in cui sono nata, che è sulla sponda del fiume che scorre proprio sotto la mia finestra. Di viaggiare non ne ho bisogno, sono i viaggiatori che vengono da me e mi portano i luoghi che hanno visitato, i sogni e i desideri che rendono rapido il cammino.
È quando stringo l’ago, ci passo il filo, afferro la stoffa, che inizio il viaggio. Allora ricamo o tesso le storie che sento dentro e sono certa di imprigionarle nella seta e di ripetere i giorni, i mesi, gli anni. Ripetere finché li ho cuciti nella tela e il ricamo parla di me. Ripetere ciò che vedo attraverso la finestra, il bosco che è macchia di verde, la forma dei rami e dei tronchi, la luce che filtra tra le foglie.
Ripetere perché sono vecchia e certa di essere giunta al fondo, di avere quasi terminato la spola. Quando si arriva al bordo del tessuto e bisogna aggiustare di smerlo, puntare la seta e rendere prezioso l’orlo, che ogni cosa va finita, perché spesso è la fine che dà senso all’inizio.
Ho fatto una pausa, girando lo sguardo verso Filomela. Ricamava con gli occhi socchiusi, come se stesse seguendo un disegno e per vederlo dovesse guardarsi dentro.
«Hai la mano sicura» ho detto.
«A sei anni ho imparato a reggere un filo» mi ha risposto.
«Si vede» le ho confermato.
Mi sono alzata dalla sedia e avvicinata alla finestra. Il sole aveva raggiunto la metà del cielo e nessun’ombra si proiettava a terra.
«Che strano, per una ragazza così giovane,» ho commentato «amare il cucito.»
«Forse non sono una ragazza di questi tempi» ha replicato sostenendo il mio sguardo.
«Forse» ho accennato, curiosa di conoscere chi è questa giovane così diversa dalle altre che ho incontrato.
«Ora devo andare» mi ha preceduto Filomela, sistemando il tombolo nella cesta, con l’ago, il ditale e la spola di cotone.
«Saranno cuscini da culla» le ho detto, scorgendo nel suo volto come un cenno d’intesa, la conferma di un’intuizione.
«Allora a domani» mi ha salutato, mentre si muoveva con gesti eleganti.
Non l’ho seguita alla soglia. Sono rimasta nella stanza e mi sono seduta.
Ho ripreso a ricamare, accompagnata da un refolo di vento che entrava dalla finestra e dal rumore dei suoi passi…
L’ Autrice
Elena Pigozzi è scrittrice e giornalista. Ha pubblicato per Giunti il saggio Letteratura al femminile e diversi libri di umorismo, tra cui Come difendersi dai Milanesi, Come difendersi dai Romani, Come difendersi dai Napoletani. È dottore di ricerca in Linguistica applicata e Linguaggi della comunicazione e diplomata alla scuola di specializzazione in Comunicazioni sociali dell’Università Cattolica di Milano.