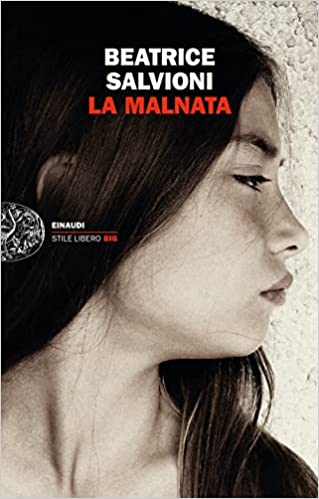

Monza, marzo 1936: sulla riva del Lambro, due ragazzine cercano di nascondere il cadavere di un uomo che ha appuntata sulla camicia una spilla con il fascio e il tricolore. Sono sconvolte e semisvestite. È Francesca a raccontare in prima persona la storia che le ha condotte fino a lì. Dodicenne perbene di famiglia borghese, ogni giorno spia dal ponte una ragazza che gioca assieme ai maschi nel fiume, con i piedi nudi e la gonna sollevata, le gambe graffiate e sporche di fango. Sogna di diventare sua amica, nonostante tutti in città la considerino una che scaglia maledizioni, e la disprezzino chiamandola Malnata. Ma quella sua aria decisa, l’aria di una che non ha paura di niente, la affascina. Sarà il furto delle ciliegie, la sua prima bugia, a farle diventare amiche. Sullo sfondo della guerra di Abissinia, del dolore per la perdita e degli scompigli dell’adolescenza, Francesca impara con lei a denunciare la sopraffazione e l’abuso di potere, soprattutto quello maschile, nonostante la riprovazione della comunità.

Alla bambina che ero.
E, soprattutto, a coloro che mi hanno insegnato
a non smettere mai di ascoltare la sua voce.
Prologo
Non dirlo a nessuno
È difficile levarsi di dosso il corpo di un morto.
Lo scoprii a dodici anni, con il sangue che mi colava dal naso e dalla bocca e le mutande attorcigliate intorno a una caviglia.
I ciottoli della riva del Lambro mi premevano contro la nuca e il sedere nudo, duri come unghie, la schiena era affondata nel fango. Il corpo di lui mi pesava sulla pancia, pieno di spigoli e ancora caldo. Aveva gli occhi lucidi e vuoti, la saliva bianca sul mento e la bocca aperta che mandava un odore cattivo. Prima di cadere mi aveva guardato con la paura che gli contraeva la faccia, una mano ficcata nelle mutande e le pupille dilatate e nere che sembravano sciogliersi fino a colare sulle guance.
Era crollato in avanti, le sue ginocchia mi premevano ancora sulle cosce che aveva tenuto aperte. Non si muoveva piú.
– Volevo solo che la smettesse, – disse Maddalena. Si toccava la testa lí dove il sangue e il fango si erano rappresi in un grumo di capelli aggrovigliati. – L’ho dovuto fare per forza.
Si avvicinò, il vestito leggero le si era incollato alla pelle fradicia e le disegnava netti i contorni del fisico asciutto, nervoso. – Vengo, – disse. – Stai ferma.
Ma io a muovermi non c’ero ancora riuscita: il mio corpo era diventato una cosa dimenticata e lontana, come un dente caduto. Sentivo solo tra le labbra e sulla lingua il sapore del sangue e a respirare facevo fatica.
Maddalena si lasciò cadere carponi, i ciottoli scricchiolarono sotto le sue gambe nude. Aveva i calzini inzuppati e le mancava una scarpa. Si mise a spingere con entrambe le braccia contro il busto di lui, usò i gomiti, poi la fronte. Continuò a sforzarsi, ma non riusciva a spostarlo.
Da morte le cose pesano di piú, come quel gatto nel cortile di Noè, pieno di terra, con le budella vischiose e un pugno di mosche che gli mangiavano il muso e gli occhi. L’avevamo seppellito insieme dietro il recinto delle oche.
– Da sola non ce la faccio, – disse Maddalena. I capelli incollati alla faccia gocciolavano sui sassi. – Devi aiutarmi.
La sua voce mi sciabordò dentro la testa, sempre piú forte. A fatica feci sgusciare un braccio da sotto il corpo di lui, poi l’altro. Premetti i palmi sul suo petto e spinsi. Sopra di noi c’era l’arco del ponte e un ritaglio di cielo torbido, sotto, i ciottoli bagnati e scivolosi. Intorno, il rumore del fiume.
– Devi spingere tutto d’un colpo.
Feci come mi aveva detto. Se prendevo fiato inspiravo il sapore languido e dolce dell’acqua di colonia di quell’uomo.
Maddalena mi guardò e disse: – Adesso.
Spingemmo insieme, io lanciai un grido, mi inarcai e di colpo lui si scollò. Piombò sulla schiena, accanto a me, gli occhi sbarrati, la bocca spalancata e i pantaloni abbassati. La fibbia della cintura tintinnò contro i sassi.
Non appena fui liberata da quel peso mi rivoltai su un fianco, sputai saliva rossa in mezzo ai ciottoli, strofinai le dita sulle labbra e le narici per cancellare il suo odore. Per un istante mi mancò l’aria, poi rannicchiai le gambe e provai a respirare. Le mutande avevano l’elastico rotto, la stoffa stracciata, bucata dal tallone. Scalciai con rabbia per sfilarmele via e mi coprii con la gonna, che si era aggrovigliata oltre l’ombelico. Avevo il ventre freddo e tutto era un dolore.
Maddalena si sollevò, si pulí dal fango sfregandosi i palmi sulle cosce. – Stai bene? – chiese.
Mi succhiai il labbro e annuii. Avevo in gola una diga sul punto di cedere. Ma non piangevo. Me l’aveva insegnato lei. Piangere era da idioti.
Maddalena si scostò i capelli appiccicati alla fronte. Aveva gli occhi piccoli e duri. Indicò il corpo e disse: – A spostarlo non ci riusciamo, – si leccò il sangue che si era raccolto sotto al naso, – dobbiamo nasconderlo qui.
Mi alzai per andarle vicino. Non mi reggevo in piedi, la suola di cuoio delle scarpe mi faceva scivolare. Mi aggrappai a lei, le strinsi le dita intorno al polso. L’odore del fiume copriva ogni cosa. Maddalena tremava, ma non per la paura. Maddalena non aveva paura di niente. Né del cane con le gengive gonfie e la schiuma fra i denti del signor Tresoldi, né della gamba del diavolo che scende dal camino nella storia che raccontavano i grandi. E nemmeno del sangue o della guerra.
Tremava perché si era infradiciata quando lui l’aveva afferrata per i capelli trascinandola oltre la riva mentre lei scalciava e gridava. Per farla stare zitta le aveva tenuto la testa nell’acqua e per tutto il tempo aveva cantato, con una voce ruvida come quelle alla radio: «Parlami d’amore Mariú. Tutta la mia vita sei tu».
– Dobbiamo trovare dei rami, – disse Maddalena, – rami robusti –. Ma non la finiva di fissare quella figura immobile, tutta sporgenze e cavità, che fino a poco prima mi aveva stretto i polsi e ficcato la lingua in bocca: mi sembrava di sentirla ancora, e addosso le dita e il respiro di lui. Volevo solo mettermi a dormire. Lí, in mezzo ai sassi e al rumore dell’acqua, ma Maddalena mi toccò una spalla e disse: – Conviene che ci sbrighiamo.
Facemmo rotolare il corpo giú dalla riva, lo trascinammo fino a uno dei piloni del ponte, lasciandolo appallottolato contro il muro che trasudava umidità. Aveva i gomiti rivoltati, le dita rigide e la bocca aperta. Non c’era piú nulla nel suo viso a ricordare il ragazzo che era: elegante e sfrontato, con i calzoni lunghi dalla piega diritta, la spilla col fascio e il tricolore, che si lisciava i capelli col pettine di tartaruga e ripeteva ridendo: «Voi non siete niente».
Raccogliemmo i rami che il fiume incastrava nell’arenile quando c’era la piena, tra i nidi delle anatre e i canali di scolo; li disponemmo su quel corpo mezzo affondato nell’acqua. Accatastammo pietre e radici perché nemmeno la piena potesse portarlo via.
– Dobbiamo chiudergli gli occhi, – disse Maddalena lasciando cadere l’ultimo sasso, grosso quanto un pugno. – È cosí che si fa con i morti. L’ho visto fare.
– Io non lo voglio toccare.
– Va bene. Lo faccio io –. Appoggiò il palmo su quella faccia sbiancata e usò medio e pollice per abbassargli le palpebre.
Con gli occhi chiusi e la bocca aperta, con tutti quei rami e quelle pietre che lo coprivano, sembrava qualcuno che nella notte viene sorpreso da un incubo, ma non riesce a svegliarsi.
Ci strizzammo le gonne e le calze. Maddalena si tolse la scarpa che le rimaneva, se la ficcò in tasca. Io feci lo stesso con le mie mutande: uno straccio molle di fango che raccolsi da terra.
– Adesso però devo andare, – disse.
– E quando ci vediamo?
– Presto.
Mentre camminavo verso casa, con le calze che cigolavano dentro le scarpe, ripensavo al tempo in cui niente era ancora cominciato. Neanche un anno prima la mia gonna era asciutta e senza stropicciature, premevo la pancia sulla balaustra del ponte dei Leoni per guardare Maddalena da lontano e l’unica cosa che sapevo di lei era che portava disgrazie. Non avevo ancora imparato che bastava una sua parola per decidere se meritavi di essere salvato o ucciso, di tornare a casa con le calze zuppe o di restare a dormire per sempre con la faccia affondata nel fiume.
Parte prima
Dove inizia e finisce il mondo
1.
La chiamavano la Malnata e non piaceva a nessuno.
Dire il suo nome portava sfortuna. Era una strega, una di quelle che ti appiccicano addosso il respiro della morte. Aveva il demonio dentro e con lei non ci dovevo parlare.
La guardavo da lontano la domenica, quando mamma mi infilava le scarpe che tagliavano i talloni, le calze piene di grumi e il vestito buono che dovevo stare attenta a non sporcare. Il sudore mi scendeva dietro al collo e il continuo sfregare mi arrossava le cosce.
La Malnata era giú al Lambro insieme ai maschi, due ragazzi che conoscevo solo per nome: il Filippo Colombo, che aveva le braccia e le gambe come ossicini di pollo, e il Matteo Fossati, con le spalle e il petto che erano i quarti di bue lucidi di grasso del mercato di via San Francesco. Entrambi avevano i pantaloni corti, le ginocchia piene di graffi e per lei, che era piú piccola e pure femmina, sarebbero stati disposti anche a prendersi in pancia i proiettili, come i soldati che vanno in guerra, e dire poi al Signore: «Sono morto felice».
Teneva l’orlo della gonna, a cui il sole e lo sporco avevano levato il colore, arrotolato nella cintura da uomo stretta in vita, i piedi nudi ben piantati sulle rocce calde di sole. Sono la cosa che una ragazza non deve mai mostrare, le gambe. Le sue erano nude e rigate di fango che le imbrattava i polpacci e le cosce.
Aveva croste che sembravano le piaghe non curate dei cani. Rideva stringendo un pesce che voleva sgusciarle via dalle dita. I maschi applaudivano e battevano i piedi nel fiume, facevano schizzare l’acqua scura tutt’intorno e io li scrutavo dall’alto mentre andavamo alla funzione delle undici, che per mamma era quella dei «signori».
Papà era davanti e non badava a noi. Camminava con il cappello che gli scopriva appena la nuca, il passo svelto, le mani dietro la schiena, una aggrappata al polso dell’altra.
Mia madre mi strattonava e diceva: «Facciamo tardi». Indicava oltre la balaustra del ponte e diceva: «Ragazzacci».
Mio padre, al contrario, non diceva niente. Non tollerava i rimproveri, ma io sapevo bene, e mamma ancora di piú, che se fossimo rimaste lontane da lui piú di un tiro di sasso e per colpa nostra a messa fossimo arrivati in ritardo, quella sarebbe stata una domenica di silenzi, di porte che sbattono e di denti che digrignano sul cannello della pipa dietro la «Domenica del Corriere».
Dovevo sforzarmi per allontanare lo sguardo dai bambini giú al fiume, i bambini che non ero e che avevo sempre spiato.
Ma quella domenica, per la prima volta, la Malnata mi fissò con i suoi occhi lucenti e neri. Poi fece un sorriso.
Mi mancò il respiro e serrai le palpebre, scattai verso mio padre, sulla strada che saliva al duomo. Lo affiancai e lui nemmeno se ne accorse. Le poche macchine che passavano ci costringevano a schiacciare la schiena contro le vetrine della merciaia e del pasticcere da cui giungeva l’odore caldo della vaniglia. L’insegna annunciava: «Vassoio di paste a cinque lire».
Stava passando la Balilla nera del Roberto Colombo, che lavorava in Comune e, diceva papà con il tono delle cose serie, «conosceva persone molto in alto». Il signor Colombo aveva due figli maschi, che la signora Colombo faceva pettinare con la riga nel mezzo, e portava gli stivali neri al polpaccio. Quando le vecchie della chiesa gli avevano rivelato che suo figlio piú piccolo trascorreva tutto il giorno con i piedi nel fiume assieme alla Malnata, si diceva lui gli avesse cacciato giú a forza una bottiglia di olio di ricino e arrossato il sedere dalle scudisciate.
Per qualche domenica, dal ponte avevo spiato Matteo e la Malnata da soli: Filippo se ne stava in chiesa, sulla stessa panca del padre, distante un braccio da lui, con la camicia abbottonata fino al collo e i mocassini puliti. In segreto, ne ero stata felice. Poi, un giorno, Filippo era tornato a farsi insozzare di fango e i suoi genitori, assieme al fratello piú grande, avevano preso a sistemarsi piú larghi a messa, per rendere meno visibile il posto vuoto che aveva lasciato.
Il signor Colombo guidava la sua auto sempre lucida con il frontale che pareva un muso di pescecane con le zanne affilatissime. La lasciava nella piazza del duomo per entrare subito in chiesa, come se a camminare gli si rovinassero troppo le scarpe.
Mio padre increspò le labbra quasi gli fossero rimasti fra i denti residui di tabacco. – La nostra rovina. Quegli orrori saranno la nostra rovina –. Non c’era nulla che odiasse piú delle macchine. – La gente vuole andare veloce, – diceva, – è per questo che nessuno indossa piú il cappello –. Però se incontrava il signor Colombo salutava con garbo toccandosi la tesa del suo Fedora di feltro grigio.
Entrando in chiesa scomparve il caldo afoso scoppiato in anticipo di due settimane rispetto all’arrivo dell’estate. Rimase solo il tanfo sporco dell’incenso che saliva al cervello e scivolava fino ai talloni; era una sensazione che somigliava alla paura del buio. Mamma mi teneva per mano e io camminavo solo sulle lastre di marmo bianco perché il Gesú di bronzo e oro in fondo all’altare non la piantava di fissarmi e se per sbaglio avessi calpestato il marmo nero poi sarei andata all’inferno.
Nella navata di mezzo risuonavano i sibili delle preghiere e l’umido schiocco della saliva delle vecchie che pregavano con le spalle curve, la testa coperta da veli che nascondevano le orecchie. Sedevamo sempre tra le file davanti e bisognava stare zitti tutto il tempo, tranne che per rispondere ai salmi, dire «Amen» e «Mea culpa, mea maxima culpa». Il prete parlava dei peccati che mandano all’inferno e io pensavo ai pesci con le pance d’argento, ai ragazzi a piedi nudi nel Lambro e allo sguardo della Malnata.
Mamma recitava il Pater Noster con la faccia nelle mani, i polpastrelli sulle palpebre. Io studiavo un chiodo che spuntava dal legno dell’inginocchiatoio. Quando il prete sollevò in alto il Corpo di Cristo, mi lasciai cadere in avanti come fanno le vecchie.
Cercai il chiodo con una gamba e ci caricai sopra tutto il peso. Intrecciai le dita e le schiacciai sulla bocca spingendo le nocche tra i denti, grattavo forte il ginocchio e dicevo il Gloria.
Lo sfregai con foga finché il dolore mi scavò nella nuca come una cosa rovente e levigata.
Anche io volevo avere le rotule segnate come i ragazzi giú al Lambro. Anche io volevo sentire il fiume filtrarmi tra le dita dei piedi e mostrare le gambe rigate di fango. Volevo che battessero per me le mani e i piedi nell’acqua.

Beatrice Salvioni (Monza, 1995), ha praticato scherma medievale e ha scalato il Monte Rosa. Nel 2021 si è diplomata alla Scuola Holden e ha vinto il Premio Calvino racconti. La malnata (Einaudi 2023) è il suo primo romanzo, in corso di traduzione in tutto il mondo e in procinto di diventare una serie tv.












