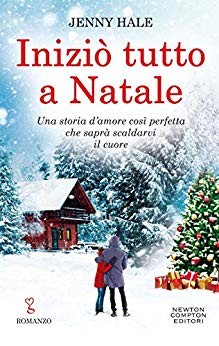Sinossi
Perfetto per gli amanti di Camilleri e Manzini
Uno strano caso per Astore Rossi
Astore Rossi lavora come restauratore di mobili antichi in una piccola città di provincia. Uomo schivo, solitario e amareggiato dai ricordi del passato, coltiva soltanto i pochi legami indispensabili al suo lavoro. L’unica persona con cui ha allacciato un rapporto è Luisa, un’anziana vicina di casa. Quando lei muore, lasciandogli una misteriosa chiave e strappandogli la promessa di rimediare al male passato, Astore si trova coinvolto, suo malgrado, nelle oscure vicende che riguardano la famiglia Spada, cui Luisa apparteneva. Ci sono antichi e inimmaginabili segreti custoditi dalle stanze di una villa immersa nei boschi dell’Appennino bolognese. E c’è qualcuno, spietato, che non vuole assolutamente che vengano scoperti. La posta in gioco per arrivare alla verità e mantenere la promessa fatta a Luisa rischia di essere molto alta…
Una chiave misteriosa
Un macabro segreto
Il passato esige il suo credito
Hanno scritto dei suoi romanzi:
«Un thriller ad alta suspense che cattura sin dalle prime pagine per la trama avvincente e il ritmo serrato.»
Leggere:tutti
«Le sue storie noir sono ben costruite ed è abile nel tessere trame che coinvolgono il lettore fino all’ultima pagina.»
Sherlock Magazine

Estratto
Mi pareva di essere vicino a capire senza però riuscire a capire, come capita di essere vicini a ricordare e di non riuscire a ricordare.
Edgar Allan Poe
PRIMA DELL’INIZIO
Le note del Concerto per piano e orchestra n. 3 di Rachmaninov si stavano diffondendo dal salone principale sino al giardino che circondava la grande casa. Le vetrate erano rimaste chiuse tranne la porta finestra, spalancata sul sentiero che conduceva al roseto. Il volume del giradischi era forse un po’ troppo alto e ogni tanto la puntina sobbalzava sul vinile.
La donna stava scrivendo con scatti frenetici, facendo scricchiolare la penna sulla carta.
Quello che aveva finalmente compreso e che aveva dovuto affrontare dopo anni di indifferente apatia era troppo per una sensibilità delicata come la sua. Per tutta la vita aveva voltato la testa dall’altra parte. Aveva commesso molti errori a causa della propria vigliaccheria, dell’orgoglio che le derivava dall’appartenere a una famiglia che possedeva un passato tanto importante.
E ora, giunta al crepuscolo della propria esistenza, si sentiva sconvolta, annichilita dall’orrore più profondo.
Aveva quindi deciso di non tacere nulla di ciò che sapeva, che aveva visto con i propri occhi e che avrebbe preferito le fossero stati strappati dalle orbite piuttosto che apprendere quegli indicibili segreti. La sua scelta era inevitabile: doveva denunciare quello che era accaduto nei lunghi anni passati alla villa e di cui si sentiva involontaria complice. Un rumore di passi risuonò nell’enorme stanza, confondendosi con la melodia che gli archi stavano imbastendo nel secondo movimento del concerto. Una mano guantata le si appoggiò sulla spalla, con leggerezza, quasi con affetto.
La donna venne invitata ad alzarsi e dirigersi verso l’esterno, mentre un terrore irrefrenabile le invadeva l’anima, velenoso come la coda di uno scorpione.
«È finita. Lo sai, vero?», le disse una voce, giunti che furono sotto un vecchio larice che dominava il giardino. La donna respirò forte, pensando che forse era meglio così, lasciarsi dietro tutto l’orrore e morire in una giornata di fine settembre, ascoltando una musica così piena di vita, in quel luogo che tanto aveva amato.
Il colpo di accetta la raggiunse al collo, facendola cadere in avanti come una bambola rotta. Al primo ne seguirono altri, vibrati con una compiaciuta violenza, finché del corpo non restò che un osceno ricordo soffocato dal sangue.
La figura se ne stava in piedi, ansimante per lo sforzo, ma inebriata da quello spettacolo di morte.
L’importante era nascondere, mettere a tacere, occultare tutto.
Andò a raccogliere la canna dell’acqua che veniva usata per innaffiare le aiuole, la attaccò al rubinetto più vicino e irrorò tutta la zona dove giaceva il cadavere, fino a far sparire ogni traccia visibile.
“Tanto”, pensò, “nessuno svolgerà indagini, tantomeno qui”.
Poi recuperò alcuni fogli di cellofan con i quali avvolse con cura i pezzi smembrati, legandoli con del nastro da pacchi.
«Che strano», mormorò, «i cadaveri sembrano più leggeri, quasi che l’anima strappata a forza dal corpo sottragga loro peso e consistenza».
Il disco di Rachmaninov giunse alla fine, la puntina si spostò in automatico verso il suo supporto. Così, d’improvviso, sul giardino calò un silenzio cupo, appena scalfito dai fremiti degli insetti, dagli scricchiolii dei rami, dal maestrale che cantava tra le chiome degli alberi per la fine dell’estate.
Sopra la casa si udì il chiacchiericcio di una cornacchia, l’unico segnale che il tempo non si era fermato insieme alle note del concerto e al battito del cuore della vittima. Le poche nuvole contribuivano a rendere speciale quel cielo, così distante e disinteressato alla bellezza, al piacere, alla morte, a tutti i delitti compiuti sotto di sé.
I sacchi di plastica furono portati nel luogo segreto, dove avrebbero giaciuto per gli anni che sarebbero serviti a far dimenticare al mondo chi vi fosse contenuto.
Si mosse con abilità, mettendo in atto tutte le precauzioni indispensabili a evitare sgradevoli attenzioni da parte delle autorità e mascherando accuratamente la morte della donna dietro l’apparenza di un suicidio. Sarebbe stato il custode, in quel momento al bar del paese a scolarsi la sua razione di vino quotidiana, a rilevare la scomparsa della vecchia signora e a dare l’allarme qualche ora più tardi. Il corpo non avrebbe dovuto essere trovato, mai. Soltanto le tracce di una morte dovuta alla depressione e alla tristezza.
La porta della grande casa si richiuse infine con un rumore sordo che echeggiò per tutto il salone, nelle stanze, persino in soffitta. I passi si allontanarono lungo il sentiero di ghiaia, fino allo spiazzo sottostante. Nel giro di qualche minuto l’ansimare grintoso di una vettura che si muoveva, scendendo lungo le strade dell’Appennino, coprì ogni suono, prima che la consueta tranquillità si riappropriasse di nuovo dell’immensa distesa verde circostante.
CAPITOLO I
Mi chiamo Astore Rossi e vi sembrerà singolare che un nome così unico sia congiunto a un cognome, al contrario, prosaico e assai diffuso in tutta Italia. Di solito prevengo ogni domanda al riguardo spiegando che, quando sono venuto al mondo, mio padre, avido appassionato di saggi sulla storia delle battaglie e delle guerre, stava leggendo le gesta di un valente condottiero che, insieme a Marcantonio Bragadin, difese con eroismo Famagosta dall’assalto dei turchi. Dal suo nome il mio. Del resto poteva andarmi peggio: se in quel periodo il mio caro genitore avesse avuto sottomano libri relativi a episodi guerreschi più recenti, magari mi sarei chiamato Winston o Adolf…
Sembrerebbe una cosa ridicola, ma è evidente che non avete conosciuto mio padre. Posso garantire che, per voi, è stato meglio così. Resta il fatto che, da quaranta anni, mi porto appresso questo fardello che, unito al mio profilo leggermente adunco, mi ha costretto a subire ogni genere di scherzi e di prese in giro, soprattutto da bambino, quando si comincia a imparare come il mondo non sia proprio un gran posto in cui crescere serenamente. Mi sono comunque abituato e ora questo nome da rapace me lo stringo forte, lo sento mio: un essere solitario che vola sopra alla città, distante da essa, insofferente alle sue regole, un uomo libero insomma.
Di mestiere faccio il restauratore di mobili e non solo questo. Se capita l’occasione, ne faccio pure il mediatore, quando non mi arrischio a comprare, sistemare e rivendere qualche pezzo discreto, magari trovato in un mercatino di provincia oppure in qualche soffitta polverosa, piena di ricordi arrugginiti e di ragnatele. Non è che navighi nell’oro, anzi. Ma è più che sufficiente, in questi tempi di crisi, a vivere in maniera dignitosa, considerando che mi accontento di poco e me ne frego del resto.
Come mai si scelga di fare questo lavoro è la seconda domanda più frequente che mi è stata rivolta nel corso degli anni e la mia risposta è rimasta sempre la medesima: non si decide di cominciare un mestiere così, si viene presi e basta. Quando replico in questo modo, vengo spesso guardato di sottecchi, come se fossi un matto – il che potrebbe anche essere vero, almeno secondo gli standard di questa società decadente – aggiungendo un pensiero non formulato, che tuttavia percepisco sulle labbra dei miei interlocutori: “Eh, certo, con un nome del genere c’era da aspettarselo…”.
Eppure è stato così. Anche se il mio destino sembrava dovermi portare verso altro, a causa di certe vicissitudini di cui leggerete poi, sono stato rapito da questa passione che mi permette di vivere come voglio, ossia in una nicchia, nascosto dalla folla quel tanto che basta a mantenermi immune da ciò che mi circonda e mi opprime, cercando l’anima nel legno degli oggetti che devo restituire a nuova vita. Non è certo facile questo mio lavoro, occorrono maestria e precisione, passione e resistenza fisica. Bisogna affinare le proprie capacità, giorno dopo giorno, come se si fosse sempre apprendisti che smaniano per imparare la tecnica e insistono nel voler conoscere le cose sino a penetrarle.
A nessuno probabilmente importerà di queste mie riflessioni e a me, d’altro canto, non importa di nessuno. Vivo le mie giornate tra la bottega e un piccolo appartamento al piano di sopra, assieme ai miei libri e alle mie idee.
I miei pochi momenti di evasione, se così si possono chiamare, li spendo nel recarmi ogni tanto a fare la spesa in un negozietto a qualche centinaio di metri da dove abito, uno di quei posti sovraccarichi di alimentari d’ogni specie, che ogni volta mi mettono allegria, mentre guardo le etichette delle bottiglie di vino, osservo le forme delle scatole, percepisco i profumi dei formaggi e gli aromi speziati dei salumi. Il gestore del negozio, un piccoletto dal viso rubizzo di nome Carmine, si diverte parecchio a pormi la stessa domanda ogni volta che mi vede.
«Allora, Astore, ci sono novità?».
E io gli rispondo sempre nello stesso modo.
«Assolutamente no».
Carmine allora ride e occhieggia i presenti.
«Sono dieci anni che ci conosciamo», esclama, «e non hai mai niente di nuovo da raccontare. Hai una vita davvero intensa!».
Io faccio finta di niente, pago ciò che ho acquistato e mi avvio a ritornare nel mio piccolo, microscopico universo personale, circondato dai rumori degli attrezzi, dai colori e dai sapori del legno.
Il percorso verso la mia bottega di artigiano si snoda attraverso alcune strade morte il cui fascino mi pervade il cuore ogni volta, quasi fosse la prima. Viuzze strette dove raramente penetra il sole e, anche quando lo fa, si vede che è soltanto di passaggio. I palazzi sono vecchi più che antichi, possiedono il fascino del tempo cattivo, delle incrostazioni, dei panni perennemente stesi ad asciugare, delle serrande chiuse e arrugginite, del silenzio pacato degli assenti.
E via San Giorgio è una strada morta per eccellenza, dove, a parte la mia attività, non ve ne sono più altre. Sì, una volta c’erano un tappezziere con annesso negozio di scampoli, un barbiere, un’agenzia di assicurazioni, ma hanno tutti chiuso. Esisteva pure una locanda che si chiamava L’asino di Buridano, che sopravviveva ai propri magri incassi preparando pasti per qualche impiegato o per qualche coppia clandestina che poteva mangiare al riparo da occhi indiscreti, finché, un triste giorno, l’anziana titolare ne ha chiuso i battenti senza alcuna speranza di cedere l’attività. Negli anni ho visto spegnersi ogni segnale di vita economica nei dintorni; al posto di insegne e vetrine sono rimaste serrande chiuse coperte di scritte e disegni volgari, come occhi ciechi e per giunta deturpati.
Qualche portone, ognuno diverso dall’altro, con i campanelli dai nomi ormai illeggibili, scoloriti dalle intemperie, si apre sugli edifici prospicienti la strada. I residenti della zona sono per la maggior parte anziani, spesso soli, che se ne stanno rintanati nei loro appartamenti a spiare da dietro ai vetri: probabilmente controllano che non arrivi la morte a cercarli. Chi altri potrebbe passare da qui se non lei?
Mi sono innamorato immediatamente di questa via che non possiede luce, né chiasso, né passeggio; che racconta le storie del passato e mescola le atmosfere del giorno con quelle della notte fino a creare una specie di crepuscolo continuo, soprattutto nelle stagioni invernali. Probabilmente il colpo di fulmine è derivato proprio dalle affinità con il mio modo di vivere.
Poiché in quel periodo stavo cercando un ambiente dove trasferirmi dopo alcuni anni di apprendistato presso un vecchio restauratore, trovai qui un piccolo negozio, sfitto da tempi immemorabili, in un edificio al cui piano superiore era libero anche un appartamento di sessanta metri quadrati. Persino troppi per uno come me. L’affitto di entrambi era veramente vantaggioso, il che era dovuto alla scarsa appetibilità della zona e allo stato pietoso in cui versavano i due immobili.
Stipulati i contratti con il proprietario, in poche settimane trasformai il negozio in una bottega artigianale, riempiendola con gli attrezzi, i materiali e i mobili di clienti di cui il mio vecchio maestro, ormai ritiratosi, mi aveva consentito di terminare il restauro, incassando conseguentemente i proventi dei lavori fatti, giusto per darmi una mano ad avviarmi.
L’appartamento l’avevo inizialmente lasciato com’era, ossia con le pareti ricoperte da una vecchia carta da parati scolorita, a tratti strappata, con i pavimenti a mattonelle bianche e rosse che ogni tanto scrocchiavano sotto i miei passi, con la vasca da bagno nella quale lunghe strisce marroni segnalavano il passaggio ripetuto di gocce d’acqua ferrosa. Vi avevo piazzato il mio letto, quello stesso dove avevo dormito nella mia adolescenza a casa di mio padre, un tavolo con due sedie, un armadio recuperato anni prima da un casolare disabitato e che avevo risistemato con infinita e paziente passione, e infine una piccola libreria di noce del primo Novecento, l’unico vero tesoro che abbia posseduto nella vita, almeno fino a oggi. Sui suoi ripiani si erano andati a collocare tutti i miei libri, quei pochi, cari, compagni notturni. In seguito la dovetti vendere per necessità e, al suo posto, misi delle semplici mensole. Anche i muri, qualche mese dopo il mio ingresso li ripulii della carta da parati, dando loro una mano di tinta neutra. Al posto della vasca, un paio d’anni più tardi, feci installare un box doccia.
Nel mio stesso stabile vi sono altri tre appartamenti, di cui uno da che mi ricordo è sempre stato disabitato, un secondo era occupato da un tale Gregori, un professore di storia e geografia in pensione che non si faceva vedere quasi mai, tanto che per incontrarlo bisognava fargli la posta come per certi animali selvatici durante la stagione di caccia. L’altro, proprio dirimpetto al mio e con cui pertanto dividevo il pianerottolo, era abitato da Luisa Ruggeri, una pimpante signora ottuagenaria, sempre pronta al sorriso e alla chiacchiera. Quando usciva o quando rincasava non mancava mai di passare a trovarmi in bottega, raccontandomi le piccole storie della sua giornata. Rappresentava l’unico legame con quella realtà esterna cui non volevo appartenere, se non il minimo indispensabile.
Le prime volte faticavo ad accettare quelle sue intromissioni nella mia giornata, quei suoi discorsi banali, quel suo ripetere spesso le frasi inseguendo con la memoria gli argomenti di cui voleva parlarmi e che le sfuggivano. Col tempo, però, mi accorsi che mi ero affezionato a quella donnina, apparentemente fragile, ma in realtà inossidabile come certe viti che resistono nelle loro cerniere anche quando il legno intorno si è sbriciolato.
Attendevo le sue visite con il piacere di un rituale sempre identico e per questo ancor più necessario a giustificare lo scorrere di una giornata.
«Sa, signor Astore», capitò che mi dicesse una volta, «non vedo più l’inquilino del palazzo di fronte, quel ragazzo che girava sempre con la bicicletta rossa. Chissà se si è trasferito».
«È morto tre anni fa, Luisa, non si ricorda? E poi aveva quasi settant’anni, definirlo ragazzo mi sembra alquanto generoso da parte sua», le avevo risposto sorridendo, mentre controllavo un piede di noce da rincollare a un comò. La signora Ruggeri aveva scosso la testa, come per controllare che i suoi pensieri fossero tutti al loro posto ed era uscita per la sua passeggiata quotidiana, lasciando nell’aria sapida di segatura un vago profumo di mughetto. Lei era così: cambiava la mia giornata in meglio, riuscendo a strapparmi i sorrisi dalle labbra, suggerendomi che, in questo nostro mondo, c’era spazio anche per i dispersi come il sottoscritto.
Il ricordo più suggestivo che mi rimane di lei appartiene a una vigilia di Natale di quattro o cinque anni fa. Me ne stavo rintanato nel mio appartamento gustando un vecchio romanzo di Balzac, accompagnandone la lettura con un bicchiere di vino rosso. Fuori faceva freddo come da tradizione, senza neve, ma con un muro di nebbia feroce, di quelle che ti avvolgono come un sudario umido, lasciandoti l’impressione straniante di non avere punti di riferimento, di essere precipitato in un mondo alieno e minaccioso.
In via San Giorgio la sensazione di estraneità si amplificava ancora di più. Mancava un’illuminazione stradale decente, non c’era traccia neppure di quei pochi festoni natalizi che adornavano le altre vie cittadine, rassicurando i passanti nel loro cammino verso i negozi traboccanti di proposte per i regali. Da un edificio poco distante dal mio proveniva un rumore insistente dovuto a un aspirapolvere usato a piena potenza. Mi stavo chiedendo chi potesse mettersi a sbrigare le pulizie domestiche alle otto di sera del ventiquattro dicembre, quando sentii bussare alla porta – non ho mai avuto il campanello – con insistenza. Mi avvicinai all’uscio e domandai chi fosse.
Rispose la voce quasi trasognata della mia dirimpettaia: «Sono io, signor Astore. Le ho portato una cosa buona».
Aprii di malavoglia, lo ammetto, seccato di essere stato costretto a interrompere la lettura. Mi trovai di fronte la signora Ruggeri con un piatto fumante tra le mani. L’aroma del brodo di cappone e dei cappelletti era commovente, al punto che lo stomaco mi si contrasse in maniera dolorosa. In effetti, il mio pasto a mezzogiorno si era limitato a un uovo sodo e una mezza piadina farcita con una fetta di salame milanese, mentre a cena non avevo ancora toccato cibo. Non avrei potuto resistere in alcun modo a quella vista paradisiaca.
L’anziana donna proseguì: «Ho pensato che passare la vigilia di Natale da solo e senza nemmeno del buon cibo da gustare sarebbe stato molto triste, anche per un burbero come lei. Così le ho preparato questi cappelletti con il brodo buono, fatto in casa con le mie mani. Li ho cucinati proprio come la tradizione vuole. Astore, la vedo tanto deperito, ha bisogno di nutrirsi bene».
«Settanta chili per uno e ottantacinque: non sono così magro, le pare?».
Nonostante la mia risposta un po’ indisponente, per la prima volta da tanti anni, il mio cuore si era rimesso in moto, anche se lentamente, da vecchio motore diesel che era, così la invitai a entrare. Mi spinsi fino a chiederle di farmi compagnia, di cenare con me, e mi stupii di essere addirittura contento quando lei accettò, recandosi nel suo appartamento a prendere un piatto per sé. Portò anche un pezzo di arrosto con le erbette e patate al forno il cui sapore avrebbe fatto resuscitare un morto. Fu la prima volta, lo ammetto senza problemi, che una donna metteva piede in quell’appartamento e che condivideva il suo tempo col sottoscritto.
Mi parlò quasi ininterrottamente del suo passato e del suo presente, a volte saltando da un argomento all’altro, mentre io la ascoltavo senza distrarmi nemmeno per un attimo.
Mi raccontò parecchie cose di sé, ad esempio del suo matrimonio con un ragazzo toscano che era morto giovane, lasciandola sola; degli studi classici che avrebbe voluto proseguire all’università, di una vacanza al mare in Calabria che le era rimasta impressa per il colore del mare e per il gran caldo. La sua voce incespicava ogni tanto su una data o su un luogo, senza che questo togliesse nulla al fascino della narrazione, anzi: quella sera riuscì a farmi sentire parte integrante del suo piccolo universo. E poco importò se non le parlai di me, se continuai a tener dentro i pensieri e le angosce che mi perseguitavano ogni notte, se rimasi un convitato silenzioso davanti a un’anziana dolce signora che mi chiamava ancora “signor Astore”.
Fu così che il suono della sua voce che accompagnava il pasto, la condivisione di quei momenti, il sorriso affettuoso che mi veniva rivolto, la sensazione di pace che mi aveva trasmesso mi portò a riappacificarmi, almeno per un poco, con il passato e con la vita che mi pesava sulle spalle.
Quando se andò, un’oretta più tardi, mi trovai a riflettere sul senso di perdita che mi aveva lasciato. Mi sentivo un po’ a disagio, non ero più abituato a quel calore, al piacere della conversazione e dell’ascolto, della compagnia. Per scacciare i pensieri sgraditi che si stavano nuovamente accompagnando alla mia solitudine bevvi due dita da una vecchia bottiglia di Barolo regalatami da un cliente, e ripresi la lettura di Eugénie Grandet sulla poltrona.
Ora che lei non c’è più, quella sera di dicembre mi appare ancor più vivida nella memoria così come mi sembra sempre più assurda la storia in cui mi sono trovato coinvolto e che voglio raccontarvi a distanza di alcuni mesi dai fatti, proprio per non dimenticarmene mai.
Riccardo Landini nato in Emilia ma d’origine romagnola, ha alle spalle studi classici e nel cuore una grande passione per Piero Chiara e per il cinema italiano degli anni Settanta. Nel 2009 ha esordito nella narrativa con il romanzo E verrà la morte seconda. Sono seguiti Il primo inganno, Non si ingannano i morti e Ingannando si impara, volumi di una trilogia. Nel 2013 è stato vincitore del premio Giallo Stresa.