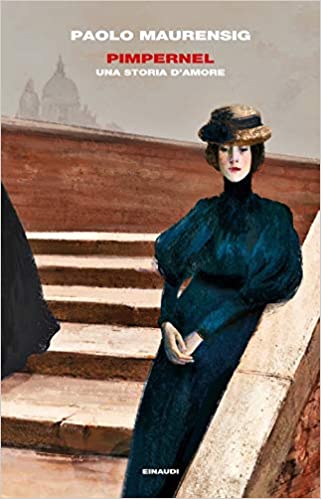Trama
È l’estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo è sull’orlo dell’abisso.
Ma lei non lo sa. Quell’estate sarà la più bella della sua vita.
Miranda parte con sua madre da Firenze per raggiungere Villa Ada, la casa del nonno paterno, il marchese Ugo Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è altrove.
La cascina del nonno e il bosco misterioso che la circonda sono il teatro perfetto per le avventure spericolate insieme con Lapo, il nipote del fattore, le scorribande in bicicletta, le scoperte pericolose, il primo, innocente bacio.
Ma il bosco è anche il luogo abitato dalle creature parlanti che l’anima di bambina vede o crede di vedere. E la foresta compare sempre, e misteriosamente, nei quadri del nonno, chiusi nel laboratorio che nessuno ha il permesso di visitare.
C’è come una luce magica che rischiara quella porzione di mondo. Miranda, ormai novantenne, ce la racconta, fendendo le nebbie della memoria. Tornare a quei giorni, a quella bambina ignara, che ancora non ha visto, vissuto, sofferto, perduto è più che una consolazione, è un antidoto.
È l’incantesimo di una giovinezza improvvisa.
Francesco Carofiglio ci conduce per mano all’ultima estate di innocenza. E lo fa con ciò che, più di ogni altra cosa, contraddistingue la sua poetica, la fragilità incorruttibile del ricordo e lo sguardo innocente di chi può ancora essere salvato.
Estratto
Bisognava sbrigarsi, fare in tempo a vivere
prima che tramontasse il sole,
prima che cadesse la neve.
WISŁAWA SZYMBORSKA
È successo d’estate, molti anni fa.
Tra le nebbie che affollano, adesso, i miei pensieri di vecchia, una luce rischiara una piccola porzione di mondo. Chiudo gli occhi e rivedo, intatta, la bellezza radiosa della campagna. Riesco a distinguere ogni dettaglio, nel fremito delle ciglia, colpite dai raggi obliqui del mattino.
Avevo dieci anni, e il mondo stava per affondare nell’abisso. Ma per me era solo estate e campagna.
La più bella estate della mia vita.
Mi chiamo Miranda, perché mio padre amava un quadro di John William Waterhouse, un pittore preraffaellita. Nel quadro è raffigurata una ragazza dai capelli rossi che guarda il mare in tempesta. È la figlia di Prospero, naufragata col padre quando era bambina. Nella tragedia di Shakespeare, a cui è ispirata l’opera, Miranda è una ragazza senza qualità apparenti. Mi è sempre parso così. Vive negli agi, protetta dal mondo, incapace davvero di agire e di entrare, nel mondo.
Mi sono chiesta tante volte perché mio padre amasse quel quadro. Ho cercato nell’opera di Waterhouse un indizio che potesse condurmi all’idea nuda, al principio ordinatore. Convinta che ci fosse un principio, e un’idea preveggente. Quasi che il nome segnasse la linea del nostro destino.
O forse ho solo cercato una traccia che mi riportasse alla stagione breve della nostra famiglia felice. Non lo so. Non ne sono mai venuta a capo, e mai ne verrò.
Ma nell’estate del 1939 mi sembrava che tutto fosse in armonia, mentre preparavamo i bagagli per la villeggiatura. Partivamo per la campagna.
E invece era la fuga. Lo avrei scoperto solo più tardi.
1
Andammo dal nonno. Il padre di mio padre.
Viveva solo in una cascina, a ridosso della grande macchia del bosco. La nonna era morta giovanissima, e mio padre era cresciuto con una tata e i domestici. Senza madre, e quasi senza padre.
Nonno Ugo era altissimo e aveva due baffi folti e bianchi, che lo rendevano inavvicinabile. Con lui viveva Elda, la governante. Era piccola, segaligna, piena di segni sul viso. Un’ape industriosa, sempre intenta alle faccende e al governo della casa.
Mia madre non amava mio nonno, credo, mio padre se ne era allontanato, subito dopo il matrimonio. Ma io allora questo non lo sapevo. Il babbo era socialista, il nonno un vecchio anarchico, sebbene di famiglia aristocratica. C’è una fotografia, che conservo ancora, in cui sono l’uno accanto all’altro, poco prima che io nascessi. Il nonno porta una giacca con un panciotto, mio padre una camicia senza cravatta. Non c’è una traccia di sorriso nei loro volti, di familiarità. Il primo sovrasta il secondo, sullo sfondo della cascina. Credo sia stata l’ultima volta che mio padre è stato lì.
Villa Ada era bella e austera, dominava una piccola altura della collina pistoiese, ad alcuni chilometri da Calamecca, un paesino medievale nella Valdiforfora. I nomi delle località, pronunciati adesso, sembrano venire fuori da un romanzo di Rabelais. Sono allegri, e misteriosi.
La cascina era una costruzione di muri squadrati, ritagliava una sagoma netta nei tramonti che infiammavano la valle. Intorno alla casa c’era un prato circondato da una siepe, poi l’aia, il pollaio e la stalla con Aldo, un vecchio cavallo maremmano. Accanto al fienile una tettoia sotto la quale erano parcheggiati il calesse e l’automobile. Le pecore e i maiali non c’erano più.
Nonno Ugo era un pittore. Era stato allievo di Gordigiani e amico di Alfredo Müller. Con lui era stato a Parigi all’inizio del Novecento e aveva conosciuto Cézanne, Pissarro, Toulouse-Lautrec. Ma non aveva avuto la stessa fortuna di Müller ed era tornato in Toscana.
Il suo studio si affacciava sulla valle, luminoso per le grandi vetrate, e freddo. Il nonno dipingeva tutto il giorno, e nessuno poteva disturbarlo, per nessuna ragione al mondo. Nello studio c’era un odore intenso, di olio, trementina, e di umidità, che aggrediva le volte disegnando paesaggi mutevoli di muschio sull’intonaco. Sul lato più lungo della sala c’erano le tele accatastate, tenute insieme dallo spago e coperte con degli stracci e, su quello più corto, gli enormi cavalletti di legno. Certi quadri del nonno erano grandi quasi quanto la parete.
Arrivammo una domenica di giugno. Alla stazione di Pistoia era venuto a prenderci Ottone, un mezzadro molto devoto al nonno, con un autocarro che puzzava di letame. Impiegammo quasi due ore per arrivare a Villa Ada, c’era stato un temporale e le strade erano piene di fango. Ma il viaggio mi sembrò bellissimo, era la prima volta che mi allontanavo da Firenze, e la prima volta che andavo a trovare il nonno in campagna.
Quando arrivammo in prossimità della valle vidi il grande bosco di cerri che costeggiava la strada. Dal finestrino, nel ritmo sincopato della marcia, seguivo la successione ipnotica dei tronchi che diventavano una cortina più fitta, man mano che si saliva verso la collina. Sentivo l’aria fresca che arrivava dalla macchia e mitigava, con il profumo delle resine, il fetore del concime. Mi sembrava di riconoscere, nel passaggio, le sagome degli animali magici che avevano animato, per anni, i racconti della buonanotte, il gufo grigio, la volpe d’argento, la lepre azzurra. Ero emozionata e felice.
Dopo l’ennesimo tornante il paesaggio si aprì in una radura festosa e assolata, e in cima alla collina riconobbi il profilo tagliente della cascina. Era lo stesso di una fotografia che era appesa nel salotto, a Firenze. Guardai mia madre e lei mi sorrise.
«Ovvìa, s’è arrivati…»
Ottone, che non aveva parlato durante tutto il viaggio, tirò fuori una voce roca e un alito di finocchiona.
Proseguimmo per alcuni minuti, con le ruote che arrancavano nel fango, poi, finalmente, attraversammo il cancello di ferro battuto e imboccammo la sterrata che portava al piazzale. Ottone diede un colpo di clacson e i cani cominciarono ad abbaiare.
Ricordo l’espressione di mia madre, il sorriso triste e gli occhi in allarme, quando davanti alla porta spuntò la sagoma agile di Elda. Attese lì, sulla porta, mentre Ottone scaricava i bagagli, e gli animali della campagna facevano il concerto di benvenuto. Non ci venne incontro. Io presi la mia valigetta color carta da zucchero e andai verso la donna, anticipando mia madre di un paio di metri.
Elda mi guardò e distese appena il volto rugoso, poi fece un passo e accostò il suo viso al mio, senza baciarmi. Aveva le guance fredde e profumava di sapone di Marsiglia. Poi salutò la mamma, quasi senza parlare.
Questo ricordo, delle persone e delle cose. Man mano che le immagini svaniscono e si perdono i dettagli delle parole e degli incontri. Mi ricordo gli odori. E metto ogni ricordo odoroso in una casella della memoria, che posso aprire e chiudere, quando serve.
Sarà l’ultima cosa che terrò con me, credo, l’odore delle cose.
Elda ci condusse nella nostra stanza, al secondo piano, e ci disse che avremmo cenato alle diciannove in punto, il nonno era abituato così. Poi sparì, come un gatto.
Sui letti, con i materassi alti e duri, erano disposti gli asciugamani. Le lenzuola portavano un ricamo celeste che terminava in una A maiuscola. La mamma mi guardò, con il suo sorriso complice, e cominciammo a disfare le valigie.
La nostra era una camera ad angolo, con due finestre che spartivano l’orizzonte in due scenari, da una parte la valle assolata, dall’altra il profilo frastagliato del bosco. Era fresca, silenziosa, percorsa dall’emozione elettrica dei nostri sguardi, mentre toglievamo gli indumenti dalle valigie e li riponevamo nei cassetti. Su un lato della stanza c’erano due letti di ferro battuto, con dei comodini alti, sugli altri lati uno scrittoio, una poltroncina, il cassettone e l’armadio. Tutti i mobili erano di legno scuro, decorati a intaglio. Il pavimento di cotto era liscio e disegnato a losanghe a forma di rombo.
Quando terminammo di mettere a posto le nostre cose la mamma mi portò in bagno e mi fece lavare dalla testa ai piedi, come quando ero più piccola, poi mise i miei e i suoi abiti in una bacinella e li strofinò con un pezzo di sapone. Aveva indosso una veste rosa, ricamata sugli orli, che le segnava il corpo magro e tornito. Quando terminò di lavare gli abiti scendemmo nell’aia, per stendere i panni.
Il sole del pomeriggio incendiava la valle, l’aria profumava di pioggia e di pini, e i colori segnavano la campagna in milioni di punti nella fioritura delle margherite.
Mia madre aveva i capelli rossi, ma non come i miei.
I miei erano quasi aranciati, i suoi di rame. Era bellissima, è sempre stata molto più bella di me.
Alle diciannove in punto andammo a cena.
2
Mamma si chiamava Sarah MacMahon, suo padre era irlandese, ma lei era nata a Firenze. I nonni materni non li ho mai conosciuti. La nonna faceva l’infermiera, morì poco prima che io nascessi, per un’infezione polmonare, il nonno era morto vent’anni prima, in guerra, era un ufficiale dell’esercito britannico.
Mio padre si chiamava Arturo Soderini. E io sono rimasta sempre Miranda Soderini, come lui, come il nonno. Non mi sono mai sposata.
Adesso mi sembra tutto schiacciato, la memoria delle cose vissute, le immagini suscitate dai racconti altrui. Le vite degli altri sono impastate alla mia, sembrano diventare una sola, davanti a questa finestra che si affaccia sulla collina. Amo questa città, guardo i muri delle case, le strade, la bellezza di ogni dettaglio. Ho vissuto a Firenze per tanti anni, e ci vivo. Ma ho abitato a lungo a Parigi, che mi manca, in certi pomeriggi invernali. Ho viaggiato, ho viaggiato moltissimo.
L’ingiuria degli anni mi ha tolto lucidità, il senso delle distanze, il passo spedito, perfino il pudore, talvolta. Ma mi ha regalato questo senso lieve di galleggiamento, questo godimento silenzioso della vista e del gusto. Una specie di sospensione, una trance emotiva che mi consente di non cedere più al pianto, ricordando le cose perdute, chi è andato via. E così il senso stesso dello stare al mondo mi pare più leggero, ed effimero, quasi fossimo davvero formiche, viste dall’alto. Formiche.
«Buonasera.»
Il nonno entrò nella sala da pranzo tre minuti dopo le diciannove, la mamma ebbe un piccolo sussulto e si alzò dalla sedia.
«Mi scuso per il ritardo.»
Si avvicinò a lei e le tese la mano. Poi mi guardò, e mi avvicinai anche io. Feci una specie di inchino, quello che ci avevano insegnato le suore quando dovevamo salutare la madre superiora. E lui un cenno col viso, senza mutare espressione. Poi ci sedemmo a tavola.
Mi ricordo nitidamente quella cena silenziosa, ogni passaggio delle posate, il profumo della zuppa, il pane raffermo che mia madre spezzava con un piccolo schiocco. E la luce che entrava dalle finestre del soggiorno, segnando la parete di un giallo intenso, che sfumò presto nel rosso e poi sparì. Non dicemmo nulla.
Non abbiamo mai detto molto di più di così, a Villa Ada. Mai parlato come si parla nelle altre famiglie, credo. Le giornate in casa erano silenzi che si prolungavano nei suoni della natura, e poi mutavano, in una forma plastica, dando voce alle voci che imparai presto a riconoscere. Gli animali del bosco, ciascuno con un passo e un verso differente, gli uccelli che si levano in volo, quelli che segnano orbite concentriche sopra il passaggio delle prede terrestri, lo strisciare delle serpi, elegante e osceno, e lo spostamento imprevedibile delle lucertole.
L’abitudine all’essenziale. Quella parsimonia delle conversazioni mi ha forse avviata a un ascolto più attento, quasi arcaico, come un richiamo lontano dei sensi primario, che non richiede mediazione. Fare a meno del sale e dello zucchero, assaporare ogni cellula. Sentire.
Non so più dire quanto, di quello che attribuisco a quella stagione, sia il racconto delle cose accadute. Ma sono certa di quella sensazione, che si ripropone adesso, intatta, mentre scrivo.
C’è come un intoppo nel fluire del mio essere, dopo quell’estate, qualcosa che non somiglia più a quella luce. Ma quella sensazione è la carezza di un’onda, una tregua indescrivibile, una sospensione.
E io vorrei restare così, sospesa.
Quando finimmo di cenare ognuno si ritirò nella sua stanza, mentre Elda rigovernava nella cucina semibuia. Salendo le scale sentivo arrivare i suoni delle posate nell’acquaio, lo strofinio delle stoviglie. Ma nessuna voce.
Il nonno era misteriosamente scomparso nell’ala proibita della casa, quella in cui c’erano le stanze per il lavoro, il suo studio.
Ritornammo nella nostra camera, in casa era sceso il freddo delle colline quando fa buio. Misi la camicia da notte di mussola bianca che mamma mi aveva preparato sul letto, e andai a lavarmi i denti col bicarbonato. Poi feci la pipì e tornai a letto. Ma non mi addormentai subito.
Restai a guardare nella penombra, senza fiatare, mentre mamma leggeva un libro alla luce incerta dell’abat-jour. Di tanto in tanto si girava dalla mia parte e mi sussurrava qualcosa.
Nella penombra riconobbi le linee d’argento che incorniciavano gli affreschi della volta, e i fiori pallidi che c’erano intorno, e le foglie più scure. E tutte le piccole crepe che ramificavano, segnando il cielo di lampi immobili.
Poi mi addormentai, credo. Sognai mio padre, credo.
Galoppava nei campi e arrivava sorridendo.
E io, non so perché, piangevo.
A volte penso che la mia vita non esiste, adesso.
Mi sembra che tutto sia avvolto nel silenzio di questa casa. Sono seduta su una poltrona di pelle, ormai consumata, proprio accanto alla libreria. Il mobile corre lungo la parete e nella penombra sembra animarsi di piccole voci. La luce della lampada taglia uno spicchio di stanza in cui io sono ammessa e lo divide dal buio.
Io sollevo gli occhi dal libro, o dal quaderno, o da un rammendo che mi fa sentire viva e guardo proprio lì, nel buio.
Uso la mia solitudine con il metodo paziente di chi non ha più fretta. Mi concentro sui gesti, sulle parole pronunciate a mezza voce, sui suoni della strada. A volte mi sento sopraffatta dal senso di esserci, dal sentirmi terrestre e presente, con le radici che affondano in una vita infinita. Altre mi sento invasa da una leggerezza strana, che mi fa sorridere dei dettagli, della mia espressione ilare, come una vecchia pazza che si guarda allo specchio.
Forse lo sono, una vecchia pazza che si guarda allo specchio.
Quanti anni sono passati? Quante volte ho percorso le stesse scale, gli stessi gradini, pensando qualcosa di futile nelle giornate uguali, comuni, noiose. Non lo ricordo più. Mi sembra di non riuscire a seguire un pensiero fino in fondo, si interrompe, scarta di lato, perde i suoni e le parole, muta, fino a quando mi sorprendo a non pensarlo più, quel pensiero. Non esiste.
Sulla libreria c’è uno scaffale più ampio, in basso. Sopra c’è una cassetta dove conservo le mie lettere di bambina, e di ragazza. Le lettere di quegli anni. E un quaderno delle minute. Tutte le minute delle lettere spedite a mio padre, da quell’estate in poi.
3
Devo aver dormito a lungo, la prima notte. Mi svegliai col sole alto che invadeva la stanza.
Mi misi seduta e lasciai penzolare le gambe dal letto, sullo specchio dell’armadio vidi le mie gambe secche moltiplicate per due.
Scesi le scale a piedi nudi. Il pavimento era gelato, fuori era caldo. Mi affacciai in cucina, sul tavolo di marmo c’era una tazza di latte bollente e su un piattino una fetta di pane col burro, e un barattolo di marmellata scura. Dalla tazza saliva una linea di fumo.
Mamma faceva sempre bollire il latte in un bollitore di alluminio, anche d’estate. Quando lo versava nelle tazze, dopo la cottura, si formava una panna gialla, grassa e densa. A me la panna faceva schifo, la pescavo sempre col cucchiaino e la mettevo sul piatto.
Salii in ginocchio su una sedia e addentai la fetta di pane imburrato, poi presi un cucchiaio di marmellata e lo misi in bocca senza spalmarla. Era confettura di more, scura e dolcissima.
Quando finii di fare colazione spostai la sedia e mi affacciai alla finestra che dava sull’aia. La luce netta di giugno disegnava l’orizzonte, distinguendo i profili del bosco e della vallata. C’era quel silenzio animato che avrei imparato a conoscere, gli insetti galleggiavano indaffarati gravitando sulle corolle delle margherite.
«Miranda!»
Mia madre spuntò fuori dal viale alberato, scesi dalla sedia, e la raggiunsi. Portava un paio di pantaloni a quadretti, alti in vita e corti sulle caviglie, e una camicia avorio, la stessa che indossa in una fotografia che conservo da sempre. In quella foto sorride, proprio come allora. Aveva le guance arrossate, per il fresco del mattino, le addolcivano la carnagione chiarissima.
«Che ci fai ancora in camicia da notte, dormigliona?»
«…ho fatto colazione.»
«Forza… sbrigati, la campagna è bellissima. Tra poco farà troppo caldo. Io ho già esplorato i dintorni.»
«E io?»
«E tu dormivi.»
«Anche io voglio esplorare i dintorni.»
«Va bene, voglio farti vedere un posto magico. Prima però ti lavi e ti vesti.»
«Evviva.»
Ero una bambina felice e ignara. Anche mia madre aveva abbandonato l’espressione obliqua del giorno prima. Sembrava felice anche lei.
Dopo essermi lavata e vestita, scesi di nuovo nell’aia e la raggiunsi. Prima che ci incamminassimo, intravidi Elda che stendeva i panni sul retro della cascina, su uno stenditoio che correva lungo la fiancata dell’ovile. Le lenzuola e i panni, candidi, sventolavano nella brezza lieve di giugno.
«Mamma…»
«Dimmi.»
«Perché non parla mai?»
«Chi?»
«Elda, perché non parla?»
Mamma rimase in silenzio qualche istante, poi riprese.
«Ognuno ha il suo carattere.»
«Che vuol dire?»
«Si vede che non le piace parlare.»
Attraversammo il cancello con i cardini cigolanti e ci incamminammo sulla strada che costeggiava la foresta. La luce colpiva gli alberi moltiplicandosi sulle foglie minuscole dei cerri. Mi sembrava di vedere luccicare, tra le foglie, gli occhi neri delle bestioline in attesa.
Camminando lungo quel sentiero, sin dal primo giorno, ebbi la sensazione che il mondo fosse diviso in due. C’era il bosco alla nostra destra e i suoni misteriosi che lo popolavano, sulla sinistra invece si stendeva la vallata, nei colori accesi che sembravano bilanciare il mistero. Mi sentivo in bilico, in quel mondo vegetale, come colpita da improvvise premonizioni, e convocata dalle voci misteriose che sussurravano il mio nome. Mamma mi teneva la mano, e io la stringevo ogni volta che sentivo una voce.
«Allora Danda… che facciamo? Parliamo o stiamo zitte?»
«Parliamo…»
«Di cosa vuoi parlare?»
«Non lo so…»
«Vuoi che ti racconti una storia?»
«Sì.»
I racconti di mia madre erano una miscela di fiabe irlandesi, che aveva ascoltato da bambina, e di invenzioni estemporanee. Io ero a mio agio nei castelli incantati, nelle brughiere, nelle lande desolate dove la voce si increspava appena davanti al pericolo improvviso, mi facevano paura, ma ne ero irresistibilmente attratta. Il bosco magico era abitato dal piccolo popolo dei folletti, dai leprecani che fabbricavano scarpe per attraversare gli anelli del tempo, dai giganti dalla barba di pietra nascosti nelle pareti rocciose e dalle sirene dei laghi con il cappello rosso a tre punte. Avevamo un tacito accordo, mia madre e io. Io fingevo di credere ancora alle fate, lei
fingeva di credere che io ci credessi. A gennaio avevo compiuto dieci anni, non ero più una bambina.
«Sai come si chiama questo posto?»
«Come?»
«La Foresta delle Creature Parlanti.»
«Perché si chiama così?»
«Be’, pare che in questa foresta abbiano tutti una gran voglia di chiacchierare.»
Alla nostra destra si aprì un sentiero che si inoltrava nella vegetazione più fitta, mamma mi guardò sorridendo e io le feci un cenno con la testa. Entrammo.
Lo percorremmo per qualche centinaio di metri, e poi scartammo di nuovo a destra. C’era un corridoio stretto e lungo circondato da piante rampicanti che facevano la volta sopra le nostre teste. Mamma mi spiegò che quella era una delle vie di accesso alla Foresta, superata una certa soglia che prima o poi avremmo incontrato, saremmo entrate nel posto dove gli animali parlano.
«Ma parlano solo se tu sei degna di poterli ascoltare.»
«E come si capisce se sono degna oppure no?»
«Io questo non lo so.»
Il nostro rito prevedeva a questo punto uno stupore crescente da parte mia e una nota nella voce di mamma che introduceva alla parte più misteriosa. Io non lo so se non ero più una bambina, non so se avevo voglia davvero di credere ancora a quelle storie. Ero come in bilico, tra due mondi, tra due vite. Come quell’estate del resto, era in bilico tra due vite.
«Gli animali ti parlano solo se hanno da dirti qualcosa di importante.»
«Tipo? Cosa?»
«Non lo so. Immagina una cosa particolarmente importante che vorresti ascoltare…»
Rimasi qualche istante in silenzio, poi mi venne in mente.
«Papà… quando ritorna papà. Potrebbero dirmi questo, no?»
Mamma smise di sorridere, ma solo per un secondo, poi mi guardò e mi accarezzò il viso. Mi disse che non era necessario aspettare che fossero gli animali a dirmelo. Lo avrei saputo da lei.
Uscimmo dal tunnel di rampicanti e ci ritrovammo in una radura circolare, gli alberi intorno erano molto alti, quasi oscuravano il cielo. Tutto lì era più verde che altrove.
La luce guizzava in proiettili sottili che si infilavano nell’erba umida facendola scintillare. E le piccole gocce restavano immobili sui fili verdi, come microscopiche biglie trasparenti.
«È bello vero?»
«Sì…»
«Ci sono già passata questa mattina…»
«Hai sentito le voci?»
«Ho sentito freddo. È strano vero? Faceva quasi freddo, qui dentro.»
«Le hai sentite?»
«…no, credo di no.»
In quel momento mi accorsi che la luce toccava una piccola porzione di tronco e la faceva splendere. Un grumo di resina lampeggiava nei toni dell’ambra e dello smeraldo. Mi avvicinai e lo osservai da vicino. Una fila di formiche risalivano la corteccia in fila indiana, avendo cura di non restare intrappolate nella colla aromatica. Il profumo era intenso, da vicino mi stordiva un po’.
Mamma mi disse di fare attenzione al vestito, e io mi allontanai dal tronco. Poi mi raccontò come si formava la resina e perché.
«Immagina la corteccia di un albero come fosse la pelle di una gamba o di un braccio. Quando cadi e ti scortichi la pelle, esce il sangue. Poi il sangue si cicatrizza e lentamente la pelle si ricompone.»
«Quindi la resina è come il sangue?»
«Non esattamente.»
Il tronco era composto di strati successivi, ognuno di questi aveva la sua funzione. In particolare ce n’era uno, subito sotto la corteccia, molto importante. Si chiamava libro. Trasportava la linfa dalle foglie e nutriva tutto l’albero. La corteccia teneva gli strati vitali del tronco al riparo dalle temperature, dai parassiti e dagli insetti.
«E quando la corteccia è danneggiata, interviene la resina.»
«Per proteggere il libro?»
«Sì, per proteggere il libro.»
Nella mente fertile di bambina questa immagine rimase impressa, immediatamente. La metafora involontaria, nascosta nel nome delle cose, mi disse qualcosa che lentamente si strutturò, divenne una certezza inconsapevole. La resina serviva a proteggere i libri.
Ci fermammo ancora qualche minuto nella radura, poi riprendemmo la passeggiata. Dopo una buona mezz’ora arrivammo al ruscello, sulle cui sponde crescevano garofani selvatici e un’erba alta e gialla. Sentivo l’eccitazione crescere per quel mondo selvatico che ci avvolgeva.
Mi avvicinai al piccolo corso d’acqua e mi inginocchiai. I ciottoli sul fondo erano chiazzati dai riflessi argentini e pesci minuscoli si muovevano come saette, si fermavano di colpo e ripartivano. Dopo qualche insistenza, mamma mi permise di immergere un piede nell’acqua.
Una tenaglia gelida mi agganciò le caviglie e i polpacci, e quasi mi immobilizzò. Mia madre scoppiò a ridere e io quasi a piangere, per la sorpresa.
«Allora Danda, l’acqua dei ruscelli è sempre fredda, ricordatelo. Anche d’estate.»
«…»
«E non fare quella faccia… che sei grande ormai, bambina. Tieni, sciacquati il viso e asciugati con questo.»
Mamma mi offrì il suo fazzoletto ricamato. Profumava di mughetto, come i sacchettini di cotone che teneva nei cassetti della biancheria. Poi si rimise in piedi e si guardò intorno.
«The pretty people in the Woods, receive me cordially, the Brooks laugh louder when I come.»
«…»
«Il grazioso popolo dei boschi, mi riceve cordialmente, i ruscelli ridono più forte quando arrivo.»
«Che vuol dire?»
«È una poesia, di una poetessa americana. Si chiama Emily Dickinson. Vuol dire proprio quello che dice. Il popolo dei boschi, cioè la natura, gli alberi, gli animali, ci ricevono cordialmente. Come adesso. E i ruscelli ridono, quando ci avviciniamo.»
«Ridono…»
«Ascolta bene. Lo senti? Il ruscello ride.»
«Ride perché sono una stupida, e ho avuto paura…»
«No… ride perché è felice di vederti.»
Tornammo a casa. Camminammo ancora un po’ fuori dal sentiero battuto, poi rientrammo sulla strada principale. Sulla mia gonna si erano formate perle d’umido, avevo le scarpe inzaccherate dal terreno ancora molle.
Sui campi, in lontananza, cinque vacche enormi pascolavano e dimenavano la coda sottile. Faceva caldo. Io ero felice…
Francesco Carofiglio, scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre a L’estate del cane nero, Ritorno nella valle degli angeli e Radiopirata (tutti usciti per Marsilio), ha pubblicato per BUR il romanzo With or without you e per Rizzoli, in coppia con il fratello Gianrico, nel 2007 la graphic novel Cacciatori nelle tenebre e nel 2014 La casa nel bosco. Per Piemme ha scritto Wok (2013), Voglio vivere una volta sola(2014), Una specie di felicità (2016), Il Maestro (2017), e nella collana Il Battello a Vapore Jonas e il Mondo Nero (2018), ottenendo sempre un grande successo di pubblico e di critica.